1) L’EMERGENZA MEDIATICA DEI ‘FEMMINICIDI’
È sempre un piacere leggere Michele Serra, ma il suo articolo sui ‘femminicidi’ mi trova per una volta in disaccordo sul punto centrale del suo argomento.
Per Serra alla base dei cosiddetti ‘femminicidi’ ci sarebbe un tratto ideale-culturale, ovvero la mancata consapevolezza dell’indipendenza della donna, il mancato rispetto per tale autonomia.
Questa è in effetti la lettura mainstream del fenomeno, ma non mi pare che si tratti di una lettura plausibile, o quantomeno non mi pare sia una lettura che colga aspetti davvero centrali del fenomeno.
Non credo che al violento-prevaricatore in questione manchi la consapevolezza che alla donna oggi siano riconosciute un’autonomia ed una dignità indipendenti, legittimate dal giudizio sociale e dalle leggi. Non credo che alla radice di questi atti, spesso di una barbarie allucinante, ci sia l’idea di una superiorità dell’uomo che debba imporsi ad una inferiorità, dipendenza, o mancanza di dignità della donna. Questa mi pare una lettura fortemente permeata di una vena ideologica che sa già dove vuole arrivare, ed è a mio avviso proprio tale vena ideologica a creare il ‘caso’ mediatico dei femminicidi.
Data per scontata la gravità ed abiezione di queste vicende, uno sguardo d’insieme del fenomeno ci consegna probabilmente una prospettiva molto meno emergenziale. In Italia i femminicidi sono circa 120 all’anno, dunque uno ogni 3 giorni. Gli omicidi per anno nel loro complesso sono intorno a 480, dunque i femminicidi sono perfettamente in linea con quanto una semplice combinatoria di possibilità (uomo vs. donna, uomo vs. uomo, ecc.) farebbe attendere (un quarto circa).
In ogni caso, entrambi i dati sono in calo costante, da decenni.
Ma naturalmente se ogni femminicidio sul territorio nazionale ottiene la prima pagina di giornali e TV, un caso ogni tre giorni è più che sufficiente per montare un clima di allarme ed emergenza.
Molti dei casi di femminicidio si caratterizzano per tratti di particolare efferatezza o di sostanziale inesplicabilità (raptus). In quest’ottica è utile essere consapevoli che, statistiche alla mano, gli psicopatici non solo esistono, ma rappresentano circa l’1% della popolazione, il che sulla popolazione adulta italiana fanno circa 510.000 psicopatici. Ora, su 510.000 i maschi saranno circa 250.000, e questo potrebbe essere interpretato concludendo che ogni 2.500 psicopatici maschi in circolazione sul territorio nazionale, uno di questi all’anno si trasforma in un femminicida. Una lettura del genere, compatibile con tutti i dati a nostra disposizione, rende il fenomeno, per quanto non meno orribile, certo molto meno sconcertante ed inatteso.
Se poi si vanno a vedere un po’ di casi specifici, è molto difficile trovare nel femminicida i tratti del ‘disprezzo’ verso la donna che ci si aspetterebbe di trovare, se davvero la lettura ‘patriarcale’ del fenomeno fosse plausibile. Per lo più i femminicidi si configurano come atti di rabbia disperata, mista a totale mancanza di empatia per la vittima (tratto psicopatico), una rabbia che si radica piuttosto nel sentirsi disprezzati, inferiori, e nel non riuscire a farsene una ragione.
In questo senso il presunto disprezzo ‘patriarcale’ e ‘machista’ nei confronti del femminile non si attaglia a quello che è invece il tratto principale della maggior parte dei ‘femminicidi’: l’estrema fragilità psicologica dell’aggressore, che spesso si trascina a lungo in un’alternanza di preghiere e minacce pur di non perdere la ‘propria donna’. Qui non si vede disprezzo per la donna. Si vede piuttosto un drammatico senso di inferiorità. Il disprezzo non permetterebbe al violento di sentirsi così annichilito dal rifiuto. È piuttosto il disprezzo di sé, la mancanza totale di risorse interiori, di interessi, di dignità e di autonomia propria ad innescare reazioni che spesso implicano il suicidio dopo l’omicidio.
In questo senso mi pare che alla radice dei femminicidi non ci sia una mancata consapevolezza da parte di alcuni maschi dell’avvenuta ‘emancipazione’ femminile. Mi pare si tratti invece piuttosto di un livello abnorme di frustrazione da parte di persone che non sono in grado di camminare con le proprie gambe, di stare al mondo con dignità al venire meno di un sostegno affettivo. Il problema qui è rappresentato da maschi dall’identità effimera e svuotata, incapaci di esistenza autonoma, e che reagiscono in forma di rabbia incontenibile di fronte alla minaccia al loro unico ancoramento alla vita, ad una minaccia che è minaccia alla propria fragilissima identità. Lontani anni luce dal prototipo del maschio patriarcale, che invece si attaglia solo a un’esigua minoranza di casi (es.: il padre conservatore islamico che picchia la figlia, fino ad ucciderla, perché troppo ‘indipendente’).
Se questa analisi è corretta, ricondurre costantemente quegli eventi drammatici, ma statisticamente ordinari, che sono i femminicidi ad una presunta ‘cultura patriarcale prevaricatrice’ del maschio, almeno in contesto italiano ed europeo, è una montatura ideologica. Peraltro, è una montatura ideologica che tende a generare atti di solenne inutilità come il tentativo di introdurre ore obbligatorie di ‘rispetto per la donna’ nelle aule scolastiche.
Se si vuole ridurre il fenomeno, come è aspirazione legittima tentare, ciò non si ottiene certo a colpi di lezioni solenni sulla dignità della donna. Forse qualcosa si può ottenere, piuttosto, preoccupandosi che nelle famiglie i bambini abbiano una formazione umana, affettiva e culturale che dia loro una qualche struttura e sicurezza.
Ma, naturalmente, oggi qualunque iniziativa si metta a sindacare sull’oramai devastante stato delle pedagogie famigliari viene percepito come invasivo e illiberale. Molto meglio, dunque, andare avanti a lacrimucce cicliche e prediche moraleggianti, che lasciano il tempo che trovano, ma producono ottimo infotainment.
2) NOTA DI CHIARIFICAZIONE SUL PATRIARCATO
Cosa significa ‘Patriarcato’?
Prendiamo due definizioni autorevoli.
La prima è quella antropologica in senso stretto: Il patriarcato “è un’organizzazione sociale contraddistinta dalla supremazia del padre nel clan o nella famiglia, dalla dipendenza legale di donne e bambini, e dal riconoscimento della discendenza e dell’eredità nella sola linea maschile.”
La seconda, più estensiva, suona come segue: “Il patriarcato è un sistema sociale in cui i maschi detengono il potere primario e predominano nei ruoli di leadership politica, di autorità morale, di privilegio sociale e di controllo della proprietà. Nell’ambito della famiglia i padri detengono l’autorità sulle donne e sui bambini.”
La prima cosa da sottolineare è che il patriarcato non è un’opinione né una collezione di opinioni, ma un sistema sociale, un sistema sociale in cui il funzionamento della società nelle sue componenti di riproduzione sociale ed economica dipende da un ordinamento gerarchico con quelle caratteristiche.
Perché il patriarcato è stato un sistema sociale così diffuso?
Per una ragione intuitiva. Nella storia dell’umanità i periodi di pace sono rare isole in un continuum di guerre, conflitti o scontri locali di maggiore o minore entità. Rarissime sono state le generazioni che non hanno vissuto una guerra, e al contrario esperire più di un conflitto cruento nell’arco di una medesima vita è stata la norma in quasi tutte le società in quasi tutti i tempi. Questa condizione aveva due implicazioni principali: rendeva il ruolo difensivo dell’uomo spesso precondizione per la stessa permanenza in vita della famiglia, e portava ad una riduzione numerica significativa, causa decessi violenti, del numero di uomini validi presenti nella società. Queste condizioni di rarità comparativa, e di importanza per la sopravvivenza del nucleo famigliare, dei maschi ne accresceva il valore sociale, creando le condizioni di privilegio note sotto il nome di patriarcato.
Con l’ascesa della società borghese capitalistica, a partire dal primo ‘700 inglese, ha luogo una lenta ma progressiva sostituzione assiologica dai valori ‘guerrieri’, intorno a cui erano sorte le antiche aristocrazie, verso valori legati a transazioni economiche pacifiche. Questo mutamento naturalmente non fu improvviso, ed in una prima fase convisse con solidi residui patriarcali, quali quelli che ritroviamo rappresentati e variamente contestati nella letteratura che va da Jane Austen a Henrik Ibsen.
Con il secondo dopoguerra, in Occidente giunge a compimento una riduzione ai minimi termini della vita rurale a favore di quella urbana e industriale, e con tale processo i residui patriarcali recedono al mero rango di occasionali opinioni. Tali residui si manifestano talora soprattutto nelle aree e nei contesti più socialmente deprivati e culturalmente arretrati. Tuttavia, il patriarcato, che come sistema sociale si era già disgregato con l’avvento del sistema di produzione capitalistico, viene a dissolversi anche sul piano culturale. (Elementi patriarcali autentici permangono invece nelle società, non occidentali, che non sono passate attraverso questo processo di urbanizzazione ed industrializzazione.)
Non vi è più “supremazia del padre nella famiglia”, non vi è più il monopolio “del potere, della leadership politica, dell’autorità morale, del privilegio sociale, e del controllo della proprietà” da parte degli uomini.
Tutto ciò è sancito dalle norme di legge ed è rinforzato dai meccanismi del potere economico, dove conta solo essere in grado di esercitare tale potere, chiunque si sia e qualunque sia il genere di chi lo esercita.
Questo significa forse che non esiste più alcuna “questione femminile” nella modernità capitalistica?
No, almeno un’importante “questione femminile” esiste ancora, ma questa volta per ragioni che sono tutte interne al funzionamento dei meccanismi di capitale, e che non hanno più nulla a che fare con quel sistema sociale morto e sepolto che fu il patriarcato.
I problemi che una società capitalistica pongono alla donna sono essenzialmente quelli correlati al suo ruolo di madre (attuale o potenziale). Mentre per altri ruoli tradizionali (cura della casa, cura degli anziani), in presenza di condizioni economiche adeguate, è possibile e legittimo ricorrere a sostituti, nel caso della maternità una sostituzione non può accadere (ed è altamente sconsigliabile accadesse, anche quando divenisse possibile). Nella misura in cui la maternità e, quantomeno, il primo periodo successivo alla nascita, sono affidate alle donne, queste attività si presentano nel meccanismo capitalistico come ‘riduzioni di produttività media’, e possono perciò condizionare sia le prospettive di carriera che i livelli salariali delle donne stesse. Spesso non è neppure necessario che una o più gravidanze abbiano concretamente luogo, giacché la semplice aspettativa di questa possibilità può essere adoperata dai datori di lavoro per esercitare pressione salariale, o per ridurre le aspettative di carriera femminili.
La maternità e l’allevamento primario, che, senza tema di smentita, rappresentano i più importanti snodi nell’autoriproduzione di una società, non ricevono di per sé alcun riconoscimento nella cornice delle relazioni capitalistiche. Appaiono anzi come un ingombro ed un danno. Come spesso osservato, in una cornice capitalistica la vita si presenta essenzialmente come un fastidioso elemento di disturbo nella riproduzione del capitale.
Questo problema può essere affrontato solo con un intervento della collettività (Stato) al di fuori e in contrapposizione ai meccanismi della competizione capitalistica. Nei paesi in cui ciò è stato affrontato efficacemente, in forma di compensazioni economiche ai datori di lavoro e servizi suppletivi alle madri, il problema è scomparso.
Questo problema coinvolge primariamente le donne, ed esiste accanto ad altri problemi (la maggior parte) che coinvolgono equamente donne e uomini (sfruttamento, precarizzazione, pressione competitiva, sradicamento, ecc.) e anche, in verità, a problemi che coinvolgono primariamente gli uomini (insicurezza, repressione dell’aggressività, frustrazione e relative ripercussioni sull’identità maschile).
Chi parla di ‘oppressione patriarcale’ oggi commette un abuso verbale con finalità retoriche; estende cioè, per propri fini polemici e rivendicativi, un uso ben definito del termine ‘patriarcato’ ad un uso vago, artificiale, buono per tutte le occasioni, ed essenzialmente strumentale. Sollevare nel contesto dei problemi sociali odierni il tema del patriarcato è un modo, magari involontario, magari in buona fede, di creare una linea di opposizione largamente fittizia (uomo vs. donna), una linea di opposizione che contribuisce ad alimentare un perenne stato rivendicativo e di ostilità latente tra i sessi. In definitiva, si tratta di una contrapposizione che di fatto cela e ostacola la percezione di quei problemi a tutti noi comuni, generati dai correnti “rapporti sociali di produzione,” e così facendo si dimostra oggettivamente complice dei meccanismi di disgregazione capitalistica.
3) СТАЧКА (STAČKA)
L’8 marzo 2017 i sindacati Usi, Slai Cobas, Cobas, Usb, Sial Cobas, Usi-Ait, Usb, Sgb, Flc e Cgil hanno indetto uno sciopero nazionale pubblico e privato di 24 ore.
Qual era lo scopo dello sciopero?
Per gli organizzatori, testualmente, si trattava di “ribadire il rifiuto della violenza di genere in tutte le sue forme: oppressione, sfruttamento, sessismo, razzismo, omo e transfobia.”
Dunque, fatemi capire, i lavoratori di questo paese si dovrebbero astenere dal lavoro in tutti i settori perché sono contro la violenza di genere?
Interessante.
Ora, a me pare di ricordare che l’istituto dello sciopero avesse una funzione specifica. Il suo significato primario consisteva nell’arrecare un danno al datore di lavoro, in modo da costringerlo – in particolare nel corso di una trattativa – ad una posizione più favorevole agli interessi dei lavoratori.
In seconda istanza, quando il datore di lavoro in questione era lo Stato in quanto fornitore di servizi pubblici, era tollerabile anche l’effetto collaterale dei danni all’utenza, che pur non essendo parte in causa poteva essere chiamata a fare pressione per i diritti dei lavoratori.
In terza istanza, quando la questione rivendicata aveva una portata trasversale a tutti i lavoratori e dunque non era limitata ad un settore o ad una tipologia, era concepibile uno ‘sciopero generale’. In tal caso l’oggetto della rivendicazione doveva essere una richiesta di natura normativa generale (es.: Statuto dei Lavoratori).
Uno sciopero dunque ha un significato quando concerne una piattaforma rivendicativa da ottenere presso una controparte, la quale verrebbe danneggiata dallo sciopero e perciò verrebbe indotta a venire incontro alle relative richieste.
Bene.
E ora, esattamente, quale sarebbe nella fattispecie la piattaforma rivendicativa? Che non vogliamo più femminicidi? Che non vogliamo più violenze sulle donne? Che non vogliamo più “oppressione, sfruttamento, sessismo, razzismo, omo e transfobia”?
Ed esattamente a chi si rivolge questa protesta? Ai gestori delle ferrovie? A quelli delle autolinee pubbliche? Ai presidi della scuole? Ai produttori di ghisa e a quelli di scarpe? Sono loro i responsabili, per omissione o commissione, della violenza? Stiamo cercando di indurre a miti consigli quale controparte? Gentiloni? La Commissione europea?
E con quali specifiche rivendicazioni?
Dire che si è contro una cosa manifestamente pessima come la violenza sulle donne non è il contenuto di nessuna rivendicazione.
E’ una dichiarazione di valori, valori su cui peraltro non ho mai sentito una voce contraria.
Ma se è così, nello stesso modo potremmo manifestare contro la fame nel mondo, il riscaldamento globale, le malattie rare, e l’inquinamento atmosferico a Shangai.
Tutte cause degnissime e giustissime, ma cose per cui, eventualmente, si fa forse una manifestazione, forse una raccolta fondi, ma certo non uno sciopero.
Qui non c’è una controparte cui chiedere qualcosa e non c’è niente di specifico che viene chiesto, dunque questo non può essere sensatamente l’oggetto di uno sciopero, se le parole e gli atti hanno un senso.
L’impressione è che la disperata ricerca dei sindacati europei di una qualche battaglia per segnalare la propria esistenza in vita si appigli tristemente a generiche “battaglie civili”, buone per una copertina patinata e qualche servizio TV.
4) NEGAZIONISTA
Oggi, dopo una discussione FB sulle “colpe del patriarcato” e i “meriti del femminismo”, in cui ho cercato di esercitare (giuro) il massimo di obiettività, documentazione ed autocontrollo, nel thread mi sono ritrovato oggetto del seguente commento tra due amabili signore: “Ma XXX [nome proprio femminile], tu pensi che valga la pena di perdere tempo con un negazionista come questo?” (sic) – Segue pronto consenso dell’interlocutrice.
“Negazionista”
Avevo la tentazione di chiedere lumi, ma poi ho pensato che no, non volevo davvero sentire da quale ennesima distorsione linguistica e mentale un termine nato per definire chi negava lo sterminio degli ebrei nella Shoah sia potuto divenire un’etichetta per chi nega “l’oppressione contemporanea del Patriarcato”.
Non lo voglio sapere, perché ad un certo punto impari a riconoscere quando non hai più a che fare con persone recuperabili ad un ragionamento comune, bensì con gli appartenenti a qualcosa di simile ad una setta.
5) BREVE RIFLESSIONE SUL ‘POLITICAMENTE CORRETTO’
In una precedente discussione un amico ha stigmatizzato il mio uso contestuale dell’espressione “spacciatori marocchini” (nella frase: “Che poi a violare la legge e spadroneggiare siano spacciatori marocchini o italianissimi mafiosi non è che questo faccia molta differenza”). La contestazione era dovuta al fatto che stavo associando un reato ad un’etnia e che ciò potrebbe produrre stereotipi pericolosi.
Provo qui sotto a rispondere all’obiezione in termini di generale applicazione.
Io capisco bene l’argomento in questione, ne conosco l’origine storica, le presunte basi semantiche, la collocazione politica, ecc.
Lo comprendo, ma non lo condivido.
Ho usato quell’espressione consapevolmente, con una specifica finalità espressiva (mettendo in contrasto una forma di delinquenza straniera con una italiana), e nominando un’etnia non a caso ma su base empirica (conoscenza di aree urbane specifiche dove lo spaccio è monopolio di quel gruppo etnico).
Non ho detto che “tutti i marocchini sono spacciatori”, non ho detto che “tutti gli spacciatori sono marocchini”, né ho stigmatizzato i nordafricani, gli extracomunitari, o niente di simile. Avrei potuto in altro contesto, se fosse stato utile sul piano espressivo, parlare di badanti ucraine, borseggiatrici zingare, profughi siriani, mafiosi siciliani, ecc.
Ora, se qualcuno vuole trarre conclusioni in cui si generalizza a vanvera e si attribuisce un certo ruolo negativo ad una certa etnia in quanto tale, bene. Se ne assume l’onere e la responsabilità; non me la assumo certo io al posto suo.
L’argomento sollevato, quello di evitare potenziali stereotipizzazioni negative, è quello che ha fondato l’abuso della political correctness negli ultimi due decenni. Si tratta di un argomento che pensa di evitare la sostanza di certi giudizi, di certe stigmatizzazioni, e anche di certi pregiudizi, omettendo di usare certe parole. Il punto cioè non sarebbe astenersi dall’usare quelle parole in modo falso o inadeguato (che è sacrosanto), ma proprio di evitare la creazione di associazioni mentali di un tipo che si presuppone essere noto ed indesiderabile.
Ecco, questa è una concezione comportamentistica, pavloviana, e francamente fallimentare del discorso politico, perché le persone quando sanno che una certa cosa “non-si-può-dire-perché-non-sta-bene” finiscono per dare a quella associazione mentale che si voleva mettere sotto il tappeto persino più credito di prima. La parole ricevono il loro significato dalle pratiche sociali e dai discorsi condivisi, e quelle pratiche e quei discorsi non spariscono per aver messo sotto il tappeto qualche parolina sgradita. Questa è un’illusione teorica coltivata da quella genia filosofica che negli ultimi cinquant’anni ha pensato che non vi fosse alcun mondo significativo al di fuori dei testi e delle loro parole.
Il Presidente Donald Trump, nel paese che ha fatto del ‘politically correct’ la sua sussiegosa bandiera (persino con legislazione penale a proposito), è là a ricordarci quanto clamorosamente sterile sul piano politico sia quella concezione.
Un conto è evitare volgarità gratuite, o parimenti preservare il rispetto per l’interlocutore; tutte cose spesso confuse con il ‘politically correct’, ma che hanno un senso diverso e sacrosanto. Tutt’altro conto invece è pensare che si eviteranno “pensieri cattivi” rimuovendo artificialmente parole o espressioni che potrebbero aiutare quelle associazioni. Questo è un modo di impostare la questione fondamentalmente sbagliata. Le cose, quando non siano falsità, si devono sempre dire, dando l’occasione con ciò a chi lo ritiene di contestarle, di limitarne la portata, di precisarle.
Dunque ci sta che uno mi dica, ad esempio, ‘guarda che non tutti gli spacciatori sono marocchini’, a cui posso replicare specificando cosa intendevo. Trovo invece del tutto sciocco e controproducente adottare censure preventive, pensando che così facendo avrei fatto qualcosa di politicamente pregevole, o persino raccomandabile.
No, ho semplicemente fatto un giochino culturale per una minoranza di benpensanti, giochino che dà l’impressione di aver fatto politica, mentre ha semplicemente contribuito, sia pure in buona fede, ad intorbidire le acque.
6) LEGALIZZARE LA MATERNITA’ SURROGATA?
Commento a “Legalizzare la surrogata: perché sì”, di Cinzia Sciuto Scenari / LEGALIZZARE LA SURROGATA: PERCHÉ SÌ.
Le argomentazioni di Cinzia Sciuto sono ragionevoli e per me condivisibili in molte parti. Mentirei però se dicessi di esserne del tutto convinto.
Innanzitutto: legalizzare significa regolamentare, come giustamente l’autrice ricorda, ma regolamentare significa anche consentire certi comportamenti e vietarne altri. La regolamentazione della surrogata per me può essere accettabile proprio perché consente di stabilire alcune situazioni in cui l’operazione di surroga potrebbe essere sensata (e ne ho alcune, per quanto rare, in mente) e consente altrettanto di stabilire che altre forme di surroga non possano essere accettate. Questo significa che la componente di divieto sarebbe comunque presente in una regolamentazione, e che dunque rimarrà sempre aperta la possibilità di chi abbia i mezzi per aggirare la norma di farlo.
In questo senso mi interessa in primo luogo sottolineare che la possibilità di aggirare la legge da parte di benestanti spregiudicati non rappresenta affatto un buon argomento a favore di una legalizzazione della pratica. Sarebbe un po’ come dire che siccome ci sono i paradisi fiscali questo è un argomento per legalizzare l’evasione. Si può vietare un comportamento anche se altrove esso è consentito, e se altri decideranno di giovarsi di quella opzione altrove, beh, se ne assumeranno la responsabilità e verranno giudicati di conseguenza.
In seconda battuta c’è un’ulteriore obiezione che mi sentirei di sollevare. L’autrice liquida in modo a mio avviso sbrigativo, e poggiando su di un argomento fallace, la questione della ‘mercificazione’ della donna (e del bambino). L’autrice usa infatti il frequente argomento liberale “chi sono io a giudicare”, argomento che se preso sul serio conduce diritto diritto all’annullamento di ogni qualsivoglia norma, giacché in ogni norma si prende posizione rispetto a reazioni altrui considerate tipiche e vissuti personali ritenuti probabili. Dopo tutto, se l’argomento è “chi sono io a giudicare?”, allora possiamo serenamente reintrodurre la validità legale della schiavitù per debiti: infatti “chi sono io per giudicare” se chi non decida di vendersi come schiavo non lo faccia perché lo ritiene vantaggioso o persino piacevole?
Ora, che la maternità surrogata non sia necessariamente e sempre ‘mercificazione’ è vero. Ci sono casi in cui una sorella si è prestata al ruolo per aiutare una donna sterile ad avere un figlio, senza che ciò coinvolgesse passaggi di denaro. Ma che mercificazione dei corpi qui ci possa essere, ed anzi che spesso sia accertato esserci, è fuori di dubbio. E qui sarebbe davvero utile conoscere l’opinione dell’autrice sulla legittimità o meno dell’introduzione della maternità tra le pratiche commercializzabili. Per quanto mi riguarda l’introduzione della maternità tra i servizi comprabili e vendibili sul mercato è e rimane inaccettabile, moralmente e legalmente.
7) MATERNITA’ SURROGATA
Recentemente Nichi Vendola e il suo compagno sono ricorsi alla maternità surrogata all’estero per avere un bambino.
Ora, personalmente spero di cuore che il neonato che gli verrà affidato abbia vita prospera e felice. E non mi permetto di censurare questa vicenda come fatto privato. Come tutte le vicende personali, essa avrà avuto una sua maturazione emotiva complessa, che dal di fuori non si può che ignorare.
Se però essa si propone come caso di valore esemplare e politico, allora alcune considerazioni sono necessarie.
Per cominciare: cosa faranno ora Nichi e il suo compagno? Preleveranno senz’altro il neonato appena partorito e se ne andranno, un po’ come si ritira un’auto da una concessionaria? Ma questo sarebbe un comportamento piuttosto discutibile. I primi tre mesi della vita di un infante sono spesso considerati una vera e propria prosecuzione della gravidanza intrauterina (si parla di ‘esogestazione’). Questo è il periodo in cui si formano gli anticorpi in allattamento, la flora batterica intestinale, ed è anche il momento in cui il trauma della nascita viene mitigato con la costituzione dell’attaccamento primario. La continuità tra percezioni intrauterine (battito cardiaco della madre, sua voce, ecc.) e primi momenti di adattamento al mondo è accertata (il neonato riconosce quei suoni, che lo tranquillizzano). Cosa comporti rompere quella continuità non è chiaro e per quel poco che se ne sa, come relativamente alla rottura dell’attaccamento primario, sembra senz’altro negativo.
Ma forse che allora la nostra coppia potrebbe decidere di lasciare il bimbo per tre mesi alla madre naturale, portandolo via in seguito? Ma questo significherebbe solo a maggior ragione rompere i legami di attaccamento bilaterale tra madre e figlio, a quel punto ancora più solidi.
Se guardiamo al lato della madre ci troviamo di fronte ad un distacco potenzialmente crudele. E sono già accaduti casi in cui la madre naturale, pur avendo sottoscritto un obbligo legalmente vincolante di cedere il bambino, non se ne sia poi riuscita a staccare. In tal caso cosa faranno i nostri amici? Chiederanno ad un giudice californiano di far valere il contratto, sottoscritto a fronte di un’erogazione di denaro, e chiederanno dunque l’intervento coattivo delle forze dell’ordine? Un comportamento del genere temo si attaglierebbe più allo Shylock del “Mercante di Venezia” che all’umanesimo marxiano.
A questo quadro va aggiunto che, comunque, la crescita di un infante da parte di due genitori maschi è una situazione piuttosto inedita. Esiste infatti un’asimmetria di genere, asimmetria che può dispiacere alla nostra cultura dei diritti simmetrici, ma che va ricordata. Nella storia umana i casi di bambini allevati da sole donne sono tutt’altro che rari. E checché se ne dica, qualcosa come l’istinto materno femminile esiste e, ancorché non infallibile, esso rappresenta un puntello importante nelle mille difficoltà che crescere un neonato comporta. Al contrario, di situazioni in cui neonati siano allevati da maschi adulti la storia è avara, e dunque di garanzie di non disfunzionalità siamo quasi privi. Esiste sì una recente letteratura scientifica, che però non distingue tra bambini cresciuti in coppie omosessuali maschili e femminili, né tra bambini così cresciuti dalla nascita o solo da un’età più avanzata; si tratta inoltre di documentazione spesso elaborata da persone già fortemente interessate a stabilire certe tesi, con fortissimi confirmation bias, e dunque diversamente da altri campi, qui l’appello ai nudi dati statistici risulta decisamente poco garantito.
Naturalmente, la specie umana è resistente, dotata di capacità di recupero e adattamento, dunque è ben possibile che un neonato trovi nuovi equilibri armonici. Il problema tuttavia non sta nel dover negare la possibilità che tutto vada per il meglio, il problema è di non esserne neanche lontanamente sicuri. Dunque qui il dovere, morale prima che legale, della migliore tutela possibile per l’infanzia non è stato rispettato. E non è stato rispettato perché invece che ad esso, è stato dato priorità al desiderio soggettivo di paternità dei nostri amici.
A proposito di questo tipo di obiezioni si incontra spesso un’obiezione che suona come segue: “Ma, dopo tutto, perché soffermarsi sugli eventuali problemi generati da una maternità surrogata, o dall’allevamento da parte di una coppia omosessuale, visto che anche normalissime coppie eterosessuali presentano spesso gravi disfunzionalità nell’allevamento e nell’educazione dei propri figli naturali?”
Ecco, questo argomento, per quanto molto diffuso, è completamente privo di senso.
Infatti, l’argomento sembra sottintendere che gli eventuali problemi di una maternità surrogata o dell’omogenitorialità siano da contrapporre a quelli delle famiglie ordinarie, come se fossero un’opzione alternativa, con problemi separati. Ma questo è assurdo, perché ciò che ci si può aspettare ragionevolmente è solo che i problemi, eventualmente, si sommino.
Non c’è dubbio che le difficoltà della vita o del lavoro, le fragilità psicologiche individuali e le insufficienze morali di molti genitori eterosessuali creino le condizioni per processi educativi gravemente disfunzionali in numerose famiglie. Solo che non c’è una ragione al mondo per credere che le stesse difficoltà, fragilità ed insufficienze non si presenteranno in simile percentuale anche nelle coppie omosessuali. E a quei problemi semplicemente ci dobbiamo aspettare che si sommeranno gli eventuali ulteriori problemi connessi a maternità surrogata e omogenitorialità.
Naturalmente, può darsi senz’altro che vada tutto benissimo, e che tutti i possibili problemi adombrati risultino superabili o in definitiva trascurabili. Ma il problema qui è chi deve dimostrarlo. E, nella fattispecie, tra 200.000 anni di prove ed errori nella storia naturale e la rivendicazione contingente di diritti individuali mi pare del tutto chiaro chi debba avere l’onere della prova.
| 8) ANCORA SULLA MATERNITA’ SURROGATA
Risposta all’articolo: http://mimesis-scenari.it/2016/03/17/uomini-che-parlano-di-donne-il-triste-caso-della-maternita-surrogata/ L’articolo in questione, mi spiace dirlo, è retorico, incompleto e, dove argomenta, erroneo. Ma veniamo alle argomentazioni che vengono di fatto sollevate. Al netto di molta retorica e di varie insinuazioni, sono sostanzialmente le seguenti: Ci sarebbe una pericolosa critica alla surrogacy da sinistra, che denuncerebbe l’idea di cedere l’uso del proprio corpo per denaro, in quanto ciò può configurare sfruttamento. a) le donne sono soggetti politici autonomi, dotati di libera scelta; Il resto del testo non introduce argomentazioni, ma insinuazioni, come quella per cui chi ha criticato la scelta di Nichi Vendola sarebbe un omofobo, più o meno camuffato, oppure profluvi di retorica riccamente aggettivata (“il piacere fallico di vedere nella donna unicamente un soggetto debole da difendere dolcemente, proprio come un pastore accarezza le proprie pecore mentre le fa rientrare nel recinto per la notte”; “nauseante pretesa di poter avere un diritto di veto sui corpi altrui”; “sedicenti difensori dei diritti degli oppressi, nella loro stucchevole critica della maternità surrogata”, ecc.). E via poetando. Concentriamoci sulle obiezioni argomentate. Nel caso della maternità surrogata l’autore non distingue, come invece avrebbe dovuto attentamente fare, tra maternità surrogata offerta a titolo gratuito (ad esempio da una sorella), per la quale non ci sono possibili obiezioni legate allo sfruttamento, e maternità offerta dietro compenso economico da parte di estranei. Per inciso, le obiezioni intorno alla mercificazione dei corpi e delle relazioni non si limitano ai casi palesi di sfruttamento economico. L’idea stessa di trattare la maternità come un servizio commerciale tra gli altri, alla stregua di un cambio d’olio, ha qualcosa di estremo ed inumano, che bisogna essere veramente acciecati dalla retorica liberale dei diritti soggettivi per non vedere. Quanto al ‘paternalismo’ l’autore sembra ignorare che la stragrande maggioranza delle decisioni politiche nelle democrazie sono decisioni in cui ci si pone il problema di come migliorare le condizioni di terzi individui ignoti, cioè decisioni ‘paternalistiche’. In queste ore tutti i paesi europei stanno discutendo del problema dei profughi, che hanno lasciato i loro paesi in condizioni di necessità. Naturalmente lo fanno al posto dei profughi. In che senso l’autore suggerirebbe di adottare una politica ‘non-paternalistica’, che attribuisca libera responsabilità ai profughi e ai cittadini degli stati di destinazione? Pensa che la soluzione ‘non-paternalistica’ sia lasciare la strada ad una ‘contrattazione’ anarchica su base locale tra cittadini e profughi, senza mediazione dello stato? Ha pensato alle conseguenze anche solo per un minuto? Veniamo all’ultima obiezione. L’autore tira fuori dal cilindro il vecchio argomento per cui gli uomini non potrebbero parlare a nome delle donne perché non esperiscono in prima persona la gravidanza. Splendido argomento. Il principio dunque sarebbe che si è legittimati a parlare solo di ciò che si è esperito in prima persona. Dunque non potrei legittimamente sostenere una legge contro la tortura, perché io esperisco solo il mio dolore, non quello altrui, dunque che ne so? Magari agli altri piace essere torturati. E non posso sostenere una norma a sostegno del reddito o contro la povertà, la fame, gli stupri, ecc. perché che ne so io di cosa prova qualcuno che sta morendo di fame, o che subisce uno stupro, ecc.? Di più. In verità, neppure una donna potrebbe parlare di ciò che provano le donne in generale, perché non c’è proprio nessuna garanzia che una donna provi precisamente ciò che prova un’altra donna, con riferimento alla gravidanza, o ad uno stupro o altro. In effetti l’esito ultimo di questi ragionamenti liberal-individualisti è sempre il solito: l’unica entità politica dev’essere l’individuo e l’unica relazione politica generativa è il suo potere contrattuale nei confronti degli altri individui. E su tutto il resto bisogna tacere. Solo che nessuna comunità umana sarebbe sopravvissuta una stagione adottando davvero questi principi. |
9) NOTA A MARGINE SULLA MATERNITA’ SURROGATA
I problemi legati alla maternità surrogata non riguardano un singolo dettaglio, tipo: se o quanto sia traumatico l’allontanamento dalla madre naturale. Il problema è molto più comprensivo.
Il punto cruciale è che nella nostra frenesia liberale di immaginare nuovi diritti dimentichiamo che ogni diritto prefigura una nuova norma e dunque una nuova possibile normalità. E quello che dobbiamo chiederci è: quanto è probabile che non sia socialmente disfunzionale l’istituzione di una nuova normalità dove, nell’ordine:
1) faccio una fecondazione in vitro tra donatori (persone) che non si sono mai visti, né conosciuti in vita;
2) trapianto l’esito in un utero ricevente (una terza persona);
3) contrattualizzo e pago il servizio della gestazione come se fosse un cambio gomme;
4) prelevo il neonato alla consegna, togliendolo alla continuità del rapporto viscerale con la madre;
5) consegno infine il neonato ad una coppia di adulti maschi (benintenzionati per carità) che hanno un rapporto totalmente virtuale ed immaginario con i neonati e la maternità.
O in alternativa:
5, bis) consegno infine il neonato ad una coppia di manager in turbinosa carriera, o magari ad un single troppo occupato lavorativamente per accollarsi una gravidanza, ma cui è saltato il ghiribizzo che, dopo tutto, avere un cucciolo d’uomo potrebbe essere una bella esperienza.
Sinceramente, credo che per non vedere più quanto di azzardato, improvvisato e presuntuoso ci sia in questo atteggiamento culturale dobbiamo essere stati ben ben acciecati dalla nostra cultura dei diritti soggettivi.
A ciò va aggiunto che questo argomento che sento continuamente, per cui si tratterebbe di problemi relativi, visto che già la famiglia normale ha di suo un sacco di casini, è un ragionamento folle. Invece che chiedere seriamente di porre rimedio alle evidenti drammatiche disfunzionalità di famiglie ordinarie, si prende la pietosa situazione dei nuclei famigliari contemporanei come un punto di partenza, da cui concludere che, siccome fanno già schifo, tanto peggio non può poi andare. Trovo incredibile che a questi ragionamenti venga dato credito.
10) MISERIA DELLA FILOSOFIA
Grande entusiasmo nella comunità LGBT ha suscitato l’intervento sul La7 di Umberto Galimberti in risposta ai farfugliamenti catto-integralisti, qui incarnati dall’ingegner Pippo Corigliano (blogger di ‘Tempi’).
Ora, capisco che chiunque si opponga al confuso dogmatismo di personaggi come il sig. Corigliano possa ricevere il pubblico plauso, ma qui le argomentazioni di Galimberti sono un’ode alla superficialità filosofica e all’autolesionismo teoretico.
1) Il tema dell’adozione omosessuale viene banalizzato con la solita argomentazione demenziale per cui “anche molte famiglie normali fanno schifo”. Ma, naturalmente questo non è il punto. Il punto è se oltre agli odierni drammatici margini di disfunzionalità famigliare, l’adozione omosessuale non ne introduca di nuovi. Un argomento da bar, non da filosofo; palla in tribuna.
2) Il tema del cosiddetto ‘utero in affitto’ è anch’esso trattato in modo completamente fuori luogo, mettendolo in parallelo con la libertà di ciascuno di regalare un rene. Ma in primo luogo regalare non è la stessa cosa di commercializzare, ed è essenzialmente della seconda cosa che parla il cosiddetto ‘utero in affitto’. In secondo luogo, chi non vede la differenza letteralmente ontologica tra ospitare un rene altrui e far crescere in sé una vita per nove mesi, non ha una riflessione nemmeno al livello di quella del bar. Secondo pallone in tribuna.
3) Infine, l’argomento di Galimberti per cui la morale e la politica non potrebbero vietare alla tecnica di fare quello che può, è un argomento penoso e suicida. Oltre ad essere un ricicciamento heideggeriano di cui nessuno sentiva il bisogno, è soprattutto un argomento che, se preso sul serio, trasforma la tecnica nell’unico soggetto della storia, e l’intera volontà umana in tutte le sue manifestazioni in un’appendice superflua, una mosca cocchiera. Come dire che se possiedi una pistola devi sparare a qualcuno, o se è possibile vendere i figli sul mercato della prostituzione minorile, allora lo farai.
Un livello sconfortante.
11) NOTA A MARGINE SUL “GIOCO DEL RISPETTO”
Qualche giorno fa un’iniziativa pedagogica pilota sostenuta dal Comune di Trieste ha ottenuto l’attenzione nazionale, e persino internazionale. Il progetto, dal titolo “il gioco del rispetto”, mira a minare gli stereotipi del maschile e del femminile, vedendoli come precursori di atteggiamenti di prevaricazione di genere. Le finalità egalitarie del progetto sono lodevoli e, credo, poco controverse.
E tuttavia una breve riflessione ci può mostrare, a prescindere da dogmatismi e ideologismi, che un dubbio razionale può ‘laicamente’ sorgere. Il dubbio è legato all’intento pedagogico e alle sue premesse teoriche, così come esse compaiono in un pamphlet di accompagnamento. Se il gioco è gioco, l’educatore dovrebbe elasticamente ‘stare al gioco’ senza instradarlo. Se però il gioco ha un intento pedagogico è legittimo credere che l’educatore/trice possa introdurre considerazioni su come sarebbe opportuno comportarsi. E qui le premesse teoriche del progetto possono pesare e vanno considerate.
Tre punti paiono problematici.
Il primo è l’idea che diseguaglianze o difformità nell’identità di genere siano l’anticamera di violenze, prevaricazioni, ingiustizie, ecc. L’idea è: poiché l’opposizione tra identità di genere (maschi-femmine) è il terreno dove crescono deprecabili meccanismi sociali (es.: la violenza di alcuni maschi sulle donne), allora cerchiamo di attenuare o abolire tale opposizione. Ma questa posizione suona valida quanto quella di chi proponesse come cura per la vecchiaia il suicidio giovanile. Se per far funzionare una società dobbiamo sopprimerne le differenze identitarie interne, ci aspettano all’orizzonte le tristi distopie di una società fondata sulla pura identità razziale, etnica, culturale, ecc. Le società storiche sono da sempre associazioni di ‘diversi’ ed ogni società è un sistema di regole per consentire la cooperazione tra differenti (per far cooperare persone affini non c’è bisogno dell’imperio della legge).
Il secondo punto problematico dipende dalla tesi abbracciata dalle redattrici (par. 2.2) per cui le identità maschile e femminile sarebbero “largamente frutto di convenzioni sociali”. Questa è una tesi che ha qualche punto di forza (l’indubbia variazione storica di alcuni tratti nei modelli maschile e femminile) e anche parecchi punti critici (casi, realmente registrati, in cui un maschio o una femmina in senso biologico sono stati forzosamente educati a sviluppare un’identità sessuale opposta, senza successo). Restando sul piano strettamente scientifico, quello che certamente non può dirsi è che la riconduzione prevalente delle identità di genere a ‘convenzioni sociali’ sia una tesi acclarata. Non è neppure lontanamente così. E dunque prendere questa tesi come solida roccia su cui costruire una pedagogia è quantomeno inappropriato.
Questo punto diviene ancor più discutibile se abbinato alla tesi successiva (par. 2.4) per cui la definizione precoce di stereotipi secondo l’opposizione ‘maschile/femminile’ rischierebbe di cristallizzarsi se non sradicata per tempo. Qui l’idea sembra essere la seguente: l’identità di genere, appresa in forma stereotipa nell’infanzia, tenderebbe a cristallizzarsi in una sorta di imprinting rigido ed immutabile. Ma questa è un’idea che non sta in piedi. Tipico della crescita nell’apprendimento umano è partire con categorizzazioni generiche e poco differenziate, rendendole più sfaccettate e complesse con l’esperienza e l’educazione. Gli stereotipi e le categorizzazioni elementari schematiche sono momenti formativi utili nella prima infanzia. Se, deprecabilmente spesso, incontriamo adulti che usano stereotipi da bambini, questo ci parla solo della miseria della loro educazione successiva, non ci dice certo che da bambini avrebbero dovuto ‘confrontarsi con la complessità’! Pensare di saltare le stereotipie (categorie elementari schematiche) per giungere subito a giudizi problematizzati e critici è un’ingenuità pedagogica gravissima.
Concludendo.
Il messaggio di fondo che l’iniziativa voleva promuovere è importante. Ed è apprezzabile che le Istituzioni locali abbiano avuto il coraggio di sostenere qualcosa di originale. Di per sé i giochi presentati nel progetto, se proposti con buon senso ed elasticità, non fanno certamente alcun danno, e possono anche avere un ruolo formativo positivo. Personalmente, avendo sempre incontrato educatori/-trici dotati di grande saggezza pratica, starei tranquillo circa l’implementazione del progetto. E tuttavia, se avessimo ragione di immaginare educatori/-trici che aderiscono senz’altro alle premesse teoriche del progetto, allora davvero ci sarebbe spazio per seri dubbi, e questo del tutto al di là di ogni etichetta di comodo su ‘conservatori’ e ‘progressisti’.
12) A CIASCUNO I SUOI DIRITTI
Un’interessante rivendicazione è stata sollevata dal fondatore dell’UCOII (Unione delle COmunità Islamiche Italiane): “Io e milioni di persone non condividiamo la relazione omosessuale e tuttavia essa è lecita e ne rispettiamo gli attori. Ora lo Stato regolamenti anche il matrimonio plurimo. Se è solo una questione di diritti civili, ebbene la poligamia è un diritto civile”.
Trovo questa rivendicazione di straordinario interesse, perché mette involontariamente a nudo la natura integralmente storica, sociale e convenzionale del matrimonio, e al tempo stesso il fatto che un’usanza integralmente storica, sociale e convenzionale possa essere radicata in forme che vanno al di là di ogni possibilità di essere messa in discussione.
Bisogna infatti convenire che l’inferenza che il presidente dell’UCOII trae è perfettamente legittima: se abbiamo deciso, per rispettare le inclinazioni di una minoranza, di introdurre una legittimazione legale all’unione tra persone dello stesso sesso, perché non fare il medesimo passo per un’altra minoranza come quella islamica, che ammette che un marito abbia una pluralità di mogli. Quali argomenti che non potevano valere anche nel caso del matrimonio omosessuale potremmo sollevare contro la poligamia? Confesso di fare fatica a trovarne. Si tratterebbe pur sempre di una scelta tra parti consenzienti che viene incontro alle inclinazioni di una minoranza della popolazione e che non toglie nulla a chi non voglia avvalersene.
Detto questo, sul piano politico la richiesta di cui sopra è un drammatico autogol, perché in un momento in cui, a ragione o a torto, la diffidenza verso la popolazione islamica residente in Europa è già alta, una richiesta che collide frontalmente con usi e costumi europei consolidati non può che risultare altamente provocatoria. Immagino perciò che tale proposta verrà lestamente ritirata per quieto vivere.
Sono comunque sinceramente in attesa di riscontri sul piano del ‘dibattito sui diritti’.
13) EROSTRATO ALLA CLOCHE
In questi giorni [24 marzo 2015, ndr.] giornali e notiziari sono stati dominati dalla catastrofe del volo Germanwings 9525.
Per quanto è dato sapere sembra che si vada via via componendo un quadro del disastro, ad anche le spiegazioni più profonde dell’accaduto sembrano in via di esaurimento. E tuttavia nel quadro emerso c’è una classe di spiegazioni che, curiosamente, manca e che merita considerare.
Va doverosamente premesso che possiamo qui valutare solo le notizie ufficiali, con i loro eventuali limiti ed omissioni. Dunque non ci proviamo neanche a dire una qualche ‘ultima verità’ su ciò che è successo. Ciò che vogliamo esaminare è piuttosto la ricerca delle spiegazioni dell’accaduto presso media, social e grande pubblico.
In prima battuta il pensiero di tutti era andato ad un attentato terroristico, e a seguire ad un guasto. Quando hanno cominciato a trapelare notizie sulla possibile responsabilità di chi era alla guida, sono iniziate a emergere congetture su eventuali afferenze terroristiche dei piloti. (Esemplare lo speranzoso tweet dell’onorevole Santanché: “Che origini hanno i piloti dell’autobus [sic] caduto?“). Infine, dopo la conferenza stampa del procuratore di Marsiglia, è iniziata l’esegesi delle motivazioni del co-pilota, Andreas Lubitz (A.L.). Una volta accertato che, grazie al cielo, A.L. non aveva sangue arabo (o magari greco) nelle vene, ci si è rassegnati a quell’ultima minimale forma di spiegazione che è la ‘follia’. A.L. sarebbe stato squilibrato. Si sarebbe trattato dunque del gesto folle di un depresso (per l’abbandono della fidanzata, per impedimenti alla carriera di comandante, ecc.).
In tutto questo quadro c’è però un interessante punto cieco. Mettiamo in fila le ‘rivelazioni’ biografiche relative ad A.L. La sua massima ambizione sarebbe stata diventare pilota, avrebbe avuto la carriera ostacolata da problemi psicofisici, avrebbe infine confidato alla fidanzata che un giorno avrebbe fatto qualcosa tale per cui “poi tutti sapranno il mio nome e lo ricorderanno”.
A questi tratti va aggiunta un’osservazione su cui tutti gli psichiatri interpellati si sono trovati d’accordo: la depressione qui non spiega nulla. Un depresso grave è restio al lavoro, se lavora lo fa in modo manifestamente subottimale, e soprattutto non pianifica, tantomeno pianifica qualcosa di così organizzato come ciò che A.L. avrebbe fatto.
Se questo è il quadro, lascia perplessi come una specifica spiegazione non si sia proprio affacciata.
Una delle figure archetipe di comportamento immorale nell’antichità è Erostrato. Erostrato fu un pastore ellenico che nel 356 a.C. diede fuoco, distruggendola, una delle sette meraviglie del mondo, il Tempio di Artemide a Efeso. Ma più che il misfatto furono i motivi addotti da Erostrato a colpire: egli disse di desiderare più di ogni altra cosa che il suo nome fosse tramandato ai posteri, foss’anche per un atto abietto.
Ora, ciò che sappiamo sembra delineare un quadro interpretabile nel modo più lineare in questa chiave: più che depresso, paranoico, bipolare o quant’altro, A.L. appare ambizioso, autoreferenziale, disinteressato alla vita altrui, e bramoso di rinomanza. Tutto parla a favore di un novello Erostrato, poco o nulla parla a favore di altre motivazioni. Naturalmente, insistiamo, questa può essere una congettura del tutto sbagliata. Ma ciò che ci chiediamo è perché non venga formulata.
A prima vista pare che una spiegazione nei termini di una moralità distorta semplicemente non sia più intellegibile o metabolizzabile. Che qualcuno soffra di uno ‘squilibrio mentale’ è del tutto ok: delle sue motivazioni continuiamo ad ignorare tutto, ma possiamo sempre sperare che una pillola prima o poi metta a posto le cose per noi. Ma uno squilibrio morale? Questo suona oggi per noi problematico, imbarazzante ed inattuale. I giudizi morali sembrano oramai espulsi dalla sfera razionale: essi abitano solo il moralismo dogmatico o l’invadenza illiberale. Ma quest’odierna diffusa dislessia morale è di per sé un problema, le cui ripercussioni hanno una gravità rispetto a cui la strage dell’airbus impallidisce.
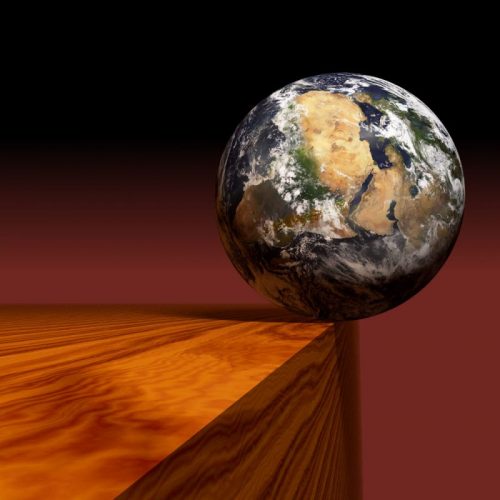
Una domanda: è possibile che la pornografia (e non mi riferisco solo a quella esplicita, ma anche a quella strisciante diffusa essenzialmente tramite la pubblicità commerciale e certi fenomeni musicali “trasgressivi”*) abbia qualche incidenza sulle forme di disagio psichico descritte nell’articolo?
*anche se parlare di trasgressione in una società dove la trasgressione stessa è diventata un valore – creando così un cortocircuito logico e morale destabilizzante, soprattutto per i giovani – è leggermente imbarazzante.