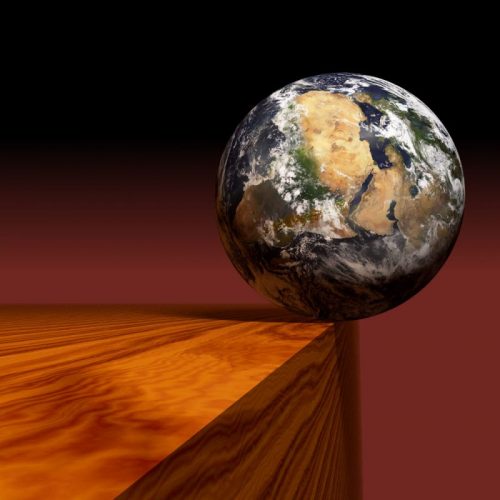1) PUBBLICA ISTRUZIONE, TRA CAPITALE UMANO E CAPITALE SOCIALE
http://mimesis-scenari.it/2015/10/20/pubblica-istruzione-tra-capitale-umano-e-capitale-sociale-2/
“Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate con l’ignoranza”
Derek Bok (Harvard University)
- Abbiate fiducia!
È divenuto costume ricorrente dei Presidenti del Consiglio italiani invocare una maggiore ‘fiducia’ come chiave di crescita e sviluppo. Dagli inviti berlusconiani all’ottimismo, da tradursi in spesa liberale al ristorante, al refrain renziano della fiducia nel paese contro i ‘gufi’ che remano contro, è tutto un prodigarsi a rafforzare l’autostima italica nel nome dei poteri taumaturgici della ‘fiducia’. Questi appelli alla ‘fiducia’ sono tuttavia, probabilmente, dovuti ad un’impropria comprensione del nesso tra ‘fiducia’ e progresso economico.
In una certa accezione la fiducia è realmente uno dei fattori cruciali nella crescita economica e nello sviluppo sociale di un paese, tuttavia questa fiducia non è un tratto psicologico soggettivo, come se bastasse una pillola di Prozac, ma un tratto cognitivo e una funzione sociale. La fiducia di impatto economico dipende dalla capacità cognitiva di affrontare la realtà circostante (capitale umano) e dal buon funzionamento delle relazioni sociali (capitale sociale).
In sociologia prende il nome di capitale sociale, la capacità di instaurare relazioni sociali costruttive e di lungo periodo. Ridotti tassi di corruzione ed elevato rispetto delle regole sono corollari tipici di un alto livello di capitale sociale. La distruzione del capitale sociale è da sola in grado di annichilire un’economia ed una società. Un esempio di Joseph Stiglitz può aiutare a comprendere la natura del capitale sociale: all’indomani del crollo dell’Unione Sovietica, il potere coercitivo centrale in Uzbekistan venne meno, mentre il paese si trovava in una condizione di elevata disgregazione sociale. In breve tempo la produzione agricola crollò per il collasso dell’intero sistema delle serre pubbliche, perché i cittadini andavano a rubare le lastre di vetro delle serre per rivendersele sul mercato nero. Non fidandosi né del potere centrale, né gli uni degli altri, l’alternativa di un piccolo guadagno a breve termine era ritenuta preferibile ad un grande guadagno collettivo a lungo termine.
Tradizionalmente si distingue il ‘capitale sociale’ dal cosiddetto capitale umano. Per ‘capitale umano’ si intende l’insieme di conoscenze e capacità personali che contribuiscono alla produzione economica e allo sviluppo sociale. Alla formazione del capitale umano contribuiscono dunque essenzialmente educazione ed istruzione.
È importante vedere come il capitale umano e quello sociale siano persino più determinanti del semplice capitale fisico o finanziario nel migliorare le condizioni di vita in un paese. Questa differenza può essere delineata, sia pure in modo approssimativo, guardando a cosa avvenne in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. La distruzione di capitale fisico e finanziario dovuto alla guerra era stata devastante, riportando le condizioni di vita in molti paesi a livello preindustriale. Tuttavia il capitale umano e sociale era in gran parte integro e sotto quelle condizioni tre decenni furono sufficienti a riportare l’Europa dalle macerie della guerra ad una nuova posizione di eminenza economica a livello mondiale. Al contrario, paesi con straordinarie risorse fisiche e/o finanziarie, ma con una carente sedimentazione di capitale umano e sociale possono svilupparsi con molta più fatica e su tempi molto più lunghi (Arabia Saudita, Venezuela, Nigeria, ecc.).
Capitale sociale e capitale umano sono concettualmente separabili, ma materialmente collegati. Il loro nesso è particolarmente evidente nelle grandi società, dove relazioni sociali, organizzative e produttive richiedono il coordinamento di numerose variabili e l’implementazione di diverse regole, spesso di natura astratta. In questi ambiti, tipici dei paesi industrializzati, un elevato grado di capitale umano è precondizione per il funzionamento del capitale sociale. Ovvero: solo chi ha un grado di istruzione sufficiente è anche in grado di comprendere e gestire relazioni che vanno al di là dell’interazione faccia a faccia, tipica di contesti familiari e locali. In questo senso, esistono numerosi studi che mostrano una chiara correlazione tra bassa istruzione media e alti tassi di corruzione in una popolazione. La ragione è intuitiva: chi non è in grado di comprendere in misura accettabile il funzionamento sociale, né di gestire relazioni organizzative astratte, può governare la propria realtà solo affidandosi a relazioni tra conoscenti, favori reciproci, aiuto famigliare. Queste relazioni, di per sé apprezzabili, divengono però catastrofiche quando si sostituiscono sistematicamente al coordinamento sociale tramite regole impersonali: questa sostituzione è il cuore delle pratiche corruttive, nepotistiche e familistiche.
Riassumendo. In una società complessa, come tutte le moderne società industriali, non è l’appello umorale alla fiducia in senso psicologico a fare la differenza. A fare la differenza, in termini di sviluppo a lungo termine, è la disponibilità di capitale sociale e di capitale umano.
- Della pubblica istruzione in Italia (ovvero, del tafazzismo come vocazione e come strategia)
Ora, al di là dei rituali appelli alla fiducia, all’ottimismo e all’orgoglio nazionale, qual è stata la strategia delle classi dirigenti italiane nei confronti della cura e dell’accrescimento del capitale umano e sociale? Con sparute eccezioni, e sin dal 1948, si è trattato di strategie autolesioniste e miopi. Avendo tempo, sarebbe anche utile mostrare come (soprattutto in tempi recenti) iniziative legislative volte ad alimentare atteggiamenti competitivi più che cooperativi abbiano danneggiato il tessuto connettivo del capitale sociale. Ma qui ci vogliamo soffermare soltanto sulla componente più macroscopicamente fallimentare: la strategia della Repubblica Italiana nei confronti dell’istruzione pubblica. La spesa pubblica italiana per l’istruzione, primaria, secondaria e terziaria, è da sempre scarsa, in termini assoluti e in relazione al PIL. Ciò ha molte origini. Un ruolo ha giocato certamente, negli anni di governo democristiano, il fatto che l’istruzione pubblica fosse vissuta come un pericoloso focolaio di laicità, da non alimentare. Un certo peso lo ha avuto senz’altro anche il timore, da parte di classi dirigenti, esse stesse spesso culturalmente deprivate, di nutrire l’indipendenza culturale di una popolazione, perdendo con ciò tradizionali leve di controllo. Più di ogni altra cosa ha pesato la perenne priorità attribuita dalla classe politica alle istanze di breve termine: infatti solo la risoluzione di problemi emergenziali, in cui il nesso tra intervento e risultato sia immediato e facilmente percepibile, possono essere venduti facilmente sul mercato politico. Al contrario, riforme i cui risultati sono visibili solo uno o due decenni più tardi non rappresentano certo una priorità per un ceto politico spesso teso solo alla successiva rielezione.
Tuttavia, in tutti i paesi industrializzati, negli ultimi vent’anni, la consapevolezza del ruolo cruciale svolto dal capitale umano e sociale è cresciuta impetuosamente. In effetti, essa è cresciuta tanto più dove già tale capitale era disponibile in misura elevata, creando le condizioni per un ampliamento ulteriore della forbice dello sviluppo.
Ma qual è stata la ricezione Italian style di questa rinnovata consapevolezza sul ruolo del capitale umano? La nostra versione ha preso la forma di alcuni maître-a-penser (incidentalmente tutti legati a interessi nell’istruzione privata, da Roberto Perotti, a Francesco Giavazzi, a Roger Abravanel, ecc.), i quali hanno iniziato, dalle pagine dei maggiori quotidiani nazionali, un martellamento inesorabile avente per oggetto le drammatiche carenze del sistema formativo italiano. E ciò poteva essere una buona cosa, se non fosse per un tratto comune a tutti questi resoconti: essi hanno sistematicamente omesso o minimizzato ogni riferimento al tema del carente finanziamento pubblico, concentrandosi invece (di norma con accenti moraleggianti) sulle pecche del personale del mondo dell’istruzione. Al netto delle varie soluzioni proposte, il nocciolo duro delle loro argomentazioni ha preso una forma tipica: 1) vengono notati (ed occasionalmente inventati) i difetti di un sistema, 2) se ne tacciono le cause storiche, 3) si levano critiche di indole morale e personale, 4) si utilizzano tali critiche per tagliare le risorse attualmente spese o per condizionarne l’erogazione a maggiore impegno da parte dei, moralmente reprobi, operatori del sistema. Infine, 5) quando le difficoltà create da queste politiche restrittive inducono ulteriori problemi, si può avviare un secondo round di alti lai sulla deprecabile condizione del sistema.
In questa atmosfera culturale, con il cortese contributo di rinomati editorialisti, abbiamo dunque assistito ad un ulteriore sgretolamento del sistema dell’istruzione pubblica.
Qualche dato, per quanto noioso e probabilmente noto, è qui opportuno. (Dati tratti dall’OECD Report 2014 e dalle statistiche annuali di Almalaurea)
L’Italia è il paese Ocse con la situazione più grave in termini di analfabetismo funzionale: il 47% della popolazione è incapace di comprendere e riassumere un medio articolo di giornale (per comparazione: Messico 42%, Germania 14,4%, Norvegia 7,5%). Nel 2013, la quota di popolazione adulta italiana con al più la scuola dell’obbligo era pari al 64%, nettamente al di sopra della media europea (39%) e alla quota tedesca (18%).
In questo contesto tra il 2008 e il 2014, mentre tutti i maggiori paesi industrializzati hanno incrementato gli impegni di spesa per l’istruzione, in Italia la spesa per ricerca scientifica è passata dallo 0,56% Pil allo 0,34% (- 0,22%); la spesa per l’istruzione scolastica dal 5,69% al 5.00% (- 0,69%); la spesa per l’istruzione universitaria dall’1,19% allo 0,95% (-0,24%). 2,9 miliardi in meno all’istruzione scolastica, 1,3 miliardi in meno alla ricerca scientifica, 0,8 miliardi in meno all’istruzione universitaria. A scanso di equivoci: negli stessi anni, al netto degli interessi sul debito, la spesa pubblica è aumentata di 50 miliardi (+ 10,7%).
L’Italia che ha già uno dei più bassi tassi di laureati (22% contro una media Ocse del 37%), ha avuto un ulteriore crollo di immatricolazioni dal 2003 (338 mila) al 2013 (270 mila): meno 20%. Questo per inciso non è dovuto al cavallo di battaglia farlocco degli editorialisti nostrani, per cui la laurea non conferirebbe vantaggi occupazionali. Come testimoniato ripetutamente dalle statistiche (Almalaurea), la laurea (qualunque laurea, anche se alcune più di altre) conferisce sia vantaggi in termini di velocità nel trovare lavoro che in termini di reddito. I laureati, in media, sono occupati ad un anno dal termine degli studi del 14% in più dei diplomati, e guadagnano in media il 25% in più. Vantaggi comparativi simili sono conferiti dal diploma di scuola superiore rispetto alla semplice conclusione della scuola dell’obbligo.
Per spiegare il calo delle immatricolazioni molte cause possono essere addotte, ma tra queste è certamente prominente il fatto che ad oggi l’Italia è al terzo posto tra le rette universitarie più alte nell’Ocse (dopo UK e Olanda), e che da noi meno di uno studente su dieci ha un qualche aiuto statale per studiare (di contro, ad esempio, al 30% in Spagna, 35% in Francia).
Tra i miti che è utile sfatare, vi è quello per cui l’arretratezza nella produttività italiana sarebbe dovuta all’inadeguata preparazione fornita dalle università alle nuove generazioni. In verità, gli oramai numerosi laureati italiani che migrano all’estero (negli ultimi anni il 7%) trovano collocazione con molto maggiore facilità di quanto accada in Italia, oltre che condizioni salariali incomparabilmente migliori (in media +815 euro/mese). Quelli che tentano di rimanere in Italia, invece, si trovano a dover interagire con la classe imprenditoriale con la più bassa scolarità di tutti i paesi industrializzati: il 28% dei manager italiani ha completato la sola scuola dell’obbligo, contro il 5% in Germania e il 10% della media EU27. Non desta molta sorpresa, dunque, che questo ceto privo di formazione abbia sviluppato con assoluta prevalenza imprese a gestione familiare (66% contro il 36% della Spagna e il 28% della Germania). Così come non desta sorpresa che questa classe imprenditoriale sia mediamente incapace di valorizzare il capitale umano di cui potrebbe disporre.
Di passaggio, vale la pena di ricordare che la competizione economica a livello mondiale si gioca, schematicamente parlando, su due livelli: quello di una produzione ad alto valore aggiunto (dove si compete in termini di formazione e tecnologia) e quello di una produzione a basso valore aggiunto (dove si compete in termini di bassi costi di produzione). Il primo richiede investimenti in capitale umano, il secondo richiede compressione dei salari. Il primo incentiva ed esige una popolazione mediamente capace di valutazioni razionali ed informate, il secondo no. Non richiede molto sforzo comprendere quale delle due opzioni sia maggiormente compatibile con il buon funzionamento di uno stato democratico.
- Rien ne va plus
Ora, negli ultimi anni, il tema delle varie ‘riforme’ dell’istruzione, scolastica o universitaria, si è ripresentato numerose volte in una medesima veste, cui l’opinione pubblica sembra aver aderito con convinzione. Questa forma è così riassumibile: ammesso e non concesso che un problema di finanziamento ci sia, prima bisogna ‘fare le riforme’ e poi, forse, avverranno nuove erogazioni di fondi.
Questo format mentale è passato come se si trattasse di una riflessione tutto sommato ragionevole. Anzi, a fronte delle considerazioni fatte più sopra, mi sembra già di sentir echeggiare in lontananza voci note: “Non basta mica aumentare i danari per ottenere risultati!” “Non ha senso versare vino in una botte bucata!”, e via luogocomuneggiando.
Invero, questo ragionamento di apparente buon senso è passato così in profondità che la stessa Conferenza dei Rettori negli anni scorsi ha sostenuto la riforma Gelmini dell’università, concedendo che andassero fatte prima le riforme e che solo poi giungessero i finanziamenti. Che poi, come noto, le riforme siano passate ma i finanziamenti non siano arrivati è un mero dettaglio.
Ora, è giunto il momento che questo modulo di ragionamento, una volta per tutte, e definitivamente, venga collocato dove gli si conviene, avendo cura di tirare lo sciacquone.
È infatti regola generale che le riforme fatte a costo zero, o addirittura negativo, siano riforme tendenzialmente abortite e fallimentari. Lo sono perché ogni riforma significativa produce difficoltà gestionali e richiede uno sforzo supplementare di partecipazione e volontà per essere implementata. Mutando la cornice delle regole pregresse, le nuove regole possono venire alla luce solo con il contributo di considerevole buona volontà e disposizione al cambiamento in chi anima i settori coinvolti. Ma quando all’insicurezza dovuta ai cambiamenti di aspettative, si aggiunge una prospettiva di contrazione economica, le persone coinvolte si concentrano di norma non sull’escogitare soluzioni ottimali, ma sul salvare il salvabile (a livello personale o di settore).
Questa considerazione generalissima vale doppiamente quando si tratta di settori già perennemente in condizioni di carenza.
Così, è bello auspicare che l’accademia italiana duelli a viso aperto con le grandi università mondiali, e scuotere il capo con disappunto quando ciò non accade. Peccato che fare così quando i laboratori cascano a pezzi, i corsi sono affidati sempre più spesso a rincalzi precari, le acquisizioni librarie latitano, i fondi per il diritto allo studio sfumano, i fondi di ricerca e di missione sono un lontano ricordo, ecc. è un po’ come deprecare che il Borgorosso Football Club non vinca la Champions League.
E siccome i miracoli esistono, nonostante tutto, accade persino che il Borgorosso si posizioni onorevolmente: l’Italia ricopre un buon settimo posto mondiale quanto ad impatto della ricerca scientifica. In effetti, come mostrato quest’estate da un ‘divertissement agostano’ di Giuseppe De Nicolao, se aggiustassimo i punteggi delle classifiche universitarie internazionali in proporzione alla spesa erogata per ottenere quei punteggi, otterremmo una classifica in cui le università italiane coprono 8 dei primi 10 posti nel mondo. Naturalmente questa classifica non vale più dei ranking internazionali su cui si appoggia (dunque, non vale quasi niente); ma se si accetta che quei ranking vengano utilizzati a giorni alterni come clava per randellare l’accademia italiana, allora bisogna parimenti accettare che l’università italiana sia la più produttiva al mondo.
Ma anche i miracoli hanno un termine e come dice l’adagio, se vuoi che il cielo t’aiuti, devi aiutarti da te.
Auspicare che l’accademia si apra alla competizione mondiale e che diventi attrattiva per i migliori ricercatori internazionali, mentre i salari sono tra i più bassi dei paesi industrializzati, e le infrastrutture di ricerca tra le più scadenti, è solo un’esibizione di retorica (unico skill in cui la classe politica italiana sembra aver conservato un grado di eccellenza).
Stiamo allora forse dicendo che bisogna cominciare a versare vino nella botte, senza preoccuparsi dei buchi? Sì, stiamo dicendo precisamente questo, perché qui accade curiosamente che i buchi vengono tappati proprio solo dal vino.
È dunque tempo di cestinare quella collezione di precondizioni ed eccezioni, di auspici e rimproveri, di se e di ma che ha costantemente accompagnato il discorso pubblico sulla pubblica istruzione. È giunto il momento di rispedire al mittente queste armi di distrazione di massa che hanno promosso per decenni lo smantellamento del sistema formativo pubblico.
La classe dirigente italiana è di fronte ad una ed una sola decisione fondamentale: o finanzia la propria istruzione pubblica, scolastica ed universitaria, portandola almeno al livello medio dei paesi industrializzati, oppure condanna il paese ad un inesorabile ulteriore regresso, economico e civile. Tutto il resto sono oramai solo chiacchiere, colpevoli o complici.
Il capitale umano e sociale che consente ad una democrazia di funzionare, e ad un apparato produttivo di innovare, richiede immediati e seri investimenti di lungo periodo, mentre fa serenamente a meno dello scandalismo interessato di intellettuali mercenari, così come degli annunci tanto al chilo di politicanti da operetta.
2) CERVELLI IN FUGA
La Commissione Ue:
“[La ‘fuga dei cervelli’ dall’Italia] può causare una perdita netta permanente di capitale umano altamente qualificato, a danno della competitività del Paese. Nel medio e lungo termine può compromettere le prospettive di crescita economica dell’Italia e anche le sue finanze pubbliche“.
Il presidente del Consiglio italiano:
“Non continuiamo con la retorica della fuga dei cervelli. Il punto centrale è che bisogna aprirsi, bisogna trovare il modo per essere attrattivi, aprendosi alla competizione internazionale.”
Ecco.
Orsù, gettiamo (in perfetto Italian Style) la stampella contro il nemico e il cuore oltre l’ostacolo.
Certo, Renzi che mette al bando la retorica è credibile quanto Trump che si schiera per la Political Correctness.
E affrontare a viso aperto la competizione internazionale per l’Università italiana è un po’ come per Valentino Rossi presentarsi al Moto GP in scooter.
E con le bottiglie di minerale sulla pedana.
Sì, sì, lo so, siamo dei gufi.
Ma purtroppo per Renzi (e per il Paese)
noi gufi ci vediamo bene.
3) BUONA SCUOLA, CATTIVA POLITICA
http://mimesis-scenari.it/2015/05/22/buona-scuola-cattiva-politica/
1. Orgoglio e pregiudizio. Il successo dello sciopero della scuola del 5 maggio (2015) ha apparentemente sorpreso il Governo e lo stesso premier: tale successo, a sentire le reazioni, sembra sia apparso inaspettato se non incomprensibile. Più di una voce, infatti, si è alzata osservando che in questi anni sono passate riforme giudicate peggiori, con reazioni minori, e il premier, orgoglioso come sempre della propria iniziativa politica, non riesce ad attribuire tale sollevazione se non a pregiudizio politico. Ma naturalmente nella storia, e dunque nella politica, non esistono comparazioni atemporali: si giudica sempre in contesto, laddove il contesto presente si deve far carico del relativo passato. Perciò dovrebbe essere chiaro a tutti come anche questa riforma non possa pretendere di essere valutata astrattamente, per così dire, mettendola accanto alle precedenti come in un concorso di bellezza: essa infatti si somma alle riforme precedenti, ereditandone gli oneri.
2. Una ventennale frenesia riformatrice. Ricordiamo allora brevemente, a noi stessi e al nostro premier, come siamo arrivati dove siamo ora. Negli ultimi vent’anni scuola ed università sono state costantemente ‘attenzionate’ dalla politica. Prima di questo periodo l’educazione statale era stata sempre saldamente nelle mani della Democrazia Cristiana, che aveva provveduto ad ‘insegnare la modestia’ all’istruzione laica, tenendola in dignitosa povertà e sotto stretto controllo (tutti i ministri dell’Istruzione della prima Repubblica, con trascurabili eccezioni, furono democristiani). Venuta meno la DC e con essa i suoi timori per una ‘deriva laicista’ del paese, a partire dal primo governo Berlusconi la scuola si è palesata alla politica nella figura in cui continua ad apparirle a tutt’oggi: come un ingombro fastidioso e politicamente improduttivo. Qualunque iniziativa in ambito scolastico dà infatti i suoi eventuali frutti ad anni di distanza, e dunque non rappresenta quell’investimento politico con ritorni personali a breve termine che attrae il politico medio. C’è tuttavia un piano su cui l’istruzione risulta materia spendibile nel breve termine, ed è quando si riesca a farne una bandiera ideologica, un simbolo. Questo è stato il destino della scuola negli ultimi vent’anni. Dell’educazione si è voluto fare un luogo di esercizio ideologico per ambiziosi dilettanti della pedagogia. Si è ritenuto di dover ‘modernizzare’ un sistema educativo, sottofinanziato ma non scadente, cercando di cucirgli addosso l’unico vestitino ‘moderno’ che il ceto politico aveva a disposizione nel proprio deprimente guardaroba ideale, il liberalismo economico.
Beninteso, ciò non significa affatto che in Italia si sia mai davvero imposta un’agenda di riforme liberali. Nei campi d’elezione dove tali riforme avrebbero potuto sensatamente applicarsi si è visto poco o nulla (dall’antitrust, al conflitto d’interessi, all’esistenza di ordini e corporazioni, ecc.) No, la modernizzazione liberale all’italiana è sempre stata una verniciatura simbolica da applicare preferibilmente in ambiti periferici (come la scuola) rispetto a quelli per cui la teoria liberale era stata elaborata.
Si cominciò così con la prima mini-riforma all’insegna del risparmio del ministro D’Onofrio, che abolì gli esami di riparazione (1995); e si proseguì poi con la Riforma Berlinguer, che modificava l’esame di maturità, eliminando i membri esterni delle commissioni (altro piccolo risparmio) e introducendo i quiz a risposta multipla, più una miriade di altre modifiche durate lo spazio di un mattino. La Riforma, scriveva già allora il ministro, era ispirata dalla “necessità di superare la distinzione, tipica del sistema formativo italiano tradizionale, fra cultura e professionalità e, quindi, fra formazione culturale e formazione professionale”. Ci furono in quest’ottica grandi progetti sulla modifica dei cicli scolastici, l’estensione simultanea dell’educazione professionale e dell’obbligo scolastico, ecc. ma non si fece in tempo neppure a studiarne l’implementazione che il tutto venne abrogato dalla Riforma Moratti (2003). Anche quest’ultima faceva grande sfoggio di pulsioni moderniste, introducendo fin dal primo anno delle elementari lo studio dell’inglese (senza insegnanti di inglese) e l’uso dei computer (senza fornire i computer). Ma prima di tentare una messa a punto di tutte le sue lodevoli intenzioni la Riforma Moratti venne a sua volta abrogata dalla Riforma Gelmini (2008), che innalzò il numero massimo di studenti per classe, ridusse le attività di sostegno e alfabetizzazione per i bambini con ritardi (o stranieri), ridusse il numero di insegnanti alle elementari tornando al ‘maestro unico’, ridusse il monte ore delle medie inferiori, ridusse di un terzo le ore negli istituti tecnici e professionali, ecc. ecc.
3. La sostanza economica. Ma mentre ferveva tutto questo attivismo riformista (di cui tacciamo, avendo lasciato tracce solo negli incubi del personale coinvolto), cosa succedeva in parallelo sul piano strutturale dell’investimento in educazione? È presto detto.
Dal 2000 ad oggi l’Italia ha investito meno di tutti gli altri paesi OCSE (tranne Grecia e Croazia) in istruzione, diminuendo gli stanziamenti netti di oltre il 5%, mentre in tutti gli altri paesi aumentavano. Questa diminuzione peraltro avveniva su di un terreno già tenuto virtuosamente a dieta dal legislatore, facendo sì che ad oggi (dati Istat) l’Italia sia buon’ultima nell’UE per investimento pubblico complessivo nell’educazione (4.6% del PIL, a fronte, per dire, di Danimarca (7,9%), UK (6.4%), Francia (6.1%), Portogallo e Spagna (5,5%), ma anche USA (6.9%), Australia (5,8%) ecc.). Non è difficile in questo contesto comprendere come il salario degli insegnanti sia al 17° posto su 23 paesi considerati dall’OCSE (a parità di orario). Quanto alle infrastrutture, stendendo il proverbiale pietoso velo su quelle tecnologiche, di cui abbiamo contezza per sentito dire, in Italia 2/3 degli edifici scolastici non sono a norma e più di un terzo (24.000 edifici) ha bisogno di interventi funzionali urgenti. Il quadro non sarebbe completo se non ricordassimo, anche se solo di passaggio, l’evoluzione della situazione nell’Università dove i tagli di denaro pubblico degli ultimi anni sono stati feroci (meno 15% in cinque anni), su una base che ci vedeva già prima della crisi al 32° posto su 37 nei finanziamenti OCSE; tali tagli peraltro sono stati effettuati in un contesto con il minor numero di laureati in Europa (22.4% contro la media del 37%), le tasse più alte d’Europa (salvo UK e Olanda) e una copertura di borse per il diritto allo studio che lascia fuori il 30% degli aventi diritto. E si potrebbe continuare, ma smetto per non annegare il lettore in statistiche e comparazioni, tutte concordemente impietose.
4. La realtà storica al netto delle intenzioni. Proviamo ora ad estrarre il senso complessivo di questi richiami. Negli ultimi vent’anni l’educazione pubblica italiana è stata sottoposta ad un’apparente frenesia riformista, caotica negli esiti, con decisioni che si sono spesso elise a vicenda, ottenendo l’unico risultato normativo di sommergere scuola ed università di adempimenti amministrativi rivelatisi di volta in volta inutili. Al netto di questo sterile movimentismo sono però comunque emerse tre linee di fondo.
In primo luogo, nel nome della retorica della modernizzazione si è avuto un incremento di controlli burocratici con carico di adempimenti amministrativi, controlli formali, e valutazioni (es.: Invalsi), ovvero qualche bel bastone e la perenne promessa di carotine a venire. Il senso, apparentemente ragionevole, di tali interventi era quello di creare una specie di equivalente pubblico di quella selezione che (quantomeno nei manuali d’economia) regnerebbe nei mercati: “Se sei pagato dallo Stato e non sei sottoposto al giudizio del mercato, hai l’onere della prova di dimostrare che fai qualcosa a fronte di questi danari”. Purtroppo, però, una volta fatto il gesto, ad uso del pubblico votante, di imbastire controlli e valutazioni, ci si è dimenticati di definirne le funzioni. Esemplare il caso dei test Invalsi, che a otto anni dalla loro prima introduzione continuano ad essere interpretati, a seconda del responsabile politico che compare in televisione, come una forma di giudizio degli insegnanti, oppure degli alunni, o dei dirigenti, o delle scuole o delle aree geografiche, cui dovrebbe seguire una riduzione di fondi, oppure un supporto economico, o forse una riorganizzazione amministrativa, o magari un commissariamento, o l’invocazione del giudizio di Dio… E poi quando di fronte a questo minaccioso marasma qualcuno manifesta scarso entusiasmo verso i test, si invoca l’arma retorica definitiva: l’accusa di essere dei codardi timorosi della valutazione.
In secondo luogo, tutte le varie riforme hanno reiterato l’aspirazione (implementata molto vagamente) di produrre un ‘avvicinamento tra scuola e lavoro’. Al di là dell’espressione promettente e garbata, l’idea di fondo è quella di vedere sempre più nella funzione formativa del pubblico non la preparazione di cittadini, ma la ‘produzione di produttori’. Curiosamente, nel dibattito pubblico viene presa per una verità autoevidente che la scuola debba assumersi il ruolo di introduzione al lavoro. Si cercherebbero però inutilmente ragioni circostanziate per cui la scuola dovrebbe fare (in modo necessariamente generico) ciò che apprendistati e formazioni in azienda hanno sempre fatto in modo specifico. L’unica, profonda quanto taciuta, ragione consisterebbe in uno spostamento di oneri formativi tradizionalmente svolti dalle aziende, sulle spalle dell’erario pubblico.
In terza istanza troviamo la linea di sviluppo più banale, ma anche la più importante per la capillarità delle conseguenze: lo Stato italiano ha orgogliosamente conservato e periodicamente accentuato, il proprio relativo disimpegno finanziario nei confronti dell’educazione, cercando di sostituire dove possibile cespiti privati a cespiti pubblici.
A tutte queste mosse appare sottesa, intenzionalmente o preterintenzionalmente, un’ispirazione di liberalismo economico che, nonostante il perenne stato di agitazione, fatica ad applicarsi ad un campo per cui non è nato.
5. La Buona Scuola. Proviamo ora a guardare in faccia il presente tentativo di riforma. La prima cosa da capire è che questa riforma, come e più di altre, è fatta di due parti, una esplicitamente scritta ed una da scrivere nei dettagli (decreti attuativi, ecc.), dettagli deducibili solo a partire dall’ispirazione di fondo. La riforma scritta di per sé consta di un numero limitato di interventi, così riassumibili:
1) conferimento di maggiore autonomia decisionale ai dirigenti scolastici su gestione delle infrastrutture e del personale;
2) mobilità per i docenti che, dopo aver vinto il concorso, non saranno vincolati ad alcuna sede, ma potranno essere dismessi da una sede su decisione del preside;
3) possibilità di rimuovere dopo un anno di prova i docenti ritenuti insoddisfacenti dai dirigenti scolastici;
4) obbligatorietà per tutti nel triennio delle superiori di fare stage presso aziende private o enti pubblici (400 ore per i tecnici, 200 ore per i licei);
5) ampliamento della possibilità di finanziare privatamente le scuole (5 per mille, bonus fiscale per eventuali donazioni in denaro ricevute da privati);
6) ampliamento delle detrazioni per le spese per scuole private;
7) messa a disposizione di 200 milioni (2016) da distribuire su base premiale a discrezione dei presidi al miglior 5% dei docenti; anche eventuali scatti di carriera non avverranno più per anzianità, ma per accumulo di crediti in cui un ruolo decisivo sembra avere di nuovo il dirigente scolastico;
8) disponibilità di 500 euro/anno pro-capite per spese di aggiornamento culturale del docente;
9) piano straordinario di assunzioni di 100.000 insegnanti con eliminazione delle graduatorie ad esaurimento ed ingresso futuro solo per concorso.
Ora, di questa riforma più o meno tutti considerano positivamente almeno gli ultimi due punti (8 e 9). Sono entrambi migliorabili, ma certamente sono migliorativi dello status quo. Inoltre, anche al netto del piano straordinario delle assunzioni (cui il governo è comunque obbligato da una sentenza) sembra che ci sia qualche fondo in più a disposizione rispetto al passato. Dunque, si potrebbe dire, perché inalberarsi?
Ci sono, naturalmente, il resto degli articoli, che commenteremo a seguire, ma per capire appieno il perché di una diffusa sfiducia ed irritazione bisogna ricordare che la più parte della riforma non è ancora scritta. La riforma attuale contiene ben 14 deleghe al governo, relative ai poteri del preside, all’abilitazione all’insegnamento, alla flessibilità nelle classi di concorso, al personale di sostegno, al riordino degli organi collegiali, al potenziamento delle attività pratico-laboratoriali, al finanziamento premiale, ecc. In pratica c’è una gran parte della legge che compare solo in forma di assegno in bianco dato al governo. Prima che qualcuno obietti che sollevare questo punto è sterile cultura del sospetto è opportuno ricordare che ad enunciare principi più o meno condivisibili sono buoni tutti: invero, tali enunciazioni sono state disseminate a piene mani in ciascuna delle precedenti riforme, solo per essere smentite o distorte a qualche mese di distanza. Ciò che in ultima istanza conta in una ri-forma sono i particolari di come si dà forma alle cose, non le generiche intenzioni all’altezza dell’ultimo battage giornalistico. Dunque, per giudicare bene la riforma bisogna completare il quadro di ciò che è scritto con ciò che è solo accennato, suggerito, o neppure quello. Tutto ciò si può solo indovinare partendo dalla visione di fondo.
6. La Visione. Ora, se cerchiamo di sintetizzare la visione della Riforma, possiamo scorgerne tre temi qualificanti, da leggere alla luce di quanto avvenuto in passato: a) il tema del finanziamento, b) il tema della meritocrazia, e c) il tema del rapporto scuola-lavoro.
6. a) Sull’aumento dei fondi. Una delle buone novelle annunciate dalla riforma della Buona Scuola è quella di un’inversione di tendenza nel finora costante sottofinanziamento dell’istruzione. Nella legge si parla di 200 milioni stanziati per una distribuzione premiale ai singoli docenti, oltre che di uno stanziamento di almeno un miliardo per il piano straordinario delle assunzioni. Si è poi parlato, senza però indicare né fonti precise né specifiche destinazioni, di un totale di 3,9 miliardi nei prossimi anni. Tutto ciò farebbe ben sperare: che sia ‘la volta buona’?
Certo, può lasciare perplessi il fatto che simultaneamente si apra la possibilità di finanziamenti privati, che di solito sono l’anticamera di un disimpegno statale. Ma questa è naturalmente ‘mera cultura del sospetto’, sia pure con una solida base induttiva. Ci sarebbe poi qualche altro particolare che non quadra del tutto, come il fatto che ci sia appena stato in finanziaria un taglio di 450 milioni alle scuole in termini di posizioni A.T.A. (2020 in meno). Ma anche questo potrebbe essere solo un dettaglio, un ultimo taglietto (dopo una riduzione di 8 miliardi negli scorsi anni), prima dell’agognata inversione di tendenza. E la verità è che tutti noi vorremmo davvero crederci: “I want to believe”, per citare X-files. C’è purtroppo un ultimo ingombrante dettaglio. Al netto delle promesse, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria prodotto da questo governo spiega che la spesa per l’istruzione è prevista in costante diminuzione in percentuale sul PIL per i prossimi 15 anni, toccando un abissale 3.3% del PIL nel 2030 (sic).
Ecco, ora va bene appellarsi all’ottimismo della volontà, alla fiducia nel futuro, all’amore per il Leader, ma temo che la richiesta di atti di fede secondo la formula credo quia absurdum vada ancora al di là di quanto un governo possa legittimamente chiedere ai propri cittadini.
6.b) Sulla ‘valutazione premiale’. Un secondo punto apparentemente del tutto ragionevole sembra essere l’appello alla meritocrazia: è del tutto sensato che chi fruisce di un reddito pagato dal pubblico sia pubblicamente valutato. In verità ci sarebbero per ciò già i concorsi pubblici (peraltro sospesi da anni), ma si aggiunge qui l’idea, anch’essa ragionevole, di avere da un lato una perdurante spinta incentivale al miglioramento durante la carriera didattica e dall’altro di avere la possibilità di liberarsi di eventuali pesi morti (docenti neghittosi ed incapaci). Personalmente trovo entrambe queste istanze, anche se non primarie, comunque condivisibili; ma temo che non sia questo il punto. Non basta infatti brandire con enfasi parole come ‘merito’ e ‘valutazione’ per ottenere ciò che si evoca. Il refrain della meritocrazia e del premio allo sforzo individuale ha dietro di sé un’ubertosa tradizione retorica, anche nelle riforme della scuola, ma ben poca sostanza operativa. Ciò che ci si deve chiedere è: il sistema ‘meritocratico’ qui escogitato è in grado di fornire ciò che promette? Prendiamo i due estremi della scala: i ‘pessimi’ (P), di cui ci vogliamo liberare, e gli ‘ottimi’ (O) che vogliamo premiare rendendoli esempi virtuosi.
Questo sistema è in grado di liberarci dei (P) del sistema? No, non lo è; in effetti è persino meno efficace del gracile sistema attuale degli ispettori, che almeno permette la cacciata in casi estremi. Qui ciò di fronte a cui ci troviamo è una situazione in cui il preside, che assumiamo per ipotesi ‘illuminato’, potrebbe trasferire i vari (P) generando un sistema in cui nelle scuole meno ambite come locazione finirebbe per concentrarsi la morchia del sistema. Dunque è una soluzione al contempo dubbia nei modi (per la concentrazione di poteri in un singolo giudicante) ed inefficace nei fini, anche se tutto funzionasse al meglio.
Prendiamo l’estremo opposto e supponiamo che il nostro preside illuminato individui sempre con occhio di lince gli (O) del sistema, conferendogli premi monetari e permettendogli avanzamenti di carriera. Questa forma di premialità ha due caratteristiche: è attribuita da un giudizio soggettivo insindacabile e fornisce riconoscimenti economici differenziando un’élite minoritaria all’interno della compagine docente. Supponiamo ora che, magicamente, tutti i presidi della nazione fossero esenti da errori cognitivi e pecche morali. Ciononostante il fatto stesso che il loro giudizio sia individuale ed insindacabile lo rende passibile di sospetto di avere predilezioni più o meno torbide: chi risulterà tra i non eletti (al momento, il 95%) non potrà che leggere la valutazione come un misconoscimento personale (e tanto più se ci ha provato ad essere ‘bravo’). Di più: supponiamo per un attimo che un gruppo di docenti sia composto da insegnanti tutti di qualità simile (al limite tutti straordinari). Il dirigente scolastico non può premiarli tutti, ma dovrà sceglierne comunque qualcuno (il 5%), trattando perciò ingiustamente gli altri (magari insegnanti parimenti eccellenti). Il risultato netto di un sistema del genere è chiaro: invece che un incentivo a far bene si genererà una maggioranza di scontenti e recriminanti, creando con ciò un potente ostacolo alla cooperazione, necessaria in un contesto come quello scolastico. Il punto, anticipando possibili obiezioni, non è che la ‘valutazione’ vada necessariamente respinta, né che sia impossibile istituirla. Se lo si vuol fare, si può farlo, ma, come accade in altri paesi, solo in forme che hanno un aspetto il più possibile ‘terzo’ ed obiettivo. Altrimenti la valutazione finisce solo per suscitare ostilità, gelosie, sospetti e frustrazioni, ingenerando più danni di quelli cui potrebbe mai porre rimedio.
In effetti, il modello del dirigente scolastico come giudice inappellabile è semplicemente una scadente imitazione del modello privatistico-aziendale in un ambito in cui non c’è alcuna possibilità, neppure di principio, di formarsi un giudizio attraverso strumenti come la misurazione del contributo marginale alla produzione e simili. Detto meno tecnicamente: si tratta di fuffa travestita da buon senso popolare.
6. c) Sulla produzione di produttori. Veniamo infine all’idea di una necessaria intensificazione dei legami scuola-lavoro. Anche questa è un’idea che circola da anni e che ha già informato precedenti tentativi di riforma. Dietro un’idea del genere c’è una lettura della realtà economica perlomeno dubbia, secondo cui (come recentemente sostenuto da quel paradigma di meritocrazia che è il sottosegretario Martone) l’elevata disoccupazione giovanile italiana sarebbe dovuta ad una formazione inadeguata sul piano pragmatico. Ora, anche i sassi sanno che la dinamica della disoccupazione italiana, giovanile e meno giovanile, è innescata da una crisi della domanda interna, e che i ragazzi italiani che sono costretti ad andare all’estero per lavorare spesso si fanno valere in modi semplicemente indisponibili nel nostro paese. Naturalmente, come spesso nelle discussioni sulla scuola, la realtà è solo un volgare ostacolo sul glorioso cammino di una bella idea; e quale idea è più bella di quella di un sano ritorno al lavoro manuale come ricetta per la disoccupazione: in fin dei conti, come pensavano nell’Inghilterra del ‘700, “se non lavorano sarà ben colpa loro”.
Ora, se di ciò non si volesse fare la solita bandierina ideologica del liberalismo all’amatriciana, si potrebbe senz’altro guardare ad alcuni ambiti specifici e circoscritti (es.: l’ultimo anno di un istituto tecnico o professionale, o l’ultimo anno di ingegneria all’università) dove un’interazione lavorativa diretta appare di mutuo beneficio, per le aziende e per i discenti. Ma siccome ciò di cui ne va è essenzialmente un messaggio ideologico, da poter spendere con quattro slogan alle prossime elezioni, ne segue che simili aggiustamenti devono assumere l’aspetto ambizioso e farsesco di ‘rimedi alla disoccupazione’, se non di una pedagogia moraleggiante per le nuove generazioni.
7. Conclusioni. Da tempo, a fronte di famiglie sempre più distratte e assenti (magari semplicemente per necessità lavorative) ci si rivolge alle scuole elevando richieste di assunzione di responsabilità e di intervento pedagogico. Ogni qual volta si incontrano comportamenti socialmente disfunzionali o individui con drammatiche minorità culturali (alcuni dei quali, peraltro, con uno scranno in parlamento), si levano lamenti nei confronti di una scuola incapace di far fronte alle nuove sfide. Ma il gioco della politica italiana nei confronti della scuola (e dell’università) è stato finora un gioco sporco fino alla sfacciataggine. Si sono pretese a parole sempre più cose, lamentando le insufficienze dell’istituzione, ma senza pensare neppure per un momento di metterla nelle condizioni per fornirle, mettendo mano al portafoglio. Naturalmente, le risorse non sono tutto e non basta stanziare soldi per avere risultati. Ma altrettanto naturalmente finanziamenti adeguati sono un sine qua non, senza il quale solo l’infinita sciatteria di una classe dirigente presuntuosa ed approssimativa potrebbe pensare di infilare una dopo l’altra riforme a costo zero o negativo, migliorando con ciò il sistema. L’assoluta malafede è infine visibile nel più semplice dei dati. Se ne fosse mai davvero andato di tentare una riforma sostanzialmente migliorativa dell’educazione pubblica si sarebbe fatta la cosa più ovvia: si sarebbe rivolto lo sguardo ad uno dei sistemi che, per riconoscimento generale funzionano in modo eccellente (Finlandia, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Canada), e si sarebbe fatto il tentativo di importarlo, eventualmente con minori aggiustamenti. Naturalmente niente di tutto ciò è passato per la mente del legislatore, giacché tutti questi sistemi, adottano sì soluzioni tecniche specifiche, ma lo fanno su di una piattaforma di finanziamento rilevantemente superiore, che nessuno ha mai voluto prendere in considerazione.
Ma lasciamo pure da parte la questione, pur cruciale, delle risorse. Ciò che l’attuale governo, nella scia di quelli che lo hanno preceduto, non sembra capire è che la scuola non è proprio niente di simile all’azienda ideale degli economisti (ed invero neppure molte aziende reali lo sono). Sono ambiti in cui le persone sono chiamate a convivere e collaborare quotidianamente, dove idee di competizione individualistica e divisiva sono semplicemente controproducenti. Qualunque soluzione incentivale che volesse essere adottata deve tener conto di ciò, e dunque deve presentarsi come riconoscimento non arbitrario, cui possono accedere di principio tutti, ed in cui eventuali differenze di reddito siano correlate a differenze nei compiti e nelle responsabilità. Al contrario le soluzioni proposte con la riforma attualmente in discussione sono una volta di più un esercizio di trasposizione superficiale alla scuola di modelli estranei (aziendali-padronali).
Renzi fa mostra di non comprendere come mai il ‘popolo della scuola’ non capisca quanto lui sia ‘diverso’ e ‘nuovo’; egli ritiene che chi si oppone al suo impianto ‘meritocratico’ lo faccia perché vittima di ideologie vetuste; e questo è un peccato, perché se provasse a guardare le proprie proposte da vicino potrebbe forse accorgersi di quanto suonino esse stesse ideologicamente retoriche e stantie. Sarebbe bello se, per una volta, si provasse ad entrare nel dettaglio di come si può ottenere cosa, invece che promettere l’ennesima ‘rivoluzione liberale’ in un campo dove questi appelli sono tecnicamente fuori luogo. La scuola così finisce per ridursi, una volta di più, a campo di sperimentazione di un’ingegneria sociale dilettantesca e ideologica, di cui nessuno, davvero nessuno, sente il bisogno.
4) VISIONE DI SISTEMA
Repubblica: “Caccia a 500 geni. Lo Stato pagherà
tutti i loro studi. Il progetto sarà inserito nella legge di bilancio”
Quando si dice avere una visione di sistema.
Niente, è tutto inutile. Quando al governo c’è gente cresciuta entusiasmandosi con Talent Show su format americani e commuovendosi con Matt Damon che fa il genio ribelle, poi questi sono i risultati.
5) DELL’ARCANO NESSO TRA MINISTRI CHE PARLANO E CERVELLI CHE FUGGONO
Qualche tempo fa è assurto agli onori della cronaca uno sfogo su Facebook da parte della ricercatrice Roberta D’Alessandro. Il post è stato ampiamente discusso in rete e la dott.ssa D’Alessandro ha avuto anche modo di correggere alcune impressioni iniziali che il suo post poteva dare, dunque non ne riparleremo oltre. Tuttavia, suo malgrado, lo sfogo della D’Alessandro ha innescato alcune discussioni che oramai si accendono come riflessi condizionati nel dibattito pubblico italiano.
Queste discussioni gravitano intorno ad una serie di luoghi comuni, che come tutti i luoghi comuni hanno un fondo di verità, pur rimanendo fuorvianti. Possiamo riassumere il quadro sinottico di questi luoghi comuni nella seguente proposizione (d’ora in poi nominata come tesi C; C come corruzione):
Tesi C:
«L’Italia viene abbandonata dalle sue menti migliori (‘cervelli in fuga’) perché l’università, gestita da baroni corrotti, respinge i migliori per tenersi i raccomandati.»
Incidentalmente questa tesi, con le sue innumerevoli variazioni, è stata adoperata come una clava negli ultimi anni per giustificare davanti all’opinione pubblica (o almeno a quella poca opinione pubblica interessata a tali vicende) il progressivo strangolamento economico dell’università italiana.
Proviamo, brevemente a gettare un po’ di chiarezza su questo quadro.
Partiamo dalla questione dei ‘cervelli in fuga’. Come è stato osservato più volte, ciò che è atipico nella mobilità dei ricercatori in Italia non è la percentuale dei ricercatori italiani che trovano impiego all’estero. Questo flusso rientra nella media, ed è anzi di poco inferiore. Ciò che è totalmente inusuale per gli standard dei paesi avanzati è la pressoché totale assenza di ricercatori che si muovono in senso opposto, insediandosi a lavorare in Italia. Ciò suggerirebbe l’opportunità di chiedere non tanto a chi se n’è andato perché lo ha fatto, quanto piuttosto di indagare perché quasi nessuno prende la strada opposta. Soffermarsi sui primi casi, naturalmente, nutre un immaginario molto italiano legato all’abbandono del focolare, della pizza, della pasta e della mamma, e si presta mirabilmente ad un utilizzo aneddotico da parte dei giornali, ma contribuisce ben poco a chiarire la sostanza del problema.
Ora, se la Tesi C fotografasse la realtà, le conseguenze di un tale sistema dovrebbero essere ovvie: se le menti migliori vengono respinte a favore di una selezione di amanti, parenti e portaborse, l’esito di tale processo sarebbe ovviamente fatale: la didattica e la ricerca italiane dovrebbero essere colate a picco da lungo tempo ed inesorabilmente.
Curiosamente le cose non sembrano stare così. Sul piano della didattica il fatto stesso che migliaia di ricercatori formatisi nelle università italiane trovino poi posto in dipartimenti europei e nordamericani è un indice affidabile del fatto che la preparazione fornita è quantomeno competitiva con i migliori standard internazionali. E sul piano della ricerca i dati disponibili dicono che la produttività della ricerca italiana è tra le più alte al mondo (insieme a UK e Canada), laddove per produttività si intende il rapporto tra risorse disponibili e rendimento di quelle risorse (in termini di numero di pubblicazioni e di loro impatto internazionale). E se si guarda specificamente alla produttività media procapite (per singolo ricercatore) emerge come l’Italia detenga addirittura con distacco il primato qualitativo. (Fonte: indagine Elsevier, riportata su Nature vol. 504, Issue 7479). Naturalmente produttività non è la stessa cosa di produzione e se guardiamo alla produzione complessiva del paese, non in rapporto alla spesa ma alla popolazione, l’Italia crolla agli ultimi posti in Europa: infatti il numero dei ricercatori in Italia è massicciamente inferiore ai suoi ‘competitors’ con PIL e popolazione comparabile (meno della metà di Francia e UK, un terzo della Germania).
Ma allora, qual è dunque il mistero che qui si cela? Possibile che dopo che questo sistema corrotto ha messo da decenni in cattedra amanti, portaborse e lacché, questi rivelino infine insospettati talenti scientifici?
Per quello che conta l’esperienza personale, che naturalmente è una campionatura circoscritta e limitata, se dovessi valutare da quello che ho visto in un po’ di dipartimenti europei (UK, Austria, Germania, Francia, Olanda) la qualità dello staff di insegnamento italiano è spesso indistinguibile dai migliori esteri. Lo è quanto alla presenza di ‘star’ e lo è quanto al blocco centrale dei ricercatori e docenti attivi. Dove si distingue in peggio (anche se, va detto, si tratta di una situazione in regresso) è la presenza marginale, ma talvolta imbarazzante, di una minoranza di inattivi totali: persone che mai avrebbero dovuto entrare nel sistema, che vi sono entrate per grazia ricevuta e che una volta entrati hanno piazzato le tende, contribuendo solo all’occupazione fisica degli spazi. Si tratta di un’esigua minoranza che tuttavia rappresenta il reale pegno pagato a quanto di vero c’è nella Tesi C: è vero che talvolta baroni corrotti hanno fatto passare nel sistema amanti, parenti e portaborse per le loro esclusive virtù di amanti, parenti e portaborse.
Ora, però, se il quadro complessivo non è qualitativamente affatto così deprecabile, possibile che tutti i resoconti rabbiosi nei confronti del sistema selettivo italiano siano campati in aria? Possibile che tutti coloro che non sono entrati nel sistema universitario italiano, trovando invece accoglienza presso istituzioni estere, si sbaglino quando danno voce al loro risentimento per essere stati immotivatamente esclusi? Anche questo è altamente improbabile. Qual è dunque la verità?
La verità, come sempre, è un po’ più complessa dei quadri di comodo. Per capirne qualcosa è importante partire da un punto fondamentale: in senso comparativo l’intero sistema educativo italiano, e nello specifico il sistema dell’educazione terziaria e della ricerca, non è sottofinanziato solo dall’inizio della crisi finanziaria (comunque: grazie Tremonti, sei sempre nei nostri cuori), ma lo è da quando esiste la Repubblica italiana. Il fatto che oggi la spesa italiana per l’università oscilli tra l’ultimo e il penultimo posto tra i paesi OCSE non è il solo frutto di una svolta negativa a partire dal 2008 (svolta che pure c’è stata), ma è il frutto di una tendenza di lungo periodo. Il sottofinanziamento si è poi sempre combinato con un certo grado di sciatteria nel formulare le regole per il funzionamento della selezione e del reclutamento, producendo distorsioni strutturali che vengono interpretate in modo abbastanza fuorviante parlando di ‘corruzione’, ‘mafia’ e simili.
Per rendere più concreto il quadro presento due casi modello che sintetizzano in modo paradigmatico processi di selezione e reclutamento passati, ma che sono durati per molto tempo. Si tratta di casi modello, non episodi con una data, perché sintetizzano diverse istanze passate di cui ho contezza.
Caso I. Per un lungo periodo, soprattutto nei settori umanistici, il primo e più brusco collo di bottiglia per l’ingresso nell’ambito della ricerca universitaria era rappresentato dall’accesso al dottorato di ricerca. Diversamente dalla maggior parte degli altri paesi, dove al dottorato ci si iscrive come ad una prosecuzione degli studi precedenti, il dottorato italiano, dalla sua istituzione nel 1980, è sempre stato un dottorato con un numero chiuso molto ristretto. Per molto tempo tutte le posizioni in concorso davano diritto ad una borsa di studio, che rendeva dunque il dottorato a tutti gli effetti un primo passo nella carriera di ricercatore. In occasione dei bandi in aree umanistiche (dove lo sbocco universitario è di norma il più ambito) si avevano esami di dottorato con un normale rapporto di selezione di 1/60. Ricordo esami di dottorato con più di 200 iscritti per 3 posizioni. La commissione, composta di 3 persone, doveva correggere gli scritti in 24 ore. In teoria la correzione doveva svolgersi collegialmente, ma per stare dentro i tempi, i temi venivano normalmente divisi tra i tre membri della commissione. Ma anche così valutare decine di scritti in poche ore non consentiva certo una disamina approfondita; ciò che di fatto accadeva è che ciascun membro della commissione dava una letta alla pagina iniziale dello scritto o poco più, compilando poi una short list di massima da proporre agli altri. In questo modo nascevano le selezioni per gli orali, in cui aveva già luogo un drastico abbattimento dei candidati. (Per inciso, molti tra i più brillanti docenti delle nostre attuali università si sono visti ripetutamente bocciare in tali selezioni.) Vista l’elevata probabilità di fallimento, si presentavano spesso per l’accesso al dottorato candidati laureati da anni, che avevano già all’attivo diverse pubblicazioni, quando non addirittura monografie. All’orale, la cernita, anche quando fatta in scienza e coscienza, aveva già prodotto una selezione con un congruo grado di casualità (se il proprio tema era corretto da un membro della commissione con interessi difformi il candidato era spacciato a prescindere). Nonostante questo grado di arbitrio, all’orale giungeva una scelta di persone che con rare eccezioni, erano tutte qualificate per l’accesso al dottorato. A quel punto ‘conoscenze personali’ e ‘raccomandazioni’ giocavano un ruolo spesso decisivo: considerando che il colloquio non aveva carattere d’esame e si trattava di scartare comunque alcuni candidati validi, se il candidato conosceva incidentalmente un membro della commissione o se un suo mentore (di solito relatore della tesi) poteva segnalarne il nome alla commissione stessa, ciò risultava spesso decisivo. Bisogna trarne una lezione circa la scorrettezza mafiosa delle selezioni? È certo che la selezione prometteva di essere qualcosa che non era: ambiva ad essere un esame strettamente meritocratico e rigoroso, ma non era concepito per poter essere tale. Prometteva una cernita attenta delle capacità, ma poi vuoi per i tempi di correzione, vuoi per la strutturazione della commissione, vuoi per il destino cinico e baro, diventava qualcosa di diverso: un sistema di selezione sommaria, cui poi si sommava un sistema di cooptazione a base personale. Il peggior difetto di questo sistema non stava nel fatto che la cooptazione fosse determinante (la cooptazione è decisiva più o meno in ogni sistema accademico), ma che non si presentasse come tale, deresponsabilizzando chi di fatto operava la scelta. Ciò detto, i selezionati erano raramente degli asini, e dunque in certo modo il sistema ‘funzionava’: si trattava di un sistema confuso, in parte casuale, in parte meritocratico, e in parte cooptativo. Naturalmente gente validissima poteva vedersi sbattere le porte in faccia ripetutamente, fino a scoraggiarsi ed abbandonare.
Caso II. Un secondo caso archetipico delle vicissitudini del reclutamento, riferito al settore delle hard sciences, aveva la seguente forma. Il ricercatore X, dopo essersi fatto valere all’estero, gestendo un laboratorio con fondi ingenti, e pubblicando articoli importanti, concepiva l’idea di rientrare in Italia. Cogliendo l’occasione di un raro concorso nel proprio settore, vi si iscriveva. Ad iscrizione avvenuta gli giungeva una telefonata (o altra comunicazione) da parte di un membro della commissione, o da altra persona influente, che gli spiegava cortesemente la situazione. Per quel posto messo a concorso c’era già una fila di candidati italiani. Questi candidati lavoravano da anni, spesso gratuitamente o quasi, con laboratori fatiscenti, pubblicando perciò con molta fatica. Al nostro brillante ricercatore all’estero X veniva fatto presente che, presentandosi, avrebbe messo la commissione in seria difficoltà, perché per non farlo vincere sarebbe stato necessario formulare valutazioni forzate, che rischiavano di essere impugnabili. Si giungeva così alla preghiera-minaccia di non presentarsi (con il sottotesto, che se mai dovesse vincere, entrerà in un dipartimento dove verrà guardato con odio). Incidentalmente, che a X potesse venir concesso di vincere era fuori discussione, perché se così fosse accaduto le conseguenze sarebbero state catastrofiche per l’intero sistema. Infatti il sistema si fondava (e si fonda) sul fatto che (per le usuali carenze di fondi) una schiera di persone lavorava per anni, e continua a lavorare, andando avanti a pane e speranza. Senza il loro contributo ‘volontario’ il sistema sarebbe andato in pezzi. E a farli andare avanti era la promessa che il loro contributo sarebbe stato riconosciuto. Se il primo ricercatore brillante di passaggio poteva saltare la fila e rompere questo sistema di ‘indebitamento morale’, ovviamente il sistema intero sarebbe saltato.
Oggi tuttavia, grazie ad alcune riforme, tra cui la Legge 240/2010, casi che ricalchino esattamente le due situazioni di cui sopra non si danno o solo marginalmente. Ma lo spirito del sistema e i suoi vincoli di fondo non sono molto diversi. Parlare di ‘mafia’, ‘corruzione’ e ‘baronie’ qui significa colpire il bersaglio di striscio, rendendolo incomprensibile. La ‘questione morale’, la tradizionale tendenza a ‘flettere’ le regole, tipica del Belpaese, è solo una delle componenti e non la più importante. I fattori essenziali del malfunzionamento sono e rimangono due: la perenne mancanza di risorse e un’implementazione tecnicamente approssimativa di regole in linea di principio nobilissime. All’incrocio tra poche risorse e regole di funzionamento claudicanti il sistema obbligava galantuomini, lestofanti, e tutto quel che sta nel mezzo, alla collaborazione. Un sistema in perenne emergenza, con risorse scarse, finestre concorsuali rapsodiche, criteri di selezione vaghi e inefficienti, e fortemente verticistico nelle scelte, finisce per dare un potere spropositato ai giudizi insindacabili di persone che occupano il proprio tempo più nella tessitura di relazioni che nella sostanza della ricerca e della didattica.
Ma per andare oltre all’usuale lamentazione sulle occasioni perdute, è importante sottolineare, che alcuni piccoli passi nella direzione di una soluzione di questi problemi sono stati tentati.
a) Il sistema dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), se funzionante, dovrebbe garantire l’esclusione futura dal sistema di quella relativamente esigua ma imbarazzante minoranza di inattivi e incapaci, che mai avrebbero dovuto entrare, e che tuttavia di quando in quando sono entrati. Consentendo di accedere ai concorsi solo a coloro i quali hanno un accettabile livello scientifico e produttivo, il sistema potrebbe risolvere alla radice quel problema. (E, per inciso, non dovrebbe pensare di risolverne altri, perché non è un sistema attrezzato per ‘scovare l’eccellenza’, ma solo, nel migliore dei casi, per escludere le evidenti subottimalità).
Ad ogni modo l’ASN non sta funzionando e a non farlo funzionare, non è la proverbiale nequizia degli accademici italiani, ma l’usuale approssimazione della nostra classe dirigente. Infatti il sistema dell’ASN non è mai entrato a regime, facendo svolgere 2 sole sessioni di contro alle 5 che avrebbero dovuto svolgersi (la terza sessione ha già subito quattro rinvii). Inoltre i criteri che dovrebbero consentire l’abilitazione sono risultati per molti settori confusi, arbitrari fino al ridicolo e, comunque costantemente mobili, così che nessuno può essere in grado di programmare fiduciosamente il proprio lavoro, le proprie pubblicazioni e attività. Quando i media nazionali cercano di spiegare l’assenza di ingressi stranieri nel sistema dovrebbero forse concentrare l’attenzione su prosaiche disfunzioni di questo tipo, prima di rincorrere commoventi biografie di valenti studiosi emigrati all’estero.
b) Anche l’avvenuta adozione del modello della valutazione ex-post dei dipartimenti potrebbe rappresentare un momento di decisiva rottura con problemi del passato: infatti, premiando dipartimenti che fanno scelte di qualità nel reclutamento, si può rompere la forzata collaborazione tra galantuomini e meno galantuomini, spingendo con la leva del ritorno ai dipartimenti a scelte qualitativamente ponderate. Ma, di nuovo, tutto ciò è destinato a rimanere sulla carta senza un’implementazione all’altezza della intenzioni. Il sistema è virtuoso se e nella misura in cui i ‘criteri premiali’ sono scelti con oculatezza, dunque se e nella misura in cui produzione scientifica e qualità della didattica vengono giudicate in maniera adeguata. Se invece, come ora accade, nei ‘criteri premiali’ entrano, per dire, istanze demenziali come la minimizzazione degli studenti fuori corso, è ovvio che la valutazione, lungi dall’introdurre incentivi al miglioramento, può risultare catastrofica. (Va da sé, che per soddisfare un criterio come la riduzione degli studenti fuori corso la strada più semplice è un abbassamento degli standard di valutazione.)
c) Infine una parola sulla ricerca. In questi giorni i giornali si sono riempiti la bocca con il riferimento ai mitici finanziamenti dello European Research Council (ERC), assunti come modello di finanziamento virtuoso della ricerca. Come al solito le classi dirigenti del nostro paese, invece che faticare a pensare ai noiosi particolari di come far funzionare il sistema (che sarebbe il loro mestiere), preferiscono brandeggiare, ad uso dei media, le virtù dell’eroismo individuale, del genio italico, (nonché una certa fiducia nei miracoli). Naturalmente tale sbracata approssimazione, che fa tanta simpatia quando compare in una commedia all’italiana, ne fa molto meno quando alimenta la perenne pretesa di fare nozze di gala coi fichi secchi. Formulare e addirittura vincere un progetto ERC non è il frutto di un’estemporanea genialata della proverbiale fantasia italica. Richiede un sacco di lavoro personale dei proponenti (necessariamente sottratto o alla didattica o alla ricerca), richiede un competente supporto tecnico-amministrativo, richiede di poter segnalare la disponibilità, nell’istituzione destinata ad ospitare la ricerca, delle infrastrutture adeguate (laboratori efficienti, biblioteche aggiornate, ecc.), richiede incidentalmente anche la menzione di aver già maneggiato in passato fondi di ricerca significativi, ecc. Per il medio ricercatore del Belpaese, sotto queste condizioni, le possibilità di vittoria sono infime (e la media internazionale di successi è comunque solo dell’1-3%), a fronte della certezza di sottrarre molto tempo ad attività accademicamente fruttifere. La vera domanda sotto queste condizioni è come sia possibile che ben 13 su 30 vincitori italiani di fondi ERC siano accademicamente residenti in Italia.
Un’ultima notazione in appendice, relativamente alla menzione di questi ponderosi fondi di ricerca. Dev’essere chiaro che fondi del genere, dell’entità di milioni di euro, possono rappresentare soltanto la panna montata sulla torta di un finanziamento capillare della ricerca. Si tratta di un’aggiunta straordinaria per progetti di ricerca di particolare ambizione e che richiedono particolare spesa. Questa non è, e non può essere, la forma normale del finanziamento della ricerca. La maggior parte dell’attività di ricerca, dalla matematica alla filosofia, dal diritto alla storia, e in generale tutta la ricerca che non abbisogna di attrezzature dispendiose e di lavoro di equipe, non richiede fondi di ricerca ingenti e concentrati, ma modesti e diffusi. Tali fondi sono invece concepiti sin dall’inizio avendo in mente un modello molto specifico di ricerca (camici bianchi che maneggiano pensosamente macchinari di mistica complessità). E va benissimo che tali fondi esistano e siano disponibili per tali ricerche. Ma prenderli a modello di ciò che dovrebbe essere il processo ordinario della ricerca, come in questi giorni viene fatto trasparire, è profondamente sbagliato, e corre il rischio di introdurre l’ennesima sciatta distorsione nel nostro martoriato sistema.
6) ACCADEMIA E MERITOCRAZIA
Parlando con un po’ di colleghi esteri (Inghilterra, USA, Olanda) mi è sovvenuto come ci sia un campo in cui, non so ancora per quanto, l’Italia è meritoriamente in ritardo rispetto ad un’evoluzione (involuzione) che ha già avuto luogo altrove.
Oramai in gran parte delle università del mondo l’attività più gettonata (è proprio il caso di dire) del ricercatore accademico è la vendita in leasing di sé e della propria ricerca. Le virtù più ambite del moderno accademico alla perenne ricerca di fondi sono le medesime che fino a pochi anni fa guardavamo con commiserazione nel venditore di aspirapolvere porta a porta. “Comprate la mia ricerca, guardate quanto è figa. E io pure non sono malaccio…” (Motivational letters)
Nulla e nessuno mi convincerà che questo non sia un nauseante e penoso passo indietro rispetto all’evoluzione ottocentesca della ricerca come questione di interesse pubblico, e dunque statale.
A questo punto, se proprio devo correre dietro all’oligarca di turno per ottenere dei fondi di ricerca, un po’ come gli artisti del Medioevo e del Rinascimento correvano dietro a qualche benefattore, beh, allora pretendo almeno che ci siano gli oligarchi di una volta, e non buzzurri arricchiti.
Voto per il ripristino dell’aristocrazia feudale.
7) L’EMIANOPSIA DESTRA DI ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA
In un lungo e interessante articolo, Ernesto Galli Della Loggia (d’ora in poi GDL) ha discusso del percorso che ha condotto all’attuale deprecabile situazione della scuola italiana. L’articolo rappresenta un’interpretazione ricca, istruttiva, a tratti anche convincente, ma affetta da alcune bizzarre omissioni.
Da quanto GDL scrive, si evince che la colpa del degrado della scuola italiana sarebbe univocamente attribuibile a fenomeni e istituzioni collocate a sinistra.
Impariamo così:
• che [nel ’68] “il sogno egualitario che sempre è alimentato dalla democrazia (vedi parole d’ordine come il «6 politico», il no alla «selezione» o alla «scuola di classe» ecc.)”, avrebbe fatto sì che le aule divenissero “culla di una fraternità giovanile potenzialmente ostile a ogni autorità, vogliosa di essere «libera» e di «contare».”
• Che “l’irrompente democrazia di massa prese la forma di un’inedita mobilitazione politica di larghi settori di ceto medio, nel nostro caso i docenti della scuola pubblica. (…) Tutti furono in realtà lo strumento del solo potere che da lì in poi avrebbe dominato la scuola italiana: il sindacato.”
• Che ciò sarebbe connesso “all’avanzata della modernità — quella modernità capace per sua natura di «sciogliere tutto ciò che è solido», secondo la profezia di Marx”.
• Che ci sono stati in questi anni “tentativi in direzione timidamente contraria osati da qualche ministro della Destra”, ma come “minuscola eccezione”.
Ora, è indubbio che istanze deleterie per il funzionamento dell’attività educativa (‘6 politico’, ‘no alla selezione’, ostilità ad ogni autorità, ecc.) sono state alimentate a sinistra.
Ed è parimenti vero che il sindacato, dagli anni ’60 in poi, è stato spesso parte più dei problemi che delle soluzioni per le questioni della scuola.
Tuttavia le cecità selettive in questo quadro sono non meno interessanti:
1) Com’è possibile che in Italia gli unici responsabili di politiche decise dai governi siano componenti che al governo non c’erano (sinistra libertaria e sindacato)? Dunque gli infiniti governi del pentapartito a guida DC sarebbero state vittime ignare di politiche decise altrove? E tenere a stecchetto scuola e università sarebbero scelte dovute alla sinistra e al sindacato? Curioso.
2) Cosa vuol dire che il “sogno egualitario sempre alimentato dalla democrazia” condurrebbe a cose come il ‘6 politico’, il ‘no alla selezione’, ecc.? Chi ha detto che una forma istituzionale democratica debba comportare un’ideologia di egalitarismo astratto? In effetti, non sembrerebbe che la diffusione della forme istituzionali democratiche abbia portato il popolo ad abbandonare l’appello alla ‘meritocrazia’ o alla ‘selezione’ negli infuocati dibattiti sul campionato di calcio. Perché, dunque, l’idea dell’autogoverno del popolo dovrebbe automaticamente indurre un’ideologia di abolizione d’ufficio delle differenze (tanto più in un sistema di divisione del lavoro)?
3) Di passaggio, caro GDL, la frase di Marx sulla capacità di “sciogliere tutto ciò che è solido” non è riferita vagamente alla ‘modernità’ (il che ne farebbe qualcosa di ineluttabile), ma è riferita al Capitalismo.
Immagino che il tuo lapsus sia accidentale.
4) E infine, caro GDL, sii così cortese, spiegaci quali sarebbero state le scelte in controtendenza dei ministri della Destra (Moratti e Gelmini), perché dovevamo essere distratti e ci sono sfuggite.
La verità è che a questo processo di degrado e smantellamento della scuola e dell’università hanno partecipato almeno tre (3) differenti protagonisti, ciascuno per ragioni proprie.
1. Le forze di sinistra, di cui è vero quanto detto sopra.
2. Almeno altrettanto influente è stato però l’impatto dei desiderata delle forze cattoliche (molto più presenti al governo della sinistra) che è dalla breccia di Porta Pia che sperano di recuperare il monopolio educativo che fu loro.
3. E infine, e soprattutto, influenti sono state e continuano ad essere, ben dopo la morte e l’abiura di ogni traccia del ’68, le ramificazioni dell’ideologia liberale, diffuse più o meno nell’intero arco costituzionale.
È, infatti, alle istanze liberali che si deve:
• il concetto di un individuo refrattario ad ogni autorità;
• la priorità data ai valori economici rispetto a quelli culturali;
• il disinteresse (e la connessa riduzione dei finanziamenti) verso l’istruzione pubblica, proprio in quanto pubblica;
• l’assegnazione della responsabilità dell’educazione alla ‘saggezza delle famiglie’ (quelle che oggi menano i docenti quando danno cattivi voti ai frugoletti);
Dunque, caro GDL, visto che a sinistra è da mo’ che hanno cominciato a fare ammenda per gli ideologismi passati, quand’è che cominciate voi, liberali di destra?
P.S:
Per ‘emianopsia’ si intende una forma di cecità corticale selettiva che può colpire la metà destra o quella sinistra del campo visivo, rendendo impossibile al soggetto percepire (e persino immaginare) ciò che accade nella sezione cieca…