Ieri mi sono imbattuto in un’accusa sempreverde: si tratta dell’accusa di provincialismo nei confronti di chi difende il ruolo dell’italiano nell’ambito dell’elaborazione intellettuale, della ricerca, dell’insegnamento. Secondo gli accusatori, chi sostiene questa tesi sarebbe un attardato, probabilmente un ignorante che cerca di dissimulare la propria ignoranza, e comunque una retroguardia culturale. La lingua del futuro infatti sarebbe l’inglese, in quanto lingua già estesamente parlata, moderna, che anche grazie alla sua semplicità si presta a diventare la nuova lingua franca, come fu il latino nel Medioevo. Opporsi a questo processo inevitabile sarebbe semplicemente sciocco.
Questa prospettiva è oggi piuttosto diffusa tra i nuovi ‘ceti colti’: essa infatti combina una gioviale aria cosmopolita, con un tono di pragmatismo e buon senso.
Ora, che conoscere altre lingue oltre alla propria lingua madre sia una buona cosa è fuor di dubbio. È una cosa buona per le finalità di chi vuole chiedere dov’è il Pronto Soccorso in vacanza all’estero, ed è senza dubbio una cosa buona (e giustamente richiesta) per svolgere la maggior parte delle attività di ricerca, accademica e non.
La questione però assume rapidamente tratti indisponenti quando si chiacchiera con leggerezza di porre l’inglese come ‘lingua ufficiale dei dotti’ o ‘dell’élite’, come lingua in cui la ricerca, l’elaborazione concettuale, la comunicazione intellettuale e istituzionale dovrebbero naturalmente svolgersi, se non si vuole essere tacciati di oscurantismo e provincialismo.
Ecco, partiamo da una prima considerazione, ovvero dall’idea che l’inglese sarebbe una lingua facile, che perciò si presta ad essere usata come medio universale. L’inglese ha una grammatica comparativamente piuttosto semplice, ma dire che è una lingua facile è una pietosa corbelleria. Se hai bisogno di ordinare al ristorante o chiedere a che ora parte l’aereo, il basic English funziona ottimamente per raggiungere lo scopo. Purtroppo chi pensa alla lingua inglese come a una ‘lingua facile’ ha in mente quell’inglese da aeroporto che biascica la stragrande maggioranza delle persone. Ma il fatto è che la lingua inglese supplisce alle limitazioni espressive di una grammatica elementare con un vocabolario amplissimo e una fraseologia consuetudinaria enormemente ricca. Lingue con una grammatica più complessa, come quelle neolatine, germaniche o slave, hanno un vocabolario (numero di lessemi) inferiore, potendo produrre varianti espressive con altri mezzi che non siano la singola unità verbale. I lessemi registrati dall’inglese sono perciò oltre 600.000, laddove quelli delle lingue neolatine, germaniche o slave oscillano tra i 200.000 e i 300.000.
Peraltro, l’inglese è definibile come una lingua unitaria solo nel senso del ‘globish’ da fast food di cui sopra: le varianti ‘regionali’ in inglese sono varianti nazionali, spesso inintelligibili tra parlanti anglofoni di paesi diversi. Una vecchia battuta britannica recita: “L’Inghilterra e gli Stati Uniti sono due paesi separati dalla lingua che parlano”. L’inglese degli scozzesi non è quello dei neozelandesi, quello degli inglesi non è quello dei texani, ecc. Così, quando si parla a cuor leggero dell’inglese come ‘lingua franca’ in effetti si sta promuovendo a lingua intellettuale generale un idioletto semplificatissimo, che rappresenta una sorta di minimo comune denominatore del parlato corrente delle innumerevoli varianti nazionali dell’inglese.
Questo inglese che si vorrebbe universalizzare è insomma una robetta grezza e ottusa, straordinariamente povera, e del tutto inadeguata a veicolare alcun pensiero che non sia scontato.
Di fatto, l’inglese come lingua nel pieno possesso delle sue facoltà espressive è una lingua raffinatissima, con un vocabolario immenso, capace di esprimere poesia e letteratura di altissimo livello. E, come lamentano molti amici inglesi, è anche una lingua che sempre meno persone parlano e capiscono, anche nei paesi anglofoni.
Le comparazioni quantitative sul lessico disponibile sono comunque abbastanza irrilevanti. Infatti, di norma i parlanti colti di ciascuna lingua usano intorno al 20% del repertorio linguistico disponibile. E in tutte le lingue europee il numero di lessemi usati nella quotidianità dalla maggior parte della popolazione oscilla tra le 6.000 e le 10.000 unità, che vuole dire qualcosa tra un ventesimo e un trentesimo dello spazio linguistico disponibile. Prendendo l’italiano, gli studi più recenti collocano l’uso quotidiano della lingua intorno ai 7.000 lessemi, mentre la competenza linguistica della popolazione colta viaggia intorno ai 50.000 lessemi; per una comparazione, il repertorio complessivo dell’italiano si aggira intorno ai 270.000 lessemi.
Ora, la verità è che possedere una lingua, una lingua qualsiasi, non è quella cosa che finisce quando hai in tasca un titolo di studio: è il lavoro di una vita.
Ma a questo punto bisogna aprire un secondo, fondamentale, fronte di discussione, rivolto a chi ha la tentazione di sostituire, per gli utilizzi ‘alti’, la lingua madre con una ‘lingua di scopo’ come l’inglese internazionale. Una lingua non è un vestito che si può indossare e dismettere senza che nulla cambi nella nostra personalità e nel nostro pensiero. (Naturalmente avere solo pensierini elementari e mediaticamente standardizzati aiuta a nutrire quest’impressione.) Una lingua è un abito sociale complesso, che si apprende davvero solo vivendo con altri parlanti e usandola nei loro specifici contesti di vita. Chi conosce una lingua nella forma di trasposizione uno ad uno di unità verbali dalla propria lingua ad una seconda non ha ancora neppure visto la porta d’ingresso di quella seconda lingua.
Una lingua si apprende solo entrando nel mondo articolato da essa, usandola in discussioni, atti performativi, fruizioni culturali, ecc. L’ingresso nella nuova lingua inizia solo quando si comincia a pensare in questa seconda lingua, e quando ciò accade è l’intera personalità ad essere affetta. Perciò sono facilitati nell’apprendere una seconda lingua personalità poco formate, come i bambini, o personalità che hanno una buona capacità di immedesimazione ‘recitativa’, perché in certo modo per entrare in una seconda lingua bisogna abbandonare l’ancoramento linguistico e comportamentale precedente e in qualche modo ‘fingersi’ inglese, tedesco, greco, ecc. Chi non riesce a fare questa operazione, ad esempio perché ‘si vergogna’, difficilmente va al di là di uno stadio di apprendimento elementare.
Chi pensa ad una lingua naturale come ad un vestito neutrale, da indossare a piacimento senza che nulla cambi nella propria personalità e nel proprio pensiero, ha semplicemente un’esperienza della lingua povera, meccanica, circoscritta e meramente tecnica.
Come alcuni tra i maggiori filosofi del ‘900 hanno sostenuto reiteratamente, una lingua è un mondo: non il mondo in generale, bensì un mondo specifico, non immediatamente trasponibile in una lingua differente. Quando Wittgenstein dice “Il mio linguaggio è il mio mondo”, o Heidegger parla del linguaggio come “pastore dell’Essere”, al netto di molte differenze concettuali stanno dicendo qualcosa di comune, cruciale e di spesso frainteso.
Il fraintendimento è quello che immagina la lingua naturale come una gabbia in cui saremmo rinchiusi, una gabbia che condiziona la nostra esperienza del mondo, ‘distorcendola’. Questa è una visione del linguaggio (spesso nominata come ipotesi Sapir-Whorf) ingenua e insostenibile, in quanto l’esperienza precede come fonte conoscitiva il linguaggio (altrimenti non potremmo neppure apprenderlo all’inizio), e perciò rimane sempre possibile introdurre attraverso l’esperienza (e la riflessione su di essa) innovazioni terminologiche o anche l’apprendimento integrale di una nuova lingua. La lingua dunque non è una ‘gabbia’, perché da essa si può uscire liberamente.
Una lingua è invece un abito, come camminare o andare in bicicletta, ma immensamente più complesso. Se non sai camminare o andare in bicicletta, i colori e le linee del mondo restano identici a quel che vede chi invece quegli abiti possiede. Però una volta che hai appreso quegli abiti, vedi cose che prima non vedevi, da prospettive che prima non immaginavi. L’abito linguistico è un abito peculiare: è l’abito che consente di riflettere. Ed è per questo motivo che lo spazio di gioco del tuo linguaggio è quello del tuo mondo: non del mondo sensibile, ma del mondo come oggetto di riflessione. Qualcosa può diventare oggetto di riflessione solo se e quando ci sono le parole per evocarlo. Altrimenti si può tutt’al più ‘presagirlo’, ma non lo si può afferrare concettualmente.
Nell’apprendimento di ogni linguaggio si creano unità concettuali che catturano gesti, esperienze, interazioni contestuali, tutte cose che vengono a far parte di un repertorio unico, che solo talvolta (e di solito parzialmente) ha un esatto corrispettivo in una lingua differente. A me, come a tutti quelli cui è capitato di imparare le lingue in vivo e non in vitro, vengono spesso in mente espressioni linguistiche particolarmente calzanti, con connotazioni peculiari, in lingue diverse dalla madre lingua. Talvolta cerco di tradurre queste unità linguistiche in italiano, altre volte mi rassegno a usare faticose perifrasi. E naturalmente (e molto di più) ciò mi capitava in senso inverso, parlando tedesco, inglese o greco in loco.
Ogni lingua ha capacità espressive ineludibili, il che significa potenzialità e limiti. E tali capacità espressive sono anche capacità di maneggiare riflessivamente concetti. Fare lo sforzo di apprendere altre lingue può dare accesso ad aspetti e prospettive cui non si faceva prima attenzione, e spesso può permettere di recuperare nella propria lingua madre espressioni divenute desuete, appartenenti a quel patrimonio maggioritario che non usiamo. Oppure può suggerire la creazione di neologismi. Sono tutti fattori di crescita altamente raccomandabili.
Tuttavia l’idea di imporre l’inglese internazionale, sradicato e impoverito, come lingua della ricerca, dell’elaborazione, della riflessione intellettuale è un’urtante sciocchezza, che combina tre fattori esiziali.
In primo luogo, questa prospettiva conduce il pensiero a usare uno strumento grezzo, di capacità estremamente limitate, che esclude dal novero di ciò che è degno di riflessione tutto ciò che non sia già in qualche misura ovvio ed aproblematico. (Ogni forma di pensiero che esula dal canone dei parlanti globish viene infatti percepito da questi ultimi come ‘inutilmente sottile’, ‘oscuro’, ‘arzigogolato’.)
In secondo luogo, ciò tende a ridurre la pluralità di prospettive (e di forme di vita) possibili, incentivando il prosciugamento delle risorse linguistiche in tutte le lingue naturali (tutte, incluso l’inglese di alto livello). Bisogna infatti ricordare che, piaccia o meno, lo spazio linguistico maggiore viene mantenuto in vita da chi si dedica a mestieri ‘intellettuali’. Se gli intellettuali riducono lo spazio di ciò che è pensabile e dicibile, nel lungo periodo ciò si riflette sull’intera lingua, parlata ad ogni livello, giacché c’è sempre un processo continuo di permeabilità tra ‘lingua alta’ e ‘lingua quotidiana’.
Infine, un’operazione del genere, già in effetti in corso da tempo, rappresenta l’ultimo atto di quella colonizzazione culturale angloamericana avvenuta sulla scorta degli esiti della Seconda Guerra Mondiale. Che ciò sia promosso consapevolmente o meno è irrilevante. Di fatto la catastrofe militare della prima metà del ‘900 ha ridotto drasticamente l’autonomia intellettuale e culturale dei popoli europei. Ciò che spesso viene chiamato (con discutibile semplificazione) ‘pensiero unico’, è in effetti una pura e semplice trasposizione del modello concettuale prevalente nella tradizione angloamericana all’intero mondo occidentale. Scientismo, obiettivismo, riduzionismo, liberismo non sono pensieri disincarnati, senza patria né tradizione: sono tratti costitutivi di specifiche tradizioni culturali, che si sono trasformate in luoghi comuni globali grazie ad un’opera di colonizzazione culturale sistematica, di cui l’inglesizzazione forzosa del pensiero (nelle suddette forme semplificate) rappresenterebbe semplicemente il compimento ultimo. (Incidentalmente, Thatcher e Reagan non erano né Inuit, né Papuasi).
Dunque, in conclusione, ciò che ci troviamo a dire è che l’accusa iniziale va precisamente capovolta: è chi preme perché tutti si pensi e discuta nel suo inglese da pausa caffé ad essere tragicamente provinciale. Si tratta di emuli inconsapevoli e presuntuosetti dell’Americano a Roma di Sordi. Solo che oggi non fanno più ridere, perché hanno il potere o lavorano per chi ce l’ha.
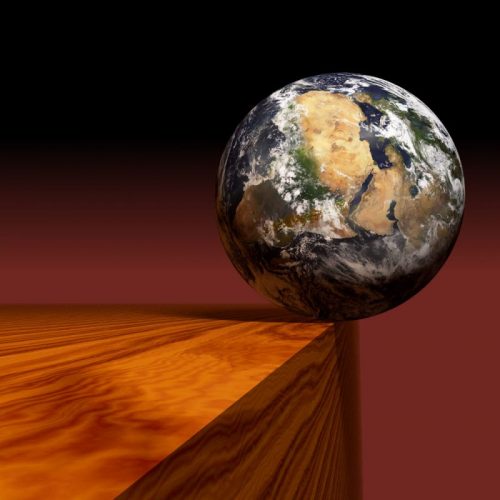
Ho trovato questo articolo davvero aureo. Se posso dire la mia, nell’anglofilia qui ben sviscerata vedo due tipi di provincialismi ch si potrebbero distinguere. Il primo è appunto l’alberto-sordità della nostra classe dirigente (dalla politica al giornalismo) che fa un uso immotivato di anglicismi (spesso pseudoanglicismi o decurtazioni all’italiana ridicole) in un ibrido, definito itanglese, che sta distruggendo i connotati storici della lingua italiana. Si tratta di un fenomeno da mettere in correlazione forse con la scarsa conoscenza dell’inglese: meno lo si padroneggia e più lo si ostenta (dall’awanagana di Sordi al jobs act e al navigator) nei “mischioni”; chi conosce bene l’inglese tendenzialmente non lo mescola o comunque lo usa a ragione.
Il secondo aspetto che riguarda l’inglese come lingua franca della scienza come lo fu il latino si basa su un falso storico. Il latino fu soprattutto la lingua dei teologi, e la scienza che molti fanno nascere con Galileo coincide anche con la scelta di usare l’italiano a partire dal “Dialogo sui massimi sistemi”, scelta con qualche precedente meno eclatante come quello di Tartaglia, ma poi divenuto un modello per scienziati come Redi, Vallisneri o per es. Spallanzani, che nel ‘700 confutò le teorie sulla generazione spontanea di uno dei massimi scienziati dell’epoca, Buffon, che a sua volta scriveva in francese, perché la nascita e lo sviluppo delle scienze fu soprattutto nelle lingue locali, non solo in latino. Fuor dalla scienza, perciò, il latino medievale e l’inglese globale odierno hanno in comune il fatto di essere l’espressione di due forme di colonialismo, quello religioso e quello odierno dell’angloamericano che ha il suo nuovo dio nei mercati e nell’espansione delle multinazionali. Un saluto.
Concordo, con un’unica precisazione: il latino medievale, più che una sorta di effetto ‘coloniale’ della religione di Roma era il lascito della grande tradizione latina imperiale, come essa si era conservata presso i ‘chierici’, le classi colte in ambito monastico. Non era dunque una ‘lingua d’importazione’. Si trattava inoltre di una lingua che conservava molte caratteristiche del latino classico, con in più la sua ipostatizzazione in forma di sola cultura ‘alta’: era dunque lingua teologica, giudirica, ed anche letteraria, ma non quotidiana. L’analogia con il moderno globish è perciò nulla.
Credo che nella ricostruzione storica si dimentichi che qui non siamo nell’analogo temporale della situazione del latino (che dovremmo chiamare “italiano antico”) medievale, bensì della lingua della Roma Imperiale, ergo dell’Impero anglofono (USA+UK) che, esattamente come nel periodo della Roma imperiale, distruggerà o ridurrà a meri dialetti tutte le altre lingue.
Il passaggio dalla vecchia tipologia degli Imperi dei territori e dei corpi a quella nuova di Imperi delle Menti basata sulla dominazione linguistica è stata chiaramente espressa fin da 1943 nella sintonia teorica Roosevelt-Churchill e da me rintracciata nel discorso di quest’ultimo ad Harvard il 6 settembre di quell’anno.
«Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non il togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. Gli imperi del futuro sono quelli della mente».
«The power to control language offers far better prizes than taking away people’s provinces or lands or grinding them down in exploitation. The empires of the future are the empires of the mind».
Winston Churchill – in dialogo con Roosevet – Università di Harvard, 6 settembre 1943.
http://youtu.be/ohe-6E2L3ks