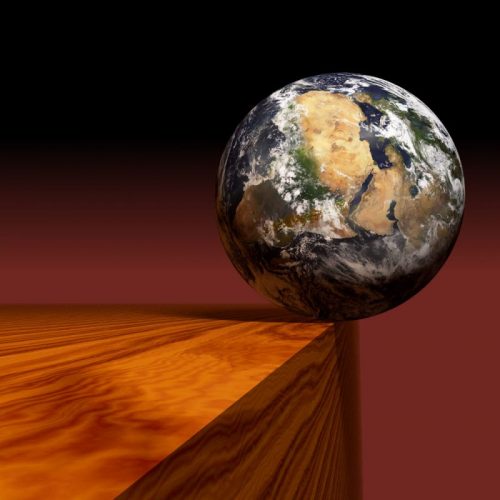Personalmente ho sempre rigettato l’odio di classe, non ho cioè mai accettato l’idea che le divergenze di interessi che dipendono da diversi livelli sociali andassero prese come ostilità fondamentali, antropologiche. Dopo tutto, molti di coloro che consideravo il sale della terra, poeti e condottieri, musicisti e filosofi, pittori e romanzieri, erano stati di origini alto-borghesi o aristocratiche, e mi era inconcepibile trattarli come ‘nemici’ da odiare. Peraltro, anche crescere in un periodo storico (anni ’70) in cui la tradizionale nettezza delle separazioni di classe si era attenuata rispetto al passato ha contribuito a sfumare il tema delle ostilità di classe.
Non trovo ragioni oggi per cambiare idea su quel punto, tuttavia credo che ci sia un senso in cui quel tema vada ripreso. Nel mondo odierno dove le classi non sono distinte da titoli o pedigree non ci sono linee nette da rintracciare, tuttavia le differenze di classe pesano in modo massiccio. Quando nel corso di discussioni politiche ci facciamo latori di posizioni che promuovono l’eguaglianza di possibilità, che stigmatizzano i meccanismi polarizzanti del capitale, o che sostengono l’idea di una sovranità democratica e popolare dobbiamo sempre ricordare che vi è un ceto apicale che è istintivamente avverso ad ogni discorso del genere, a prescindere da ogni buona ragione che puoi menzionare; e con tali gruppi ogni mediazione è e resta di fatto impossibile. Peraltro tale ceto, potente ma ristretto, si può giovare del supporto di coloro i quali, pur non facendone parte, sperano un giorno di entrarvi. (Si diceva un tempo, che gli americani tendono ad avversare le idee socialiste perché lì ogni morto di fame si crede un milionario in temporanea difficoltà).
Questi ‘ceti superiori’, e ciò che rappresentano nella società contemporanea, pongono però alcuni problemi che sono un unicum storico e antropologico. In tutti gli ordinamenti sociali ‘premoderni’ troviamo differenze tra ceti superiori e inferiori. Marx era incline a vedere questi interessi in conflitto come una costante nella storia, e aveva buone ragioni per accentuarne la continuità. Ma c’è un’ottica da cui è invece la discontinuità che deve essere sottolineata.
Come lo stesso Marx talvolta ricorda, nella storia la miseria della grande maggioranza è stata spesso condizione necessaria per l’agio di una minoranza. Questo modello di diseguaglianza di ceto attraversa tutta la storia dell’umanità, e se da un lato presenta aspetti di ovvia ingiustizia, dall’altro aveva in sé aspetti per cui poteva essere giustificato, anche in un senso ‘universalistico’. Le condizioni di agio delle classi possidenti, delle ‘aristocrazie’, delle ‘corti’, della ‘borghesia’ che vi stava attorno seguiva un modello paternalistico. Secondo tale modello il ‘superiore’ aveva in proprio diritti e privilegi inequivocabili, ma aveva anche ambizioni e obblighi universalistici. L’ideale di quel modello classico è lo stesso, tardivamente vagheggiato da Nietzsche, dove un ceto superiore giustifica l’esistenza propria, e anche quella del ceto inferiore, attraverso la sua forma di vita superiore, superiore per cultura, educazione, creatività, spiritualità, finezza d’animo. L’otium connesso all’agio di una minoranza era qui precondizione per fornirvi le condizioni di pensare e vivere al di sopra delle necessità immediate.
Le classi elevate si ponevano perciò come una sorta di ‘avanguardia dell’umanità’, capaci di esplorare dimensioni precluse ai più. Va notato che ciò implica una percezione del proprio privilegio come qualcosa di empiricamente esclusivo, ma di principio universalistico: i ceti superiori nella storia, con rarissime eccezioni, interpretavano la propria collocazione davvero come un ‘compito’, come un ‘dovere’ di nascita, in cui rientrava l’idea, caratteristicamente paternalistica, di doversi ‘prendere cura’ degli inferiori. Essi dunque si percepivano come parte privilegiata di un intero umano.
Se, quanto, o quali aristocrazie storiche siano state all’altezza di questa idealità è questione su cui non ci interessa soffermarci, ma ciò che conta è che tale modello un senso universalisticamente intelligibile ce l’aveva: i ‘molti’ rappresentavano il concime, maleodorante ma necessario, su cui le oligarchie potevano vivere gradi di libertà superiore, libertà che talvolta generava fiori di grande bellezza. La storia della cultura umana premoderna è storia di oligarchie costituite da possidenti, su base ereditaria e/o bellica, e del loro entourage: in questo spazio sociale trovavano spazio la maggior parte delle personalità che oggi meritano la nostra memoria.
Comunque si giudichi quel modello, la sua razionalità ideale è chiara, ed è perfettamente comprensibile come il ‘popolo’ sognasse di poterne far parte (i racconti su figli di nobili, allevati come figli del popolo, e infine riconosciuti come aristocratici, sono un topos della narrativa popolare).
Per un certo tempo la nuova borghesia capitalistica, subentrata alle oligarchie aristocratiche precedenti, ritenne di far proprie quelle pretese, cercando di coltivare la cultura e le arti, e anche di preservare la tradizione del mecenatismo. Questa fase, che copre il periodo dalla fine del ‘700 ai primi del ‘900 è stata perciò una fase particolarmente prolifica, in cui il permanere della stima verso gli ideali aristocratici si univa all’ampliamento della base sociale di chi poteva accedere all’alta cultura. In questo periodo, peraltro, emerse in modo manifesto nell’elaborazione culturale stessa l’insanabile contrasto tra gli ideali classici (e le loro ambizioni spirituali), e la pochezza delle nuove ‘virtù borghesi’.
Ma il mondo contemporaneo, quel mondo emerso da mezzo secolo a questa parte, presenta caratteristiche nuove. Esso ha tagliato i ponti con ogni riferimento e radicamento in quella visione aristocratica premoderna. I ‘ceti superiori’ odierni hanno rinnegato l’otium classico e non vogliono né possono concepirsi come ‘avanguardia dell’umanità’, come punta avanzata del pensiero, della bellezza, come ambizione spirituale idealmente rivolta all’universale. Si tratta di una forma di vita che coltiva ed incentiva soltanto l’oculatezza dell’investitore, il calcolo costi-benefici, la prudenza come risvolto della paura. È caratteristica la virtuale scomparsa del mecenatismo, nonostante le disponibilità di capitalizzazioni liquide inoperose abbiano una dimensione sconosciuta a qualunque altra epoca della storia; il mecenatismo rimasto è solo quello fatto come ‘investimento in immagine’, che è ovviamente l’opposto dello spirito della gratuità e dell’otium.
Paradossalmente, mentre il benessere aristocratico era latore di sicurezza e con ciò di un atteggiamento ben disposto verso la gratuità, l’eccedenza, l’impiego non utilitario dell’ingegno, il benessere capitalista contemporaneo è comunque parte di un mondo in cui l’instabilità coinvolge potenzialmente chiunque. Questo perché l’unico fattore stabilizzante, di difesa, è appunto la disponibilità di capitale. L’aristocratico d’un tempo poteva perdere la propria posizione solo disonorando il proprio status o per una radicale disfatta militare, ma a fornire un esteso cuscinetto sociale a garanzia della propria sicurezza vi era l’intorno delle proprie lealtà sociali. Anche il plebeo, il contadino, pur esposto alle fragilità della propria condizione economica precaria, poteva affidarsi come fattore di sicurezza ad un intorno sociale consueto e affidabile. Ma questa dimensione di sicurezza ontologica, di agio, di solidità esistenziale oggi è inattingibile anche ai vertici della piramide economica mondiale, che sono al sicuro soltanto fino a che preservano una sufficiente barriera di capitale tra sé e il mondo: sono sciacalli dorati attorniati da altri sciacalli, che non rappresentano una barriera verso l’esterno, ma una minaccia verso l’interno.
Qui cominciamo a vedere quale sia in ultima istanza l’autentica inaudita miseria dell’epoca contemporanea. Ciò che la caratterizza come un unicum è infatti il dato di fondo che qui gli animi intelligenti, sensibili, dotati di ambizione spirituale semplicemente non desiderano essere al vertice della piramide. Tutti naturalmente si augurano prosperità economica, come mezzo per vari fini, ma questo non è volere la forma di vita esemplificata dai ceti superiori. Questa è l’epoca triste in cui i ‘migliori’, gli ἄριστοι, non possono volere il vertice di comando (la κρατία).
Ad ambire alla vetta della piramide socioeconomica, ad essere disposti a ‘fare quello che è necessario’ per arrivarci e restarci, restano individui che non formano un ceto, ma sono solo accomunati da alcune caratteristiche psicologiche, e nello specifico da elevati gradi di frustrazione precoce cui si correla un tenace desiderio di rivalsa. Solo una peculiare forma di cura autoreferenziale di sé, di visione di corto respiro, e di vuoto desiderio di rivalersi (di ‘fargliela vedere’) può alimentare il tipo umano disposto a tentare la scalata alla vetta della piramide. Né questi, né coloro i quali sono già in vetta e si ingegnano a rimanervi, sono necessariamente ‘incolti’. Non è questo il punto. La cultura autentica non c’entra se non marginalmente con l’essere stati esposti a ciò che il convento passa come ‘alta cultura’. La cultura esiste solo quando è animata da passione, dedizione, ammirazione, progettualità ideale, cioè solo quando è l’atmosfera motivazionale primaria in cui ci si muove. Perciò chi concorre oggi al vertice della piramide ne è escluso: perseguirla è infatti un impedimento fatale verso quell’obiettivo.
Questo, in ultima istanza, è il male più profondo del sistema sociale in cui viviamo, quello da cui gli altri mali dipendono. Miseria, violenza ed ingiustizia ci sono oggi (deludendo le mille promesse in senso opposto) ma si può dire che, dopo tutto, in varia misura, ci sono sempre state. Ad essere unico qui è un sistema in cui i migliori non possono desiderare di dominare, di stare in vetta, giacché tale sistema tende a conferire le leve apicali del potere (economico) a gente da cui nessuno comprerebbe un’auto usata.
Questi moderni ‘ceti superiori’ hanno la forza della propria pochezza: non tengono a nulla di reale in modo sufficientemente saldo da non poter essere oggetto di negoziazione, transazione, aggiramento. Non presentano le rigidità, le pretese o la compattezza di un’aristocrazia, e perciò possono trasformarsi opportunisticamente presentandosi in qualunque forma sia utile a preservare o accrescere la propria fortezza censitaria, il proprio capitale. Sono perciò più pericolosi di qualunque altro ceto dominante nella storia, proprio perché ciò che li accomuna non è alcun valore positivo, alcuna visione del mondo e dell’umanità, ma soltanto il galleggiamento autoperpetuantesi. È per questa ragione che queste nuove élite possono serenamente disinteressarsi di ogni tipo di conseguenza: per popoli, nazioni, ambienti, culture, generazioni future. Non sono infatti accomunate da niente se non dall’autoperpetuazione di un ‘potere d’acquisto’ di diritto (non è neppure importante che davvero conduca al consumo o alla fruizione).
Ecco, nei confronti di questo gruppo sociale, di questa ‘classe’, chiunque abbia a cuore una forma di vita democratica o semplicemente umana, deve imparare a parlare in termini forse non di odio, ma certo di ostilità antropologica, di inimicizia irrevocabile. Perché qui davvero non ci sono, né mai ci saranno margini di mediazione.