Come nota Foucault in un passaggio de “La nascita della biopolitica“, la massima del liberalismo è ‘vivere pericolosamente’. Lo è verso il basso, sul piano delle pulsioni economiche primarie, e lo è verso l’alto, sul piano dell’incentivazione ideologica nobilitante.
Sul piano dei meccanismi economici, i meccanismi di mercato sono meccanismi che si appellano espressamente al motivante primario della paura, dell’insicurezza. La sicurezza per il modello liberal-capitalistico è male, perché è latrice di ozio e inerzia, è stagnazione. Dai suoi inizi il liberalismo economico ha mosso guerra ad ogni forma di sicurezza e appagamento, visti come il viatico di gravi colpe morali, di pigrizia e neghittosità.
Si vede in controluce come gli strati sociali presso cui questa visione si impone siano sin dall’inizio strati privilegiati della popolazione, abituati a interagire con strati subordinati, asserviti. Infatti l’inerzia è la tipica gioia dello schiavo o del servo, di chi, non avendo una volontà che gli appartiene, trova il proprio principale spazio di soddisfazione nel sottrarsi al comando, alla coazione a lavorare.
Le prime crisi di disoccupazione all’alba della Rivoluzione Industriale vennero subito categorizzate infatti come epidemie di pigrizia e indolenza, la cui cura poteva essere solo una sottrazione delle tutele tradizionali (come il soccorso delle parrocchie inglesi agli affamati). Il borghese vedeva nella proverbiale pigrizia del povero, del servo – ma anche nell’otium aristocratico, attivo, ma improduttivamente dedito alle arti (e agli artifizi) – il segno di un’incomprensibile e maligna tendenza umana. Non c’è mai stato in questo ambito alcuno spazio per un esame serio dei motivanti umani: si è trattato invece di confezionare rapidamente una condanna che permettesse, di rimando, di rivestire d’una nuova aura nobile il commercium, l’indaffararsi, il ‘business’.
Una volta concepito l’umano come naturalmente pigro, a meno che non venga sottoposto al ricatto maggiore, alla morte per fame, tutto il resto del lavoro consisteva nel cercare di implementare quanto meglio possibile questa visione, che è rimasta in tutto il pensiero liberale come retropensiero fondante, una convinzione mai più rimessa in discussione.
La storia delle classi dirigenti liberali è costantemente combattuta tra due istanze. Da un lato c’è la citata istanza ‘antropologica’, che preme per creare le condizioni di ricatto più dure possibile per i non abbienti, che altrimenti, per natura, rimarrebbero inerti. (Questo è quel tipo di pensiero che fa capolino in espressioni come quelle del compianto Padoa-Schioppa, quando lamentava che le protezioni sociali del XX secolo avessero “progressivamente allontanato l’individuo dal contatto diretto con la durezza del vivere”). Dall’altro lato, questa pressione deve fare i conti con i moti di ribellione, alle esplosioni di insofferenza rispetto a tale pressione, in quanto il sistema produttivo ha bisogno di stabilità, ed eccessive turbolenze incidono sui profitti. Nel bilanciamento tra massimo accrescimento possibile dell’insicurezza individuale, e minimizzazione della turbolenza sociale, si gioca lo spazio di manovra delle politiche liberali sul piano delle motivazioni ‘verso il basso’.
——————–
Ma c’è poi una seconda dimensione, per così dire ‘verso l’alto’, che concerne l’incentivazione ideologica. È chiaro che la dimensione di ricatto verso il basso può funzionare appunto soltanto per i ceti inferiori, ma è una motivazione insufficiente per chi si allontani abbastanza dalla minaccia primaria da non correre più quel rischio. Questo è il piano dove deve trovare spazio l’ambizione, la volontà spontanea di fare. Ed è qui che l’antropologia liberale si trova teoricamente in maggiore difficoltà, perché non ha per essenza alcun valore guida, alcun contenuto da realizzare, alcuna visione ideale della società o del mondo da proporre. Che fare, dunque, per mantenere motivati e attivi questi depravati degli umani?
Qui l’appello all’insicurezza, l’invocazione della paura, deve prendere forme diverse. Ci si richiama allora all’orgoglio personale, che viene sollecitato nella forma del ‘coraggio’, dell’amore del rischio. Tutta l’ideologia liberale decanta senza interruzione, e in ogni contesto, concetti come ‘sfida’, ‘scommessa’, ‘rischio’, ‘avventura’, ‘intrapresa’. E a chi avesse il cattivo gusto di chiedere a che pro cotanto scapigliato eroismo in giacca e cravatta, si ribatte con un gesto di rilancio che oblitera la domanda: ci si batte per ‘superare i limiti’, per ‘abbattere le barriere’, e soprattutto per ‘vincere’. Vincere che? Non ha importanza. Se vinci non sei un ‘perdente’,e tanto basta. Il punto non è la finalità della vittoria, ma la vittoria in quanto tale, il rapporto di priorità comparativa rispetto ad altri.
Ci si appella dunque ad una dimensione competitiva primaria, infantile, che viene però costantemente rinforzata, in quanto i ‘vincitori’, per quanto inane sia il gioco, sono comunque premiati (e dunque imparano la fruttuosità della competizione).
In questo quadro l’eroe per eccellenza è lo scommettitore, colui il quale ‘si gioca tutto’, quello che ‘ama il rischio’ (gambler). Il ‘coraggio’ è sempre stato considerato una virtù, ma nella concezione del rischio liberale avviene una mutazione genetica della tradizionale lode per il coraggio. Il coraggio nella storia (e nel mito) viene lodato come espressione dell’eroe, di colui che si batte per un fine che lo trascende, e che porta benefici alla collettività.
Nell’amante del rischio liberale di quella configurazione morale rimane solo lo scheletro emozionale, mentre il suo senso si ribalta: l’amante del rischio rischia da solo e rischia per sé solo; e il fine dell’assunzione di rischio è del tutto irrilevante, in quanto nel migliore dei casi tale fine è l’acquisizione di un vuoto mezzo (il mezzo per un fine generico, cioè il denaro). È questa temperie culturale che produce i ‘Gordon Gekko’ e i milioni di loro emuli, i sudaticci eroi dei nostri tempi.
L’amante del rischio, va notato, può permettersi eticamente questa disposizione di strutturale temerarietà nella misura in cui nessuno dipende da lui. Infatti il baldo scommettitore che, scommettendo, si giocasse la vita altrui, rimane, persino per la nostra moralità claudicante, semplicemente un farabutto. Il padre di famiglia (o la madre sola) che volesse giocare al gioco del ‘coraggio liberale’, mettendo a repentaglio il pane dei figli non riesce (almeno non ancora) a risultare una figura lodevole. Ma ciò ha un’ovvia ricaduta.
Questo modello di eroismo, di amore per il rischio e la sfida, per quanto sia promosso come modello generale, valevole e motivante per tutti, è in verità un gioco riservato a selezionate minoranze: da un lato a predatori solitari che non hanno niente da perdere, e dall’altro a giocherelloni che cadranno sempre in piedi, perché qualcuno li trarrà dagli impicci.
Insomma, gli eroi del nostro nuovo mondo coraggioso presentano un profilo di principio ben definito, corrispondente a due categorie ideali: gli psicopatici e i figli di papà (se entrambe le cose, meglio).
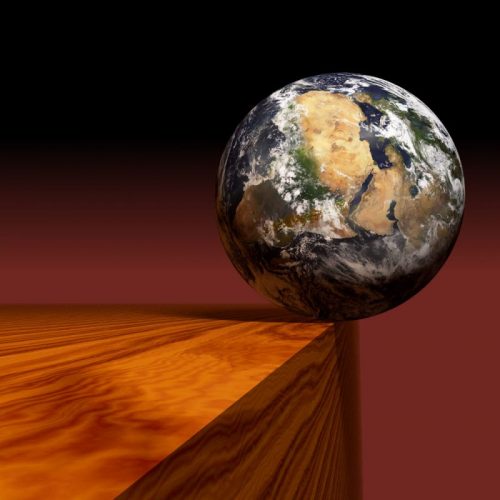
Sono le 7 e 52 di un sabato mattina, per puro caso mi sono imbattuta nel tuo sito, e ho letto il primo scritto che mi si è presentato al aprirlo. Risveglio duro, come una secchiata di acqua gelida che poi, però, ad osservarla bene, è piacevolmente calda. Articolo illuminante.
Una piccola osservazione a latere. Relativamente ‘all’otium’ aristocratico ho l’impressione che uno spolvero di invidia sia rimasto a tutt’oggi da parte della casta ‘vaishya’ rispetto agli ‘kshatriya’ (i nobili, quelli rimasti – le caste sussistono, anche se rivestite dalle tassonomie syloslabiniane contemporanee e successive osmosi). Il sigillo vendicativo dell’aura nobile dal subordinato : “quello sì che è un vero Signore”, è duro a morire. A parte il fustigante PadoaSchioppa, un Aurelio Ambrogio (poi fatto santo) in sedicesimo, ai primi viene comunque in soccorso l’escatologia protestante.
Leggo sempre con interesse i suoi scritti.
“Occorre proporsi un rinnovamento costante per giungere ad un’apertura spregiudicata a tutte le istanze progressive, accettando una situazione precaria e feconda in un’incessante ricerca collettiva delle possibilità di sviluppo e di crescita, spezzando le remore, rovesciando le strutture acquisite, rivoluzionando le forme accettate per aprire nuovi orizzonti d’indagine, sollecitando contributi costruttivi a un ridimensionamento che metta in crisi le categorie e le abitudini, protendendosi verso esperienze sociali sempre nuove in una accettazione consapevole delle inquietudini e dei rischi di una rimessa in questione dei princìpi statici, sì da superare le preclusioni aprioristiche, le chiusure sterili, allargando la partecipazione a tutti i livelli in vista di una revisione basilare degli schemi, in uno slancio generoso e con impegno incessante e sofferto volto a distruggere le barriere, le caste chiuse, le vischiosità antistoriche che impediscono la libera crescita e l’innovazione sociale, educando a un ripensamento critico che sciolga le cristallizzazioni fissiste, i residui metafisici e formalistici, con una rivoluzione radicale che si ponga all’avanguardia in una ricerca di nuovi moduli tecnici che permettano di uscire dall’ìmmobilismo e di riprendere la marcia in avanti in un clima di lavoro comune per liberare dalle istituzioni ormai superate attraverso uno scavo che permetta la enucleazione via via verificata delle finalità provvisorie che devono emergere dal farsi stesso, dal libero confronto sociale e dallo stimolo che dalla situazione concreta riceveranno gli operatori impegnati nel lavoro di riforma e di rielaborazione dialettica, in un dinamismo vitale che sgretoli gl’indugi estetistici e immobilistici in un’assunzione deliberata di ipotesi e di valori sempre drammaticamente precari, ripartendo da zero, con uno slancio ottimistico, accettando il confronto vivo, la sfida dell’ambiente in trasformazione, ricacciando le tentazioni oscure del mito e del dogma”.
Gazzette e libri moderni sono commenti fedeli a questa filastrocca, i romanzi stessi ne sono ormai incarnazioni figurali, e a furia di tendersi secondo questi comandamenti le arti figurative si sono contorte in materia informe. In questo fluire monotono s possono lasciar cadere aleatoriamente anche le più nobili parole: prenderanno un aspetto equivoco, si corromperanno. Così nella filastrocca citata si può infilare a caso, “valido”, “validità” (fu consueto per un ventennio) e prenderà il senso di “avente corso” provvisoriamente; oppure “attuale”, ma vi smarrirà l’antico significato di compiuto, di possibilità tramutata in evento perfetto nella sua specie, per diventare sinonimo di “effimero”. E “umano” significherà “empio”; “sociale” significherà “antimetafisico”. Basta che la parola esprima una negazione: il ripudio del criterio di discriminazione tra bene e male e la rinuncia a precisare la causa finale: tutto dev’essere un fluire, un incalzare che non si sa dove vada a parare, una corsa nella notte; bene è il correre, male è soffermarsi, malissimo voler sapere dovesi va e perché ci si vada. La ‘divinità’ lo vuole, ma non si esprime emanando questo comandamento, perché, essendo tutta negativa, si deve presentare in modo tutto affermativo. Essa innalza sull’altare fatti umani, mortali, provvisori, oggetti che suggeriscono la polemica, la discussione, la labile contemporaneità, la ricerca che ‘inquieta’, l’esperimento ‘sofferto’, e ci si domanda come possano non uccidersi i suoi seguaci, i quali sotto questo orribile imperio non hanno più motivo di procreare, se alle generazioni future non hanno nulla da trasmettere che non sia condannato a farsi superare; non hanno motivo di edificare, se ogni cosa sussistente va demolita e rifatta (…).
Caro Andrea, mi hai fatto tornare in mente questo breve stralcio di un magistrale Elemire Zolla, d’annata (’68).
Ottime riflessioni sull’antropologia del liberalismo.
Qui alcuni spunti che riprendono le sue analisi:
https://orizzonte48.blogspot.com/2020/02/il-pluralismo-nellera-post.html