Una parola inattuale
- Tra i termini che godono di cattiva stampa nella riflessione etica e politica contemporanea vi è certamente il termine “identità”. Espressioni come “rigurgiti identitari”, “politiche identitarie” o lo stesso termine “identitarismo” hanno una chiara connotazione reazionaria, assimilata alle posizioni di partiti di estrema destra. Questo non è un mero fraintendimento, né propriamente un errore: il ricorso politico alla nozione di identità, in particolare nella versione dell’identità come matrice del nazionalismo, ha una storia nel migliore dei casi discutibile, spesso semplicemente indifendibile. L’identitarismo nella forma nazionalistica si è manifestato nel corso del ‘900 frequentemente secondo linee xenofobe e razziste, producendo politiche internazionali aggressive, e politiche nazionali autoritarie. In questo senso è ben giustificato mantenere un’elevata vigilanza etico-politica quando si manipola l’idea di identità, vistone il potenziale distruttivo.
Lo sfondo storico
- E tuttavia raccontare la storia della nozione di ‘identità’ in senso etico-politico a partire dalle degenerazioni della prima metà del XX secolo è una scelta comprensibile, ma anche fuorviante. Il radicalismo identitario che si ritrova prima nel nazionalismo e sciovinismo che precede la Prima Guerra Mondiale, e poi nelle dittature che condurranno alla Seconda, non è una bizzarra abiezione nata dal nulla: si tratta di una reazione storica a dinamiche socioeconomiche fino ad allora inedite. È l’allentarsi della capacità degli Stati Nazione di dare risposte efficaci alle dinamiche della ‘prima globalizzazione’ (1870 – 1914) a generare una reazione rabbiosamente identitaria, in particolare nella piccola e media borghesia europea, che si ritrovò minacciata dalle prime forme di competizione internazionale con ribassi insostenibili, e dalle prime forme massicce di libero spostamento dei capitali. Lo sfociare della competizione economica tra paesi europei in competizione coloniale (imperialismo) e poi in guerra mondiale è una dinamica che può considerarsi acclarata (anche se naturalmente nell’infinito dibattito sulle ‘origini della Prima Guerra Mondiale’ entrano moltissime altre componenti, dal sistema dei trattati segreti, al bellicismo prussiano, al revanscismo francese dopo la battaglia di Sedan, ecc. ecc.).
- Guardare al quadro più comprensivo non serve a giustificare le degenerazioni nazionalistiche del ‘900, ma serve a comprendere come il problema dell’identità (qui come identità nazionale) vada inteso non come un mero ‘errore contingente’, in cui non ricadere, ma piuttosto come il problema di un’esigenza profonda che rifiuta di essere messa da parte.
Identità personali.
- Per comprendere il senso assiologico dell’identità è utile fare una breve premessa riferita non alle identità collettive, bensì all’identità personale di ciascuno di noi. Il tema della definizione dell’identità personale è tema complesso e molto discusso, e sarebbe impossibile riassumerne qui anche solo le diramazioni principali [me ne occuperò a breve in forma monografica]; ciò che si può provar a fare è fornire un quadro assertorio che renda intuitivo il senso dell’identità per ciascuno di noi.
- L’identità personale non è un dato di fatto, non corrisponde ad un’entità empirica. È notoriamente arduo trovare una qualche collezione di attributi che rimangano tutti costanti nel corso dell’esistenza di un individuo e che perciò lo definiscano come dotato proprio di quella identità e non di un’altra. Ed in ogni caso tale collezione sarebbe tutt’al più la nostra identità come oggetto per altri, non la nostra identità per noi stessi. Le nostre conoscenze, le nostre capacità, le nostre idee, e anche la materia del nostro corpo, cambiano in modo radicale nel percorso che va dalla nostra nascita alla nostra morte. Non c’è alcun fatto materiale, e neppure alcun insieme circoscritto di credenze, cui potremmo far corrispondere univocamente la nostra ‘identità’. Neppure la continuità della nostra memoria di noi stessi (cfr. Locke) definisce adeguatamente la nostra identità, perché il punto chiave è che, per quanti ‘buchi’ la nostra memoria abbia, noi sappiamo sempre che ciascuna nostra memoria è appunto nostra: appartiene a ciò che siamo, siamo stati e vogliamo essere.
- Ma per quanto apparentemente sfuggente sia la nostra capacità di circoscrivere obiettivamente cosa conti come nostra identità, tuttavia la nostra identità percepita è qualcosa cui teniamo intensamente, qualcosa che difendiamo quando minacciata, che perseguiamo con tenacia, che cerchiamo nel tempo di consolidare sulla scorta di modelli o ideali molteplici, e che soffriamo quando viene incrinata (ad es. da malattie neurodegenerative, amnesie traumatiche, ‘lavaggio del cervello’, ecc.). L’identità personale di fatto implementata è qualcosa di mobile, di costruito, sia pure non arbitrariamente, sulla base di inclinazioni spesso abbastanza generiche, è qualcosa di diveniente nel tempo, ma al tempo stesso è qualcosa per cui combattiamo vita natural durante, cercando la nostra sfera di autonomia, ‘diventando grandi’, ‘diventando qualcuno’. La nostra identità non ci è regalata da nessuno, ma è oggetto di contenzioso e talvolta di compromesso. Ogni decisione, ogni rammemorazione, ogni autonarrazione ed ogni progetto sono momenti in cui ne va della costituzione della nostra identità che definisce anche il nostro senso. Anche se potremmo avere grandi difficoltà a spiegare cosa c’è esattamente di comune tra il noi stesso che ricordiamo all’asilo o sui banchi di scuola e il noi stesso maturo, o anziano, noi sappiamo che quella continuità di senso rappresenta precisamente un’identità, la nostra identità: ciò che in definitiva siamo e vogliamo continuare ad essere. Solo la nostra identità personale nel tempo rende sensate cose come l’assunzione di responsabilità, la formulazione di promesse o impegni. È solo perché io assumo di essere lo stesso che ero ieri, e che sarò domani, che posso farmi carico di quello che ho fatto ieri (essendone lodato o rimproverato) e impegnarmi o promettere di fare (o essere) qualcosa domani. Solo in questa dimensione identitaria esistono sentimenti come il rammarico o la speranza, la vergogna, il pentimento o l’orgoglio. La nostra identità dunque non ci si dà mai come una serie di realtà fattuali, per quanto sia importante per noi produrre queste o quelle realizzazioni, ma si presenta piuttosto come quell’orizzonte di senso unitario tale per cui un agente può sviluppare la propria azione nel tempo. La nostra identità personale non appartiene alla sfera dei fatti, ma dei ‘valori’.
Identità collettive.
- Che dire delle identità collettive? Qui potrebbe sembrare che le difficoltà nello stabilire cosa sia un’identità crescano esponenzialmente. Sul piano empirico, se già stabilire cosa sia l’identità di un individuo risulta arduo, cosa potremmo mai addurre per determinare l’identità di un gruppo (comunità, società, stato, ecc.)? E cosa mai potrà ‘accomunare’ me e migliaia o milioni di altri individui, se non magari alcuni tratti biologici?
- Ma anche qui, ed anzi forse in modo persino più chiaro, vediamo come l’identità non sia né possa mai essere una questione fattuale. Un’identità non si ha; un’identità si diventa, costruendola, difendendola, ricostruendola. L’identità in senso collettivo è quel luogo ideale dove possono verificarsi comprensione reciproca, concordia circa ciò che è degno di memoria, unità in ciò che è degno di essere sperato, collaborazione in ciò che può essere progettato. Non so se mai in terra tale identità collettiva si sia pienamente incarnata, ma è certo che per tali identità ideali si è combattuto a tutte le latitudini ed in tutti i tempi.
Identità collettive tra frammentazione e olismo.
- In verità, nessuna cultura storica ha osteggiato l’idea di un’identità collettiva più sistematicamente di quanto abbia fatto il pensiero occidentale contemporaneo, dominato dal liberalismo libertario (correlato politico del liberismo in economia). In questa cornice culturale ciascuno di noi è invitato ed incentivato sin dalla nascita a ‘trovare la propria strada’ (che si presume sia un unicum inedito), ad ‘imporsi con le proprie forze’ in libera e gioiosa competizione con gli altri, ad inorgoglirsi per la propria irriducibile originalità. Certo, questi aspetti luminosi si accompagnano ad alcuni non trascurabili lati oscuri, come la sistematica solitudine esistenziale, l’elevatissimo tasso di incomunicabilità, l’estrema difficoltà a trovare ‘affini’ (tanto sul piano amicale che sentimentale), ecc. Ma questi ‘lati oscuri’ vengono ricondotti nella cultura contemporanea a ‘vicissitudini personali’, ‘problemi psicologici’ da risolvere privatamente, nel foro interiore, o in specifici ambiti terapeutici.
- La cultura del sospetto nei confronti dell’idea di identità collettiva è coltivata accuratamente, e quando non è possibile farne scomparire l’aspirazione (e non è mai del tutto possibile), allora la si riconduce al formato più frantumato ed insignificante possibile. Così, si dice, ciascuno di noi è oggettivamente partecipe di un’infinità di ‘identità collettive’, cui può aderire o meno: c’è chi ama lo Heavy Metal e può aderire ad un’identità collettiva di ‘metallari’, chi raccoglie francobolli e può far parte della società filatelica, chi tiene per il Milan e si aggrega ai milanisti, chi prega Allah e si aggrega ai musulmani, chi venera Osho agli arancioni, chi Lenin ai leninisti, ecc. E quindi ciascuno può essere anche un metallaro arancione milanista filatelico, o qualunque combinazione che gli piaccia provare.
- Ma questa nozione di identità collettiva frantumata occulta il senso implicito nella ricerca di un’identità collettiva. Questa sfera assiologica rappresenta infatti la dimensione ideale di un’esistenza le cui caratteristiche qualificanti sono in grado di esistere indipendentemente e di riprodursi intergenerazionalmente. Un’autentica identità collettiva è il correlato soggettivo di un mondo: è quella dimensione che, idealmente, può conservare il proprio senso e i propri valori nel tempo innanzitutto perché è in grado di determinarsi nell’insieme delle pratiche e delle istituzioni che fanno esistere un gruppo e il suo mondo. È perciò che non può esistere propriamente un’identità collettiva di metallari o filatelici perché si può trattare solo di hobby, di aspetti ‘domenicali’ di una vita che si dispiegherà poi in una miriade di attività separate e di principio separabili. Al contrario un’identità collettiva consta di quelle pratiche, tradizioni, valori e istituzioni che consentono ad un gruppo di autoriprodursi, regolamentando i modi di interazione tra i suoi membri, i diritti e doveri, le abilità richieste e quelle auspicate, i principi di normalità e anormalità, gli estremi generali di una visione del mondo. – È possibile un’appartenenza ‘multipla’, ma in forma di appartenenze ‘concentriche’ (ci può essere un’identità famigliare, e poi una comunitaria, campanilistica, regionale, nazionale, europea, ecc.). Identità multiple ‘trasversali’ sono invece semplicemente identità dimidiate (peraltro molto coerenti con il modello apolide, “Zerrissener”, richiesto dall’organizzazione moderna del lavoro).
L’occultamento delle identità collettive.
- Poche cose possono sembrare ad un moderno cittadino occidentale più distanti ed esotiche di questo richiamo all’identità collettiva. Per noi tipicamente questo tipo di appelli fa parte tutt’al più di qualche immaginario distopico (l’“annegamento dell’individuo nella massa”, l’“organicismo” contro cui si scaglia Popper, ecc.). Richiami di tal fatta all’identità suscitano quasi fatalmente il riflesso condizionato di chiedere: “Ma di quale identità parli?”, “Cosa sarebbe mai questa identità?”, “Puoi dirmi cosa ne farebbe parte e cosa no?”. E il sottotesto è che il mondo odierno e i suoi abitanti non ammettono, e non abbisognano neppure, di alcuna identità del genere.
- Questa distanza ideologica da ogni tensione identitaria è però un’autointerpretazione gravemente erronea e potenzialmente fatale. In verità nessuna comunità o società esiste senza possedere tutti gli elementi menzionati sopra: regolamentazione dei modi di interazione tra i membri, diritti e doveri, aspettative circa le abilità richieste per essere membro di quel gruppo, criteri di normalità e anormalità, nonché gli estremi di una visione del mondo. Il liberalismo libertario non fa eccezione, anche se indebolisce e camuffa tutto ciò sotto le vesti di un’apparente “non interferenza” e di un generale “permissivismo” (salvo però mostrare molto rapidamente la faccia feroce, se confrontato con idee politiche o religiose che ne minacciano l’ordinamento). La differenza principale del liberalismo libertario rispetto ad altre identità collettive storiche consiste nell’aver delegato ai meccanismi di autoriproduzione economica gran parte di quelle funzioni che un tempo richiedevano una decisione sovrana. Al contempo questo modello interpretativo opera costantemente in modo da frantumare ogni aspirazione ad identità collettive, producendo nel processo (come corollario), l’impotenza di ogni forma politica che non veleggi già a favore dei meccanismi vigenti di autoriproduzione economica.
- Questa struttura paradossale ed autodissimulativa del liberalismo libertario non è però priva di rischi, al di là delle sue insufficienze interne. La propria strutturale impotenza politica tende a generare periodicamente reazioni violente, reazioni che di solito non riconoscono i meccanismi di autoriproduzione economica sottostante, e che prendono perciò come oggetto polemico l’immagine libertaria di sé che viene propagandata. Così facendo l’ordinamento liberal-libertario prepara il terreno per la sua negazione, per quel tipo di reazioni, violente, autoritarie ed aggressive che gli ‘identitarismi’ del primo ‘900 hanno mostrato, e anche per quelle forme di rigetto antioccidentale che oggi si manifestano nell’estremismo terrorista di molti immigrati di seconda generazione.
- Un’identità forte non ha bisogno di essere aggressiva, perché non ha bisogno per percepirsi di opporsi violentemente ad alcun’altra identità vista come diversa ed avversa. Un’identità forte non ha neppure bisogno di essere coercitiva, essendo intrinsecamente persuasiva: essa consente maggiore, non minore libertà di quella presente in società destrutturate. Ma un’identità forte è un’identità coltivata, promossa ed amata, non certo qualcosa che si fa ogni sforzo per dissimulare o tutt’al più si tollera, dunque non è un’identità che possa fiorire in ordinamenti liberal-libertari. Al contrario, gli esiti ultimi verso cui ci porta la grande finzione dell’irrilevanza identitaria sono forme di identitarismo aggressivo, dogmatico, intollerante, quel tipo di identitarismo così insicuro di sé da aver bisogno costante di un nemico per potersi dare nerbo e forma.
L’identità e il suo senso.
- L’errore fatale del mito antiidentitario liberale sta nel rimuovere il senso etico fondamentale di un’identità collettiva (sociale, comunitaria, statale, ecc.). Così come per ciascun individuo la propria identità, per quanto mobile, è ciò che gli consente di avere un’esistenza, e dunque un senso, intertemporale, così per un gruppo umano l’identità è ciò che consente di concepire i propri atti, valori, realizzazioni, retaggi ed auspici come qualcosa che potrà avere una possibile continuazione al di là dei limiti della nostra caducità di individui. Questo tratto di fondo, peraltro, non è neppure un’esclusiva delle visioni del mondo immanentiste e storiciste: anche le visioni religiose, anche quando predicano una sopravvivenza dell’anima individuale, non hanno mai fatto a meno, e non riescono a fare a meno, di questa dimensione di identità sovraindividuale.
- Un’identità collettiva non viene all’esistenza perché è utile, in quanto non appartiene alla sfera dei mezzi, ma a quella dei fini, o forse meglio dei valori intrinseci: essa non ‘serve’ a qualcos’altro, bensì è ciò in vista di cui altre cose ‘servono’. In questo senso si può capire il sussistere di tradizioni, usi, costumi che apparentemente non hanno alcuna funzione ragionevole se non di alimentare la coalescenza dell’identità collettiva. È vero che un’identità, personale come collettiva, non può mai permettersi di dedicarsi così integralmente alla propria autodeterminazione da divenire una sorta di solipsismo (individuale o collettivo): se vuole conservarsi intertemporalmente deve infatti manifestare anche un’efficacia nell’affrontare l’alterità del mondo, la “durezza del reale”. Qui stanno ottime ragioni per favorire il formarsi di identità capaci di un confronto razionale (es.: scientifico, filosofico) con il mondo. E tuttavia non bisogna dimenticare neppure per un momento che il nocciolo assiologico che alimenta la pulsione all’identità non dipende da alcuna utilità estrinseca, ma si presenta come la dimensione naturale di ciò che ha valore per l’agente.
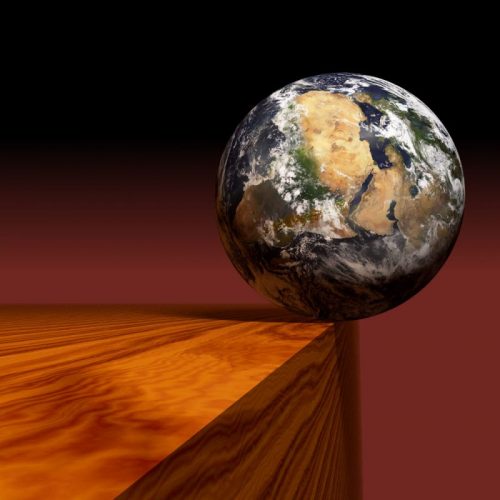
Mi permetto di segnalarle questo pezzo http://www.iltascabile.com/societa/classi-sociali/ sul concetto di “classe” oggi. Ricorda la vecchia critica che denunciava la marginalità delle quetioni d’identità: “I “culturalisti” attaccano il presunto economicismo delle classi in un modo che tende a ignorare deliberatamente gli sforzi fatti da molti di riattualizzare il concetto. Per parte loro, i difensori dei diritti sociali non prendono sul serio l’idea che l’esclusione dal riconoscimento sia politicamente rilevante e non può essere derubricata a epifenomeno della lotta di classe. Squalificare come ‘non politiche’ queste istanze fa il paio con la pretesa di detenere il monopolio della ‘giusta rivendicazione’, e i confini di ciò che è legittimo considerare politico diventano essi stessi una posta in gioco, come argomento da mobilitare nell’agone o come titolo preventivo a prenderne parte. ” Poi sostiene che il rossobrunismo è il risultato del divorzio tra la politica dell’identità e quella di classe, divorzio che occore respingere.
NOTA SU COSMOPOLITISMO E RADICAMENTO
In un post su FB ho letto alcune considerazioni che mi parevano ovviamente condivisibili. Vi si trovava scritto, in soldoni, che essere costretti ad andare all’estero per lavorare o studiare non è una figata, non è una dimostrazione di apertura, non è un gioioso abbraccio alle sfide dell’internazionalizzazione, ma può essere un grave onere, persino un dramma. Sentire un docente universitario dire (come mi tocca fare più spesso di quanto vorrei) che “Se vuoi uno straccio di carriera è meglio che ti metti nell’ottica di emigrare” non è una cosa di cui andare fieri, tutt’altro.
Naturalmente che chi voglia un’esperienza all’estero se la faccia va benissimo, e può essere incoraggiato, ma costringere qualcuno, per mancanza di alternative, a questi percorsi, percorsi che preludono spesso ad una vita con le valigie pronte, è senz’altro una sconfitta.
Curiosamente, nonostante l’apparente buonsenso della considerazioni di cui sopra, ho notato numerosi commenti che, ispirati da una prospettiva sedicente ‘di sinistra’, tacciavano una prospettiva del genere di ‘conservatorismo’, ‘regressività’, ‘nazionalismo’, cui veniva opposto il cosmopolitismo di chi ha come “sua terra il mondo”.
Ora, ci sarebbero mille cose da dire, ma ne voglio dire una soltanto.
Gente che chiacchiera del “mondo come propria patria” o non ha capito di cosa si parla, o scambia il catalogo Alpitour per una ‘conoscenza del mondo’.
Quei ‘cosmopoliti’ che contrappongono tale cosmopolitismo al radicamento non hanno capito che conoscere gli alberghi di qualche metropoli e i relativi MacDonald’s non è ancora sapere proprio niente di una terra, delle persone che la abitano, della cultura in cui si radicano, delle forme di vita che hanno ereditato, del senso che esse riescono ad attribuirvi.
Una vita si sviluppa solo in un radicamento finito in luoghi, ambienti e conoscenze umane circoscritte, la cui conoscenza in profondità e intensità non è mai sostituibile con la conoscenza estensiva di mille frammenti di esistenze altrui. Viaggiare e conoscere il diverso è utile, forse persino indispensabile per comprendere meglio la propria identità, personale e collettiva; ma non è alcun sostituto del radicamento.
Chi non è in grado, per le vicissitudini della propria vita, di radicarsi in nessun luogo, vive in una condizione di minorità irredimibile, per quanto possa fregiarsi di uno sterminio di timbri sul passaporto.
Se non hai radici, non puoi neppure comprendere quelle altrui, e sei semplicemente condannato a non capire parte essenziale dell’esistenza.
P.S.: Seguendo un’etimologia corrente, il termine “cosmopolitismo” viene spesso reso con l’espressione “essere cittadini del mondo”. Tale espressione è retorica e impropria quanto poche, giacché l’essere cittadini evoca proprio l’appartenenza locale, per contiguità, frequentazione e impegno, cosa che nessun umano può coltivare nei confronti del mondo tutto. – Quanto alle nostre “radici” esse non vanno mai intese come meri dati di fatto, mere contingenze. Le radici sono, come quasi tutto ciò che concerne le nostre identità, una DECISIONE fondata in modo NON ARBITRARIO, ma neppure cogente. Così, ad esempio, io ho avuto l’occasione per decidermi a più di un’appartenenza nella mia vita e solo con il tempo ho maturato la determinazione di coltivarne una specifica (e naturalmente ‘a centri concentrici’, con aree di maggiore o minore prossimità). Di contro, non qualsiasi appartenenza mi sarebbe stata disponibile: non avrei mai sensatamente potuto sentire un radicamento a Shangai o Tokio (mentre potevo sentirlo, ad esempio, a Vienna, pur non essendo la mia città natia, ma solo, per un periodo, adottiva).
NOTA SU IDENTITA’ E “VELO DI IGNORANZA” RAWLSIANO
Esiste un ragionamento, di indole pedagogica, che chiede alle persone di riflettere sulla possibilità che esse possano essere nate altrove, sotto condizioni diverse e meno fortunate, in famiglie differenti, ecc.
E che in grazia di questa possibilità, esse dovrebbero accettare di ‘scambiarsi’ idealmente con altri, di fare proprie le loro difficoltà, le loro sofferenze, in certo modo le loro vite.
Questo ragionamento è molto ben intenzionato e moralmente lodevole. Ma è anche essenzialmente sbagliato.
Ciascuno di noi infatti ha avuto la fortuna o sfortuna di essere quello che è. Ciò implica letteralmente tutto: il luogo di nascita, ma anche l’essere intelligente o stupido, l’aver avuto genitori amorevoli o meno, l’avere forza di volontà o meno, ecc. ecc.
Questa è la condizione contingente di ogni vivente e di ogni essere umano, cui nessuno sfugge.
Questo ragionamento è importante per renderci consapevoli di quanto cauti e prudenti dobbiamo essere quando parliamo di meriti e demeriti.
Tuttavia questo ragionamento non può in alcun modo sfociare nell’idea che in qualche modo noi e gli altri possiamo essere in certo modo ‘interscambiabili’, e che dunque le responsabilità che noi abbiamo nei confronti di noi stessi, nella nostra vita, possano essere trasposte in vite altrui, assumendocene ruoli e possibilità, assumendo nei loro confronti idealmente le stesse responsabilità che abbiamo nei confronti di noi stessi nella nostra esistenza attuale.
Nessuno di noi infatti è in grado di uscire dalla dimensione cui apparteniamo, per così dire guardandola dall’esterno, e portando a compimento il ragionamento fittizio:
“Come sarei se fossi nato in un altro tempo, un altro luogo, da genitori diversi, ecc.”
Questa è una trasposizione impossibile, anzi insensata, perché molto semplicemente io non sarei io, ma sarei un altro; e più precisamente sarei quell’altro con quelle opportunità, quei limiti, quelle speranze, quelle capacità, di cui dalla mia collocazione e identità attuale non ho alcuna idea.
Noi possiamo legittimamente, e lodevolmente, decidere di aiutare X e/o di amare Y, nella loro diversità e con la loro identità. Possiamo decidere di venire incontro ai bisogni che essi manifestano perché essi li manifestano.
Ma non possiamo mai sostituirci ad essi, né di fatto, né di diritto.
Che lo si voglia o meno noi SIAMO il luogo e tempo dove siamo nati, SIAMO le persone che abbiamo incontrato, SIAMO la cultura che ci ha forgiato, SIAMO le disposizioni, talenti e limiti che abbiamo scoperto in noi, ecc.
Non siamo necessariamente migliori o peggiori di altri, ma le responsabilità che abbiamo acquisito, le promesse che abbiamo fatto, i compiti che ci siamo assunti, i progetti in cui ci siamo impegnati, tutto ciò e molto altro esiste solo per noi stessi in prima persona, sul sentiero che abbiamo percorso.
E solo ad essi siamo moralmente vincolati.