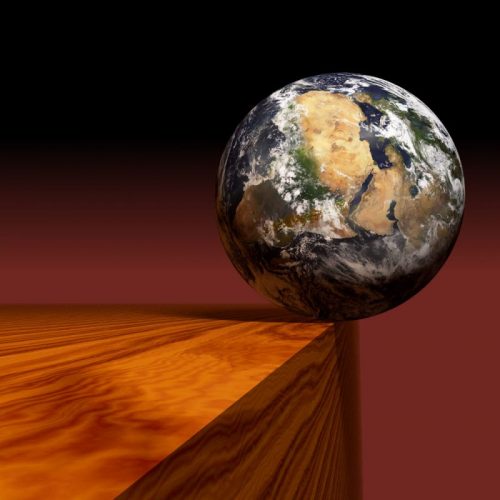Il riferimento a comportamenti ‘naturali’ o ‘innaturali’ (contro natura) ha una tradizione lunga, celebre, e anche estremamente discutibile. Spesso nella storia il riferimento alla ‘naturalità’ di certi comportamenti o costumi è stato semplicemente un travestimento involontario di una pregressa decisione dogmatica, o dell’appartenenza ad una specifica ortodossia. Molto frequentemente il riferimento stesso ad un ‘diritto naturale’ cade in confusioni insostenibili, oppure si risolve nel semplice riferimento ad una visione del mondo precostituita, perlopiù a base confessionale.
Due sono le obiezioni di fondo che possono essere mosse rispettivamente: (1) alla definibilità di un comportamento umano come ‘naturale’, e (2) alla determinazione di un diritto o di una morale su base ‘naturale’.
- Obiezione (1): Si dice spesso che per quanto riguarda i comportamenti umani una distinzione tra ‘naturale’ e ‘culturale’ (o ‘storico’) è impossibile in quanto la dimensione culturale e storica è appunto parte della natura umana. Gli esseri umani producono riflessioni verbali, creano strumenti e istituzioni sociali. E l’essenza dell’uomo è stata definita classicamente proprio come animale dotato di linguaggio, o come animale costruttore di strumenti, o come animale sociale. Da qui emergono le obiezioni che hanno buon gioco nel mettere alla berlina il riferimento alla ‘naturalità’. Dopo tutto, si dice, dove possiamo dire che finisca la natura e inizi l’artificio? Vestirsi, riscaldarsi, mangiare cibi cotti, curarsi con erbe prima e medicine poi, ecc. ecc. in che senso potrebbero dirsi atti artificiali piuttosto che naturali? Non è chiaro che, se volessimo perseguire una presunta pura naturalità dell’uomo, finiremmo per ridurci ad animali preumani?
- Obiezione (2): Secondo il noto argomento della ‘fallacia naturalistica’ (cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana; G.E. Moore, Principia Ethica), dalla descrizione di un fatto, qualunque esso sia, non si possono trarre proposizioni normative (‘No ought from is’). In quest’ottica, anche quando si sia stabilito che un certo comportamento meriti di essere considerato naturale, questa sarebbe comunque solo una constatazione fattuale, da cui non è possibile derivare alcuna norma. Con un esempio concreto (e molto discusso): supponiamo che si stabilisca, plausibilmente, che l’unione di un maschio e di una femmina sia la forma naturale di creazione di una famiglia; posso da ciò dedurre che allora uomini e donne si devono sposare per creare una famiglia? Oppure, posso da ciò dedurre che una coppia che non consti di un uomo e di una donna non debbano sposarsi? Qui sembra evidente un non sequitur: il matrimonio è un’istituzione sociale normativa, con sue condizioni e obblighi, non un fatto di natura, e non c’è alcun automatismo che connetta l’istituzione del matrimonio ai rapporti tra i sessi, anche quando essi siano riconosciuti come naturali. Dunque anche parlare di un ‘matrimonio naturale’ o è semplicemente un’espressione confusa, oppure richiede una spiegazione non banale.
Queste due obiezioni sono obiezioni filosoficamente solide. Tuttavia, una volta che le abbiamo considerate abbiamo solo scalfito la superficie del problema. Esaminiamo partitamente quegli argomenti e proviamo a leggerli attraverso una chiave interpretativa meno ingenua.
- 1.a) Partiamo dal primo punto. Davvero la ‘natura culturale’ dell’uomo cancella ogni possibilità di applicare la nozione di naturalità all’umano? A ben vedere le cose non stanno così. Ciò che quell’argomento sancisce è l’impossibilità di definire il ‘naturale’ per mera opposizione rispetto allo storico/culturale. In effetti tale opposizione tradizionale tra ordinamento naturale e ordinamento storico/culturale ha un’origine teologica e ricalca l’opposizione tra un ordinamento supposto stabile ed eterno (le “leggi di natura” o “idee a priori” come “pensieri di Dio prima della creazione”), ed un ordinamento temporale e transeunte. Ma questa opposizione è oggi razionalmente insostenibile, al di fuori di una riflessione squisitamente teologica. Nessuno dubita oggigiorno che vi sia una storia naturale, né che in essa compaiano processi evolutivi. Ma se vi sono una storia ed un’evoluzione naturale definire il naturale per contrasto con lo storico è un palese non-senso. Questa prospettiva cambia radicalmente il senso che possiamo attribuire alla ‘naturalità’.
Se diamo credito alle nostre migliori teorie intorno alla storia naturale, dobbiamo dire che un funzionamento ecologico o biologico oggi esistente è qualcosa che si è affermato e stabilizzato in un processo durato centinaia di migliaia, quando non milioni, di anni. Esso, per così dire, eredita l’immensa sequenza delle ‘prove ed errori’ del passato, di cui appare come un esito ‘di successo’. Questo significa in maniera piuttosto diretta che qualunque funzionamento ecologico o biologico esistente ha ottime ragioni, ragioni per lo più per noi imperscrutabili, per essere come è.
Questo significa che tale funzionamento sia necessariamente ‘sacro’, ‘intoccabile’, che non possa mai essere corretto? No, questa sarebbe una conclusione troppo forte, e peraltro contraria proprio al carattere storico ed in evoluzione dello sviluppo naturale. Per dire, la variante genetica nel cromosoma 11 che in alcune persone si presenta come anemia falciforme o anemia mediterranea sembra fondato in termini di storia naturale dalla concomitante resistenza alla malaria per i portatori eterozigoti di quella variante. Ci sono dunque ragioni evolutive perché quel tratto genetico esista, anche se per alcuni soggetti (omozigoti) esso può risultare letale. Se qui è possibile una terapia genica operante sulla sola linea somatica che rimedi a questa mutazione negli affetti da anemia falciforme, essa sarebbe perfettamente legittimabile. Si tratterebbe infatti di pesare due esiti che concernono e si esauriscono entro una singola persona: la malattia di contro alla guarigione. Trattandosi di un intervento che non avviene sulla linea germinale del DNA esso non propaga alcuna conseguenza sulle generazioni future. Tutt’altra questione sarebbe invece un intervento di ingegneria genetica che intervenisse sulla linea germinale, coinvolgendo nelle (ignote) implicazioni della modifica le generazioni future. Un tale intervento, per le medesime ragioni di cui sopra, non dovrebbe essere mai consentito, salvo il caso estremo di rischi terminali per la specie tutta (estinzione) e non per un singolo individuo.
Prendiamo un esempio complementare. Il concepimento e la crescita del feto nell’utero dei mammiferi è anch’esso un processo immensamente complesso e delicato, frutto di un processo selettivo durato milioni di anni. Si parla oggi della possibilità di sostituire la gestazione naturale con la gestazione in un utero artificiale, che supporta le funzioni dell’utero reale a noi oggi note. Vista l’onerosità per la donna, e per la produttività economica, di una gravidanza è facile intravedere quale interesse pragmatico tale soluzione possa presentare in prospettiva. E tuttavia, avallare questa pratica sarebbe totalmente irresponsabile, per la semplice ragione che una modifica delle condizioni naturali di crescita in utero può avere conseguenze di portata ignota sul nascituro. Di contro, questo significa che sotto nessuna condizione potrà mai essere legittima l’adozione dell’utero artificiale? No, neppure una proibizione assoluta è giustificata. Il punto è che una soluzione del genere potrebbe presentarsi come giustificabile solo in situazioni estreme, che mettono in campo benefici o danni che si ripercuotono sulle generazioni future, e dove i possibili benefici superino in modo evidente i possibili danni. Possiamo, ad esempio, immaginare l’esplosione dell’epidemia X, che rende impossibile, finché una cura non venga trovata, la riproduzione naturale in utero. Di fronte alla prospettiva dell’estinzione della specie, l’adozione dell’utero artificiale sarebbe naturalmente un rischio accettabile. Al contrario, la sua adozione non sarebbe giustificabile per venire incontro al desiderio corrente di maternità di una singola persona impossibilitata a portare a termine una gravidanza: qui il rischio per il nascituro, e il potenziale gravame per la generazione futura, non possono essere subordinati al pur legittimo desiderio di maternità.
- 1.b) Va osservato come questo ragionamento intorno alla naturalità di alcuni funzionamenti biologici può essere esteso parzialmente anche a processi di storia umana, e non solo di storia naturale. Anche nel caso di usi e costumi consolidati, di tradizioni e pratiche diffuse, noi sappiamo che se essi si sono affermati e propagati nel tempo, una funzione sociale devono averla avuta. Se una tradizione esiste ci sono certamente ragioni per la sua esistenza, che in una qualche fase storica deve essere stata funzionale all’autoriproduzione e al successo del gruppo (cfr. Hayek, Regole e ordine). Questo è un ragionamento di forma analoga a quello adottato con riferimento alla storia naturale, ma, proporzionalmente ai tempi di consolidamento incomparabilmente inferiori, esso deve essere considerato come molto meno vincolante. In questo senso, a maggior ragione rispetto al caso biologico, ciò non comporta la tesi del conservatorismo classico per cui ogni tradizione sarebbe di per sé ‘buona’ o addirittura ‘intoccabile’.
Prendiamo un caso come l’esistenza in certe popolazioni dell’Africa orientale di una tradizione che promuove la mutilazione genitale femminile. Noi ignoriamo quali siano state le ragioni per l’introduzione di una tale pratica in certe aree. Può darsi che quando è stata introdotta essa avesse una funzione contestuale concreta, oppure può anche darsi che essa sia stata introdotta semplicemente sulla scorta di credenze religiose, la cui unica funzione sociale era quella di mantenere l’assetto (sociale, cosmologico, ecc.) nelle credenze collettive di un gruppo. A fronte del contenuto vuoto o effimero delle attuali motivazioni a favore della pratica stanno le gravi conseguenze in termini di danni fisici alle donne che vi sono sottoposte. Visto questo bilanciamento motivazionale, non c’è dubbio che ci siano ragioni determinanti per chiedere l’abolizione di quella tradizione.
Ma esistono anche molti casi diversi. Prendiamo un caso dove una tradizione consolidata sussiste, ma dove è senz’altro concepibile una società in cui vigano tradizioni diverse da essa, e dove non ci sono ragioni manifeste né a favore né contro quella tradizione. Pensiamo, ad esempio, alle infinite variazioni storiche circa cosa debba contare come comune senso del pudore in una società. Conosciamo società in senso antropologico e storico con diversi “sensi del pudore”, e sappiamo dunque che alternative sono possibili. Possiamo inoltre non trovare al momento ragioni particolari, esterne al costume stesso, a favore del suo mantenimento. Ma questo non significa affatto che, qui ed ora, sia sensato modificare il costume attuale. Per dire, io posso perfettamente immaginare una società in cui due persone possano, se e quando lo desiderano, esercitarsi in un coito pubblico, e non mi si presentano obiezioni insuperabili per cui una tale società non possa comunque vivere e prosperare adottando questo costume. Questo però non significa che io sia giustificato a criticare il costume attualmente vigente che vieta quel comportamento, giacché non ho una conoscenza, se non necessariamente superficiale, di quali altri tasselli comportamentali in un ordinamento sociale si mettano in moto a cascata una volta introdotta quella variazione di costume. Il costume attuale è frutto di un equilibrio raggiunto, un equilibrio certamente provvisorio come tutti gli equilibri storici ed i costumi sociali, ma per proporne un cambiamento devono essere chiaramente visibili ragioni a favore della modifica, altrimenti vige l’assunto dell’esistenza di ragioni (eventualmente ignote) a supporto del costume in vigore e con ciò della sua conservazione. Chi propone un’innovazione rispetto ad un costume o ad una tradizione consolidata ha l’onere della prova di mostrare il chiaro prevalere di ragioni favorevoli al mutamento (come nell’esempio delle mutilazioni di cui sopra).
- 2) Veniamo infine alla seconda obiezione, cui implicitamente abbiamo già cominciato a rispondere. Nel ragionamento di cui sopra abbiamo già visto implicitamente come dall’accertamento della naturalità di un comportamento o dalla tradizionalità di un costume (determinazioni fattuali) possano emergere conclusioni normative. Ma come è possibile che ciò accada, se l’argomento della ‘fallacia naturalistica’ è valido? È proprio vero che dalla descrizione di una realtà di fatto non sia mai possibile dedurre istanze normative?
Ora, in verità il celebre argomento della ‘fallacia naturalistica’ è un argomento che deve la sua apparente evidenza al fatto di muoversi su di un piano molto astratto (cfr. MacIntyre, After Virtue). È logicamente inattaccabile che da una pura descrizione fattuale nessuna proposizione normativa possa essere immediatamente dedotta, e quindi in un mondo in cui nessun ordinamento normativo/assiologico sia vigente, esso non può essere introdotto attraverso mere descrizioni fattuali. Ma le condizioni reali in cui ci muoviamo nella vita sociale sono già permeate di fattori valoriali e normativi, ed è perciò che l’emergere di una specifica determinazione fattuale può orientarne l’indirizzo in modo decisivo.
Immaginiamo il seguente caso.
Descrizione fattuale α): <Scoppia sul nostro pianeta una devastante epidemia letale, ma ad un certo punto un ricercatore ne scopre una cura.>
Da questi due fatti a rigore non è possibile dedurre la proposizione normativa:
β): <È dovere del ricercatore condividere la sua scoperta>.
Quella proposizione infatti può essere sostenuta solo sulla base di qualche valore condiviso. Ad esempio, se assumiamo:
a) che sia un valore per gli umani vivere piuttosto che morire,
b) che una persona normale debba avere qualche empatia per il suo prossimo.
A rigore né a) né b) possono essere date per scontate. Esse sono assunzioni circa la normalità di alcuni valori, assunzioni che possono di principio essere violate, e che in un certo numero minoritario di casi sono certamente violate (ci sono persone, ad esempio profondamente depresse, che preferiscono morire a vivere, e ci sono persone, costitutivamente prive di empatia, che non sono minimamente toccate dalla sofferenza o dalla morte altrui).
Dobbiamo dire perciò che dalle condizioni descrittive di α) è illegittimo concludere la proposizione normativa β)? Beh, quello che è vero è che β) non è logicamente deducibile da α), ma è anche vero che in un contesto normale, in cui facciamo riferimento alla prevalenza di alcuni valori nei soggetti coinvolti, possiamo trasformare quel nesso in un imperativo ipotetico:
<Se ammettiamo i valori a) e b), allora dalla descrizione fattuale α), ne segue in modo imperativo il dovere morale β).>
È interessante notare come un tribunale ordinario non farebbe nessuna difficoltà a trarre proprio questa conclusione, ad esempio imponendo coercitivamente la condivisione della scoperta al ricercatore.
Ma è anche degno di nota come un tribunale che assumesse rigidamente i principi dell’individualismo liberale potrebbe sentenziare diversamente: non potendosi stabilire a priori né quanto vale soggettivamente per il ricercatore diffondere la sua scoperta, né quanto vale soggettivamente per i malati curarsi, si dovrebbe lasciare spazio ad accordi privati tra ricercatore e malato (secondo il meccanismo ordinario della domanda e dell’offerta).
- Conclusioni.
Da quanto si è visto sopra:
1) È possibile stabilire un senso perfettamente razionale, scientificamente suffragabile e non dogmatico di ‘naturalità’, anche con riferimento a funzioni e comportamenti umani;
2) Questo concetto può essere esteso, in forma attenuata, agli ordinamenti di pratiche, costumi e tradizioni di una storia sociale (qui non sarebbe opportuno parlare di ‘naturalità’ di un costume, ma di una sua ‘validità inerziale’;
3) Dall’aver stabilito la ‘naturalità’ di una pratica o la ‘validità inerziale’ di un costume è possibile trarre inferenze di tipo normativo.
Detto questo, va anche osservato:
4) che le inferenze di tipo normativo in questione hanno il carattere di imperativi ipotetici a base storica, e non di imperativi categorici. Da ciò ne segue che non possiamo concepirli come ‘leggi divine’, ‘norme assolute immutabili’, ecc. Dobbiamo aspettarci che essi sotto certe condizioni possano essere messi in discussione e anche mutati. Tuttavia, dato un intorno storico-sociale ben definito ed un contesto di applicazione, la norma può anche essere tassativa e non negoziabile.
5) che tali inferenze di tipo normativo sono imperativi che indicano un dover essere, e non sono dunque leggi nel senso particolare del diritto; tali imperativi ipotetici ci consegnano, per così dire, lo ‘spirito di una legge’, mai la legge bell’e fatta, che sarà oggetto, come per tutte le leggi e i diritti, di definizione giuridica particolare.
6) che il superamento dell’argomento della fallacia naturalistica richiede un assunto di fondo, un assunto intuitivo e di cui si può dimostrare la necessità, ma di cui qui non abbiamo dimostrato la necessità. L’assunto è il seguente: noi dobbiamo concepirci come accomunati da qualche valore con altri esseri umani. Si potrebbe dimostrare che tale assunto è sia una necessità empirica, presupposta a funzioni come l’apprendimento del linguaggio, sia una necessità storica, presupposta all’esistenza di qualunque comunità o società.
È ovvio che questo ragionamento fornisce una base per tutte le forme di adozione del cosiddetto ‘principio di precauzione’ in bioetica ed ecologia, ma anche per una sua estensione (mitigata) al campo degli usi e costumi sociali. Una rimessa in discussione dei concetti storici di ‘progresso’/’progressismo’, ‘conservazione’/’conservatorismo’, e ‘rivoluzione’/’riforma’ alla luce di queste conclusioni è opportuna.