Nell’intervento precedente (su “Il senso etico della naturalità ecc.”) avevamo affermato, ma non argomentato, che “le condizioni reali in cui ci muoviamo nella vita sociale sono già permeate di fattori valoriali e normativi”, e che il riferimento ad una comunanza valoriale con altri esseri umani è un’istanza necessaria ed inaggirabile.
Cercherò qui di dimostrare questo punto e di illustrarne alcune implicazioni.
Il riferimento alla ‘normalità’ (in ambito psicologico-comportamentale) è considerato spesso ‘sospetto’ avendone di vista gli aspetti normativi e potenzialmente oppressivi, ovvero l’idea che in tale riferimento possa albergare un’istanza discriminatoria ed aggressiva nei confronti di chi non si conforma alla ‘normalità’.
Questi timori non sono invenzioni gratuite, ed hanno una base storica e comportamentale. È vero che sul crinale ‘normalità’ / ‘anormalità’ applicato agli individui si sono spesso impiantati comportamenti discriminatori od oppressivi.
Il problema tuttavia è che in una parte, autodefinitasi ‘più avanzata’ o ‘più progressista’, dell’intellighentsia contemporanea, la ‘soluzione finale’ per quel timore è rappresentata dalla delegittimazione di ogni riferimento normativo alla ‘normalità’ in quanto tale. Si tratta di una posizione politica molto netta, che peraltro si colloca armonicamente nella cornice dell’individualismo libertario corrente. Questa istanza ‘abolizionista’ del normale dà infatti una veste intellettualmente rispettabile ad una spinta molto più generale, una spinta concorde con le dinamiche economiche contemporanee, che va verso la dissoluzione delle identità collettive e la riduzione delle ragioni pubbliche a mediazioni tra desideri privati. L’ideale liberale contemporaneo è crescentemente quello di un mondo di individui, privi di appartenenze e radicamenti, ed esentati da ogni richiesta valoriale normativa, individui che si rapporterebbero l’un l’altro nella sola forma della tensione tra interessi contrapposti (la contrattazione di mercato), rispettando solo una cornice legale a tutela dei liberi scambi economici [Su ciò torneremo in una discussione successiva.]
- L’essenza normativa della normalità
Nel discorso comune noi non possiamo in alcun modo fare a meno di riferirci al dualismo concettuale normalità/anormalità, né possiamo fare a meno di considerare la normalità come ‘metro’ o ‘standard’ in senso normativo. Prendete un qualunque oggetto, utensile o funzionamento intorno a voi e troverete immediatamente che in esso riconosciamo un ambito di normalità e, in progressivo allontanamento da quell’ambito, una dimensione di eccezione o anormalità; inoltre, troverete che la normalità serve da parametro per valutare l’eccezione, e ne stabilisce gerarchicamente la ‘subnormalità’ o, al contrario, l’esemplarità.
Ciò che l’istanza politica di cui sopra esige è una specifica astensione: quando si arriva alla sfera dell’umano ogni discorso in termini di normalità sarebbe da considerare tendenzialmente un abuso a rischio di prevaricazione, ed andrebbe espulso, o ‘messo tra parentesi’. L’opposizione tra normalità ed anormalità è tuttavia meno semplice di come si presenta prima facie.
Nell’ambito del non-normale possiamo distinguere tre istanze differenti, che chiameremo rispettivamente l’anomalia, la patologia e l’immoralità. Per anomalia intendiamo ogni situazione o comportamento che non si conforma allo standard della normalità, senza però collidere con esso. L’anomalia non impedisce perciò né la tolleranza, né l’empatia. La patologia è invece un’anomalia che richiede anche una presa di distanza e, se possibile, un intervento correttivo. L’immoralità, infine, è un’anomalia che richiede una presa di distanza ed un giudizio di rigetto, che vi sia o meno la disponibilità di interventi correttivi.
Possiamo provare a comprendere meglio queste distinzioni esaminando innanzitutto l’applicazione dell’idea di anormalità nell’ambito psichiatrico, e in quello dei comportamenti sessuali. È certo che l’applicazione del giudizio di normalità o anormalità nelle valutazioni in questi due ambiti sono state anche un mezzo per l’implementazione di iniziative repressive. La reclusione in istituti psichiatrici di persone che, secondo standard attuali, non presenterebbero alcunché di patologico è un fatto storicamente accertato, così come è indubbio che in molti contesti (anche recenti) forme di sessualità eterodosse possono venire considerate illegali o immorali (omosessualità, pedofilia, ecc.). Il problema è quali conclusioni trarne. Se la conclusione che ne viene tratta è che l’attribuzione di giudizi di normalità nella sfera umana, e il loro utilizzo in determinazioni normative, vadano soppressi, allora abbiamo un serio problema.
La prima questione che dobbiamo discutere ha un aspetto molto astratto, e tuttavia è necessario prenderla in considerazione per segnalare la profondità dello sfondo. Essa concerne il senso più generale in cui è necessario ammettere una comunanza di valori tra esseri umani in quanto appartenenti ad un medesimo gruppo sociale.
- La costituzione linguistica del soggetto e la normalità necessaria
Il tema della necessità di un’assunzione di normalità sul piano cognitivo ed assiologico è emerso a più riprese nelle indagini intorno ai modi in cui il linguaggio viene appreso (Wittgenstein, Davidson) e ai modi in cui i giudizi di oggettività vengono composti (Husserl). Nel ‘900 la vecchia idea che il linguaggio potesse essere appreso con un semplice meccanismo di associazione ostensiva (parola + indicazione = battesimo verbale) ha mostrato a più riprese, sia in termini antropologici che di psicologia dell’età evolutiva, la sua inadeguatezza. Per comprendere come il linguaggio possa essere appreso una migliore approssimazione si può ottenere rielaborando un vecchio esempio di Quine. Se sono proiettato in mezzo ad una tribù di cui non conosco il linguaggio come posso accedere progressivamente ad una comprensione di esso? Essenzialmente vedo come essi usano il linguaggio in contesto e, affidandomi alla mia affinità con il loro modo di percepire e giudicare, inizio a formulare ‘ipotesi di significato’, che in istanziazioni successive vengono smentite o precisate. Se vedo un coniglio saltellare nell’erba e sento il nativo dire ‘gavagai’ posso supporre che egli stia intendendo il coniglio. Gli errori naturalmente sono sempre possibili, ma è importante capire che se un accesso al linguaggio altrui dev’essere possibile, ciò può accadere solo in quanto vi sia un’affinità antropologica di fondo. Se con ‘gavagai’ il nativo in quel contesto intendesse la sola macchia bianca sul dorso del coniglio, o la benevolenza della ‘Madre Terra’ verso gli animali zampettanti, o la bellezza del suono ‘gavagai’ in sé e per sé, o la nausea che lo coglie privatamente nel vedere animali zampettanti, o l’odore dell’erba smossa, ecc. ecc. la nostra possibilità di pervenire ad un linguaggio comune sarebbe sostanzialmente nulla.
In concreto, per i nostri fini, questo significa che affinché si instauri un codice comune tra me e il nativo (e lo stesso discorso si può fare tra l’infante, privo di linguaggio, e il genitore che glielo insegna) è necessario che vi sia un’affinità tra di noi nella capacità cognitive e nell’ordinamento degli interessi ( = valori). Se abbiamo capacità cognitive fortemente divergenti (es.: io ho una predominanza della vista e lui dell’olfatto), oppure se abbiamo ordinamenti assiologici fortemente divergenti (es.: io sono interessato alla vita animale, alle cose in movimento, ecc. mentre lui è focalizzato sulle proprie reazioni interiori o sulle funzioni estetiche dei suoni, ecc.), allora non giungeremo mai ad alcun codice linguistico comune.
Nel caso di un infante che apprende il suo primo linguaggio questo processo di apprendimento acquisisce una particolare profondità. Infatti il bambino, con l’appropriarsi del primo linguaggio, apprende anche le prime forme di articolazione della propria capacità di riflessione, e con ciò il primo nucleo della propria identità personale. Questo significa che il primo nucleo di autonomia mentale che l’infante acquisisce è già sempre definito da un livello di accordo cognitivo ed assiologico elementare, che riposa su potenzialità e sensibilità affini. (In assenza di tali affinità nessuna comunanza di linguaggio e pensiero si può stabilire: è questo il senso della celebre osservazione di Wittgenstein: “Se un leone potesse parlare, noi non lo potremmo capire.”)
È inoltre in questo senso che il nostro giudizio personale (riflessivo) intorno alle cose e agli eventi è già sempre un giudizio che si intende come ‘intersoggettivamente valido’: qualunque cosa noi riteniamo vera o reale è per ciò stesso intesa come giudicabile tale anche da altri (oggettiva).
Questo breve ragionamento (che potrebbe essere ampliato e approfondito di molto) dovrebbe già chiarire come la nostra esistenza di parlanti di un qualunque linguaggio e con ciò di membri di una comunità di parlanti-pensanti, presupponga necessariamente una comunanza di valori. Si potrebbe però dire che tali valori sono valori banalmente universali, propri di tutti gli uomini, e che dunque non riguardano in nessun modo giudizi di normalità assiologica di rilevanza politica.
Per comprendere la significatività del rilievo bisogna perciò estenderne la portata.
- L’anormalità come patologia: il caso dei giudizi psichiatrici
Abbiamo stabilito che una comunanza assiologica dev’essere già sempre vigente sullo sfondo di qualunque funzionamento sociale (a partire dal principale di tali funzionamenti, il linguaggio). Ma per comprendere il funzionamento e la portata dei giudizi di normalità bisogna esplorare il senso del limite che li contrappone a valutazioni di patologia. Prendiamo alcuni giudizi di patologia psichiatrica. Una persona affetta da schizofrenia paranoide può continuare a ragionare con noi in modi perfettamente articolati, ma in breve tempo ci accorgiamo che i ‘pesi probabilistici’ che essa assegna agli eventi circostanti ci appaiono ‘distorti’. Essa vede nel bisbiglio tra due persone le tracce di una congiura che la coinvolgono, nella coincidenza tra due eventi il frutto di un piano ben congegnato, in successioni banali ordinamenti logici ed intenzionali, in ogni evento del mondo qualcosa che ruota intorno alle conseguenze che ne potranno venire a sé. Qui, si noti, la persona in questione (come spesso nelle fasi iniziali della schizofrenia) non manca affatto di capacità raziocinativa. I suoi ‘errori’ non sono allucinazioni o inferenze logiche sbagliate, bensì mutamenti nelle priorità di ciò che è saliente, e dunque di ciò che è soggettivamente probabile. Ogni presunta ‘smentita fattuale’ qui può essere messa fuori gioco da una riorganizzazione interpretativa, e con ciò si vede che ad aver subito una metamorfosi non è la capacità inferenziale, bensì l’ordinamento assiologico: il mondo del paranoico è ora governato dalla paura e dall’autoreferenzialità.
Prendiamo un altro caso come quello delle depressioni gravi. Anche il depresso, fino alle ultime fasi degenerative, non presenta alcun intaccamento delle facoltà cognitive. Ciò che cambia è la capacità di interessarsi alla dimensione futura. Il depresso si ritrae progressivamente dalla sfera progettuale e protensionale, fino a cadere nell’inerzia, o addirittura nella catatonia. In una prima fase (quella in cui i depressi possono essere pericolosi per sé e per gli altri) ciò si presenta come un appiattimento ‘nichilistico’ di ogni valore, su di uno sfondo che ancora tende a proiettarsi verso il futuro: questa è la disperazione. Successivamente persino il ricordo di aver ‘avuto mai un futuro’ può essere spazzato via.
In entrambi questi casi (e gli esempi si potrebbero moltiplicare) la patologia psichiatrica si configura come un mutamento radicale nelle forme di ‘interessamento al mondo’, ovvero nell’ordinamento di valori. (Va da sé che quando si parla di ‘valori’ non si intendono principalmente quei valori di cui siamo consapevoli e che sapremmo verbalizzare, ma che della sfera assiologica rappresentano di solito solo la componente più superficiale.)
Ora, la domanda cruciale è la seguente: da quale punto di vista noi possiamo determinare le forme psichiatriche di cui sopra come ‘patologiche’? Dopo tutto, come è stato notato più volte, questi soggetti hanno ‘il loro mondo’, e l’erroneità del loro mondo (di contro alla correttezza del nostro) non può essere oggetto di alcuna ‘dimostrazione’ cui essi possano concordare. (Più radicalmente ancora, dovremmo ricordare, con Nietzsche, che anche il ritenere ‘erroneità’ o ‘correttezza’, ‘verità’ o ‘menzogna’ come qualcosa di importante dipende da un ordinamento assiologico specifico). Ma allora, se in qualche modo il mondo della persona affetta da melancholia, o da schizofrenia paranoide, ha pari dignità del nostro, non dovremmo semplicemente astenerci dal parlare di patologia?
Qui il problema tocca i suoi confini definitori. Qualunque sia la nostra decisione sul piano legale o istituzionale circa la ‘patologia mentale’, noi non possiamo evitare di riconoscerla e di isolarla. Possiamo naturalmente isolarla nelle forme più varie, criminalizzandola, rinchiudendola o invece magari facendone un benemerito ‘Fool’, il matto del villaggio cui vengono concessi speciali privilegi. Ma sia come sia, il punto è che le persone con quelle caratteristiche comportamentali si manifestano come incapaci di partecipare al funzionamento ordinario delle relazioni sociali. E in questo senso, una comunità che non fosse in grado di isolare il comportamento ‘patologico’ correrebbe il rischio di compromettere la propria capacità di autoriproduzione, e dunque in definitiva di sopravvivenza. L’anormalità che designiamo come patologia psichiatrica rende le persone costitutivamente inaffidabili. Il giudizio di anomalia o patologia qui ha fondamentalmente questa base, che è una base assiologica e sociale: il ‘pazzo’ può essere buono o cattivo, piacevole o repellente, ma ciò che lo separa e stigmatizza è l’essere socialmente disfunzionale. E questo, per essere chiari, non è un ‘problema marginale’, ma il più fondamentale dei problemi etici. Nessuno può convincere con argomenti il depresso terminale che si stia lasciando morire, che ‘la vita vale la pena di essere vissuta’. Questo è un fattore assiologico che o c’è o non c’è, ma non può essere oggetto di spiegazione, bensì è presupposto affinché una qualunque spiegazione possa avere presa. In definitiva il giudizio di separazione tra noi, ‘sani di mente’, e lui, affetto da patologia psichiatrica è un giudizio di valore dove le spiegazioni hanno un termine. E naturalmente, l’errore più sciocco che potremmo fare è quello di pensare, in linea con il moderno soggettivismo etico, che siccome è un giudizio di valore a definire questo confine, allora tale confine non sarebbe nulla di sostanziale od oggettivo. In verità non c’è al mondo nulla di più sostanziale ed oggettivo di un giudizio di valore condiviso.
- L’anormalità come immoralità nella sfera sessuale
Estendiamo ora la discussione ad un secondo caso qualificante, quello dei giudizi e pregiudizi concernenti preferenze e comportamenti sessuali. Non di rado valutazioni psichiatriche e valutazioni dei comportamenti sessuali si sono sovrapposti, ma l’ambito della sessualità ha uno specifico che merita qualche considerazione a parte. Anche nel caso della sessualità, non meno che con riferimento alla salute mentale, stabilire il carattere patologico di certi comportamenti o di certe preferenze ha talvolta comportato esiti che oggi giudichiamo come ingiustificabili abusi. Va inoltre osservato che si tratta di un ambito in cui, pur in presenza di considerevoli variabilità individuali, storiche ed antropologiche, la tendenza a produrre modelli normativi è forse persino più intensa che nel caso della patologia mentale. A titolo di esempio paradossale può bastare l’evoluzione negli USA del giudizio scientifico (e politico) sull’omosessualità. Fino al 1972 l’omosessualità era inclusa dall’American Psychiatric Association tra le patologie mentali; nel 1973, anche sulla scorta di fortissime pressioni da parte di attivisti dei diritti gay, l’omosessualità venne tolta dall’elenco delle malattie nel DSM-III; neppure quattro anni dopo era l’omofobia ad entrare nell’elenco delle malattie psichiatriche. Svolte del genere sembrano segnalare più che la sobrietà di una maturazione nel giudizio scientifico, un’ipersensibilità sociale che esige di sfociare comunque in stigmatizzazioni normative.
Ora, anche qui, per comprendere il funzionamento e la portata dei giudizi di normalità è opportuno esplorare il senso del limite che li contrappone all’anormalità o patologia. Come nel caso della malattia mentale, esiste chi è propenso a escludere per definizione la legittimità di ogni giudizio di anormalità o patologia con riferimento alla sessualità. Queste posizioni partono anche dalla constatazione di alcuni slittamenti storici come quello menzionato sopra intorno all’omosessualità: se abbiamo potuto mutare giudizio così radicalmente e in un così breve torno d’anni, quanto è plausibile che i nostri giudizi in materia siano validi? Non è più semplice rinunciare senz’altro a giudizi in merito?
Le cose, tuttavia, non sono così semplici. Prendiamo anche qui un paio di esempi che ci permettano di esplorare il senso del confine. Per quanto Levi-Strauss, come noto, parli dell’incesto come del più antico dei tabù, in effetti esso venne praticato più che occasionalmente nella storia; tra le istanze più note che troviamo vi è l’endogamia presso le famiglie nobili degli Inca o degli Egizi, ma non mancano esempi biblici (Lot e le figlie, Abramo e Sara, ecc.).
Nonostante l’antichità del tabù, è però interessante notare come l’incesto non sia più considerato reato in molti sistemi legali liberali, ad esempio in Spagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Nel 2014 il Consiglio Etico tedesco ha chiesto che l’incesto non venisse più considerato reato, con la motivazione che “Non è compito del diritto penale applicare standard morali o porre limiti alle relazioni sessuali tra cittadini adulti ma di difendere i singoli dai danni e da gravi disturbi, e proteggere l’ordine sociale della comunità”. L’idea qui sembra essere che, purché non generi figli (eliminando il rischio di tare genetiche) anche l’incesto dovrebbe essere derubricato a questione di libera scelta tra adulti consenzienti. In effetti, come sempre nei modelli etici liberali, qui è l’idea stessa che possano esistere standard morali a risultare sostanzialmente inaccessibile: la moralità è vista tutt’al più come una concessione a dogmi antichi, o come una genuflessione opportunistica a qualche istituzione ecclesiastica. Per il resto ci sarebbe spazio solo per leggi positive, che intervengono eventualmente per prevenire danni a terzi. Ciò che sembra completamente sfuggire a questo modello etico è il fatto che morale non è sempre stato solo il nome di un’imbarazzante reliquia del passato; ‘morale’ è ciò che rappresenta e rinforza il mos, il costume sociale, dunque ciò che distingue, anche sul piano pedagogico ed esemplare, forme di comportamento esemplari da forme di comportamento deprecabili. Invero, l’idea liberale che possano esistere società governate solo da leggi ma prive di indirizzi morali è uno dei, non pochi, disastri culturali della contemporaneità. Nella fattispecie, e fortunatamente, checché ne pensi il Consiglio Etico tedesco, la saggezza del ‘pregiudizio’ tradizionale è ancora sufficientemente radicata da non essere scosso da queste puntate ‘progressiste’.
Le ragioni antropologiche che vengono di solito menzionate per spiegare la condanna dell’incesto sono di due ordini, il primo biologico (la fragilità genetica dei frutti di matrimoni endogamici) e il secondo sociale (l’ampliamento dei legami sociali con l’imposizione delle unioni esogamiche). Entrambi sono ottimi motivi, ma entrambi, se vengono trattati come semplici ‘ostacoli’ particolari potrebbero essere aggirati. Potremmo fare in modo che l’incesto non abbia progenie, o, perché no?, potremmo magari riuscire presto a correggere eventuali tare ereditarie con qualche ingegnoso intervento di ingegneria genetica. E d’altro canto, nelle vaste società odierne il rischio di ‘provincializzazione endogamica’ di famiglie o clan sembra trascurabile. Dunque perché mai preservare una stigmatizzazione dell’incesto? Perché non dichiarare anche l’incesto una forma legittima, normale, giustificabile della sessualità? Non è giunto forse il momento di lasciarci alle spalle anche questa reliquia del passato?
Già. E in effetti, se non si intende il senso del ‘morale’, questa è l’unica conclusione cui si può coerentemente giungere. Il solo senso inderogabile nel divieto dell’incesto sta nell’intenderlo in rapporto ad un’idea di società, di comunità, o di mondo umano. Il punto di divieti morali, come di modelli morali (virtù), sta nel presentare l’idea di un costume buono di contro ad un costume cattivo, di un comportamento che se normalizzato è latore di prosperità e di un comportamento che se normalizzato è invece latore di disgregazione. Se un mondo in cui l’incesto possa diventare un costume ci appare indesiderabile, allora abbiamo ragioni per stigmatizzarlo moralmente. Ma l’incesto ‘normalizzato’ come costume sarebbe una pratica socialmente disgregante: si tratta di un comportamento che sostituisce, deforma e falsifica relazioni costituenti nel funzionamento familiare (l’autorevolezza del genitore, la complicità tra fratelli, ecc.) e si tratta per di più di un comportamento insidioso in quanto può consumarsi in forme e contesti difficilmente controllabili (l’interno della famiglia). Questi tratti, al di là del rischio genetico, fanno sì che l’incesto rappresenti un comportamento ‘socialmente deformante’, un comportamento che nessuna società può permettersi diventi costume, e ciò ne decreta la condanna morale.
Prendiamo brevemente in considerazione, per completare il quadro, un secondo caso, ovvero quello della pedofilia. La pedofilia è una delle più note parafilie. Per parafilia si intende una sostituzione del fine normale (piacere, eccitazione, orgasmo) o dei partner ordinari (uomini o donne) dell’attività sessuale con finalità o partner anomali. Rientrano nell’insieme delle “parafilie” molteplici varianti di queste sostituzioni che vanno dal feticismo al masochismo, dall’esibizionismo al voyeurismo, dal sadismo alla pedofilia appunto. Mentre per molte di queste parafilie c’è stata e c’è ampia tolleranza (es.: feticismo), per la pedofilia la tolleranza è stata, ed è, generalmente molto più bassa. Come nel caso dell’incesto si tratta di una pratica insidiosa, nel senso che sostituisce e distorce relazioni fiduciarie tradizionali tra adulti e bambini, che si presta a mimetizzarsi sotto vesti difficilmente rilevabili (l’affidamento al prete, all’insegnante, ecc.), e che tende a lasciare strascichi psicologici (statisticamente molti pedofili risultano essere stati a loro volta abusati da bambini).
Ma naturalmente si sbaglierebbe a pensare che anche la pedofilia non abbia i suoi campioni. Molto nota è la NAMBLA (North American Man/Boy Love Association) che rivendica il diritto alla normalizzazione del rapporto pedofilo, visto come un’accettabile variante dell’amore sessuale, ma ve ne sono molte altre: la International Pedophile and Child Emancipation, la Australian Man/Boy Love Association, la Coalition Pédophile Québécois, la Danish Pedophile Association, ecc. ecc. Peraltro, in alcuni paesi con legislazioni liberali particolarmente ‘avanzate’, come l’Olanda, le associazioni che promuovono la pedofilia sono state legalizzate. Se ci si prende la briga di andare a vedere gli argomenti che vengono sollevati dai difensori della pedofilia si trovano idee come quella che amare non può mai essere sbagliato, che non bisogna confondere l’amore con la violenza, che un contatto precoce con la sessualità adulta può essere anzi benefico per il bambino rispetto ai soliti tabù, che l’idea che i bambini non abbiano una capacità di valutazione di chi li ama è un pregiudizio, che essi meritano di essere considerati capaci di autodeterminazione sessuale, ecc. E dopo tutto, siamo ben certi che in nessun caso particolare potremmo mai trovare che queste idee non contengano qualcosa di vero? E se abbiamo questo dubbio, allora, perché non dare una chance anche a queste ‘opzioni emancipative’?
Tra i comportamenti sessuali la pedofilia è uno dei pochi che merita ancora la considerazione psichiatrica di ‘patologia’. Ma è anche chiaro che con ciò niente di definitivo è stato detto. Come in molte patologie psichiatriche non esistono qui agenti patogeni definibili, né eziologie chiaramente circoscrivibili, né ‘cure’ particolarmente efficaci, dunque il piano della classificazione scientifica non sembra tale da impedire rovesciamenti valutativi, come ve ne sono stati in passato in altri casi. In effetti, l’unico baluardo effettivo nei confronti della ‘normalizzazione’ della pedofilia consiste nelle resistenza di ‘valutazioni morali’, quelle valutazioni che l’odierna cultura occidentale tratta sempre più spesso come immotivabili atavismi o vaghi pregiudizi. E naturalmente se i giudizi morali non trovano più alcuna copertura razionale essi finiscono per logorarsi ed essere obliati.
Ma anche qui la base razionale ultima dello stigma morale è semplicemente la collisione tra le relazioni sociali normali, che sono normali in quanto consentono l’autoriproduzione delle nostre società, e relazioni come quelle istituite dalla pedofilia, che, divenendo mos, costume, abito comune, normalità, tenderebbero a disgregare le prime. È importante ricordare che la sessualità, nell’ambito dell’autoriproduzione sociale, non è un esempio qualunque, tra gli altri, ma è il nesso cruciale, quello attorno a cui si distribuiscono ruoli e competenze primari, necessari perché una società possa continuare ad esistere intergenerazionalmente.
- Conclusioni
1) La normalità rappresenta dunque la casistica esemplare, intorno a cui si costituiscono i fondamentali modelli e le istanze pedagogicamente esemplari di comportamento. I giudizi di normalità non sono aggirabili, anche se cosa rientra nella sfera della normalità può variare. Chi pretende di togliere il senso implicitamente normativo alla normalità, lo può fare solo con una forzatura, nella forma di veti o censure espressive (political correctness) che però rendono solo clandestini dei giudizi inevitabili.
2) La sfera della ‘non-normalità’ tuttavia non è omogenea, in quanto non tutti i giudizi di anormalità definiscono le medesime forme di giudizio ed atteggiamento. Abbiamo qui distinto tre istanze differenti, nominate come ‘anomalia’, ‘patologia’ e ‘immoralità’, rispettivamente.
2.1) La semplice anomalia è un comportamento che rimane decentrato rispetto alla normalità, perché se concepito come norma generale non consente l’autoriproduzione sociale. In questo senso, ad esempio, una coppia volontariamente priva di figli rappresenta un’anomalia, e, secondo questa definizione, la rappresenta anche se le coppie volontariamente prive di figli divenissero la maggioranza delle coppie esistenti. Una tale condizione è detta infatti ‘anomala’ in quanto non può rappresentare una condizione che stabilisce un modello normativo, giacché se ‘normalizzata’ comporterebbe la mancata autoriproduzione (cioè l’estinzione) di una società. L’anomalia di per sé non richiede stigmatizzazione (anche se in certe condizioni la sua valutazione può scivolare nel giudizio di immoralità), ed in una società in buona salute può ricevere non solo tolleranza, ma anche empatia.
2.2) La patologia è un comportamento decentrato rispetto alla normalità e che consiglia trattamento (anche se non lo obbliga). La patologia si presenta come più insidiosa della semplice anomalia perché non rientra nella sfera delle ragioni, ma delle cause, e quindi non è sensibile a forme di convincimento: il malato è come è non per responsabilità/scelta propria. Anche la patologia risulta ostativa al buon funzionamento di una società, ma qui il problema posto da un possibile ‘divenire norma’ della patologia non si pone, nel senso che non trattandosi di comportamento volontario essa non può divenire un costume sociale. Se si diffonde ha il carattere di un’epidemia, non di un costume. Quando un comportamento anormale viene giudicato essere una patologia esso richiede perciò di essere sorvegliato, per evitarne la diffusione involontaria ed, eventualmente, per curarla. Diversamente dalla semplice anomalia, la patologia non riceve empatia ma eventualmente compassione, e non viene trattata con tolleranza (termine che si attaglia a scelte volontarie), ma può essere trattata con umanità.
2.3) L’immoralità invece concerne l’anormalità di un comportamento, in quanto scelta soggetta alla volontà, in quanto può aspirare a divenire costume, e che divenendo costume verrebbe a confliggere frontalmente con l’autoriproduzione sociale. Qui il giudizio di condanna è appropriato, come è appropriata l’intolleranza (che non significa l’odio).
3) È chiaro che quali comportamenti rientrino di diritto in quali fattispecie può essere oggetto di variazione storica, sulla scorta dello stato delle conoscenze, ma anche delle condizioni sociali correnti. Un comportamento semplicemente anomalo può divenire immorale se la sua perseveranza mette a repentaglio l’autoriproduzione sociale (es.: se la diffusione delle coppie volontariamente prive di figli raggiungesse dimensioni tali da minacciare la società di estinzione). Oppure, un comportamento giudicato come immorale può essere riletto come patologico (per un caso come quello della pedofilia vi è una frequente oscillazione tra queste due interpretazioni). Ma mentre cosa cade di volta in volta in una o nell’altra classe può variare storicamente, la necessità di distinguere normalità da anormalità, e i tre differenti atteggiamenti nei confronti dell’anormalità sono riconoscibili trasversalmente a differenti contesti storici.
4) La necessaria esistenza di un carattere normativo della normalità implica la necessità di ricorrere, in fasi pedagogiche iniziali, a distinzioni stereotipate. Gli stereotipi sono dunque parte costitutiva inevitabile del processo di orientamento cognitivo nell’apprendimento di ciò che è auspicabile o meno perseguire. Dopo di che, è desiderabile e da incentivare che nella maturazione intellettuale e cognitiva delle persone la rigidità, semplicità e genericità degli stereotipi iniziali lascino spazio ad una crescita informata della complessità, attenta alle varianti particolari. Ma il passaggio attraverso una fase di stereotipizzazione è in qualche misura inevitabile.
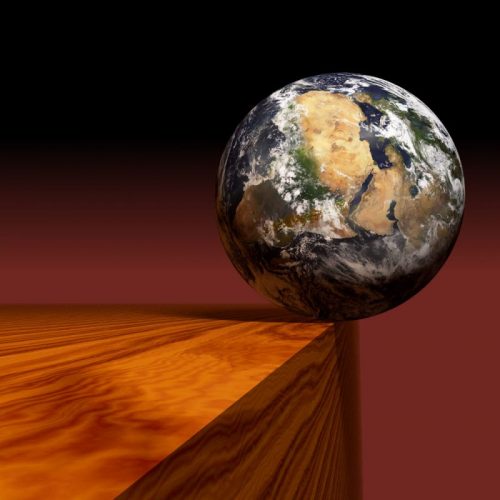
Buonasera,
premetto che non sono affatto un esperto del settore, ma per caso sono capitato su questo articolo che ho trovato molto interessante.
Non mi è chiara, tuttavia, la soluzione proposta: come è possibile fondare un sistema legislativo su un insieme di valori condivisi e come è possibile che questo sistema non incorra in altri “errori” grossolani? (Mi riferisco ad esempio al caso dell’omosessualità, recentemente declassata ad anomalia sessuale, ma curata con rimedi empirici e del tutto inefficaci fino a qualche decennio fa).
Trovo che l’insieme di valori condivisibili da un gruppo di individui dipenda in buona parte dal momento storico contingente e per il resto dalla società a cui questi individui appartengono e mi sembra che i “valori condivisi” siano in continua evoluzione.
Prendiamo per esempio la rivoluzione francese: prima di questa i valori condivisi avevano sicuramente al loro interno qualche riferimento al potere assoluto del re; un gruppo ristretto di individui con ideologie progressiste (Liberté, Egalité, Fraternité) ha portato una rottura nella società dell’epoca. A questo punto i valori condivisi sono cambiati radicalmente e la società si è riassestata su nuovi valori.
La questione è senz’altro pertinente, anche se travalica quanto tentato in queste poche pagine. Non ci ho provato neppure a “fondare un sistema legislativo su un insieme di valori condivisi”, perché processi del genere sono processi storici altamente complessi, in cui bisognerebbe entrare in una miriade di dettagli. Provo però a rispondere solo al punto più generale, che mi pare sia riassumibile nei seguenti termini (mi corregga se ho mal interpretato): “Come possiamo fondare norme positive, leggi, ecc. su valori, se i valori medesimi non sono stabili ma hanno un carattere storico”.
Una risposta completa richiederebbe troppo spazio, ma un abbozzo di risposta può essere il seguente.
‘Fondare’ non significa fondare una volta per tutte, o definitivamente. Ci sono possibilità, conoscenze e capacità operative che sono disponibili in un’epoca e non in un’altra, ed esse incidono pesantemente sulle forme normative concrete. Sarebbe privo di senso immaginare di poter dedurre una legge immediatamente da un principio / valore: i principi o valori passano necessariamente attraverso una possibilità di applicazione contestuale, che non può essere fatta astrattamente.
Provo a fare un esempio, per capirci. In ogni cultura di ogni tempo si è avuta percezione evidente del ‘valore della vita dei propri consimili’: togliere la vita di un ‘alter ego’ è sempre stato considerato un atto pesante, grave, denso di significato, non certo un atto qualunque come grattarsi o schiacciare una zanzara.
Potremmo però da ciò dedurre una norma che vieta in ogni caso l’uccisione di un consimile? Potremmo dedurre sensatamente un divieto universale della pena di morte o persino dell’uccisione per autodifesa?
No, un gruppo sociale potrebbe magari provare a farlo, ad esempio per motivi religiosi, ma non è difficile immaginare che in certi contesti storici rimanere fedeli ad una tale norma pratica potrebbe significare l’estinzione. In una comunità nomade, come i Mongoli, la pena di morte veniva comminata con grande facilità rispetto ai nostri standard, ma bisogna comprendere come per loro fosse estremamente difficile concepire efficaci pene alternative per chi fosse ritenuto socialmente pericoloso (una comunità nomade non ha prigioni). Schiavitù o morte erano le opzioni fondamentali. Qui non c’è bisogno di supporre che i Mongoli attribuissero un valore radicalmente diverso all’uccisione di conspecifici, rispetto a noi. A cambiare radicalmente è però il modo in cui quel valore poteva combinarsi in situazioni materiali concrete con altri valori, come l’autopreservazione del gruppo sociale.
Proverei perciò a rispondere così: alcuni ‘valori’ o ‘indirizzi assiologici’ di fondo sono fondamentali per tutte le società in quanto ogni società opera avendo di mira la propria perpetuazione (non come semplice sopravvivenza biologica: la riproduzione delle proprie qualità e dei propri significati). Ma il fatto stesso che i ‘valori’ o ‘indirizzi assiologici’ siano più di uno esige di trovare di volta in volta un equilibrio tra di essi, equilibrio che dipende da quali cose concretamente, in una certa epoca, e in una certa società, si sa e si può fare.
Coraggioso e interessante. Forse l’avevi già fatto nell’intervento precedente, ma sarei stato curioso di leggere qualche tua considerazione sullo statuto sui generis di queste norme che orientano i nostri giudizi di normalità, anomalia, patologia e immoralità. Insomma un tuo parere sul rapporto tra valore e genealogia, che è un tema che mi appassiona in questo periodo. Come sai bene, il rapporto tra norma e contingenza è essenziale nella visione post-darwiniana della natura. La differenza sessuale, per esempio, non è sempre esistita in natura e questo, ovviamente, offre il destro a chi, più o meno consapevolmente, prova quello che il mio amico Alessandro Bellan chiamava l’orrore del determinato. (È una sindrome molto diffusa nel nostro mondo – pensa solo ad Agamben, che è da sempre il campione di questo atteggiamento.) Nella filosofia contemporanea, l’orrore per il determinato, quando si sposa con un temperamento genericamente humeano, conduce spesso a una decostruzione nominalista di ogni forma o struttura dotata di significato normativo intrinseco. Un filosofo della biologia superintelligente che ha sempre difeso una posizione del genere, a partire dalla sua critica del concetto di specie, è David Hull. Qualche anno fa ho tradotto un suo saggio (molto bello) sulla natura umana. Te lo linko. Probabilmente lo conosci già. Comunque, lui offre lo sfondo teorico alla curiosità che qui non sono in grado di articolare più di tanto. Buon lavoro! https://www.academia.edu/33203637/David_L._Hull_La_natura_umana
Il tema è vastissimo, ma provo ad abbozzare una risposta intanto partendo da una posizione come quella di Hull. Ciò che Hull dice, se tradotto in termini filosofici classici, è una tesi antichissima e molto nota: in sostanza ciò che ci sta dicendo è che in natura non esistono essenze, ovvero che nessuna determinazione reale (empirica) presenta mai confini netti o identità descrivibili come elenco esaustivo di tutti e soli i suoi attributi. Per quanto io cerchi di individuare soglie rigide tra gli enti naturali, troverò sempre varianti o casi intermedi. Se definisco l’uomo come ‘animal rationale’ mi trovo nell’imbarazzo di fare posto a uomini folli o dementi, se definisco l’identità della specie come ciò che è in grado di riprodursi producendo a sua volta esemplari fertili, mi trovo nell’imbarazzo di far posto a membri di una specie infertili, ecc. ecc. A questo approccio la risposta che la storia della filosofia ha dato ha preso il nome di Idealismo, in tutte le sue varianti. L’idealismo, come ovviamente sai, afferma che l’identità del modello (eidos) non può mai essere estratto dalla pluralità dei casi particolari, ma, al contrario, che la nostra capacità di individuare modelli dotati di identità è presupposta alla capacità di identificare casi particolari come tali.
Sul piano epistemologico trovo già le obiezioni platoniche definitive. Ma il vero problema per l’idealismo si è sempre posto quando si trattava di definire lo statuto ontologico delle ‘essenze’ (o ‘Idee’). La proposta platonica di una sussistenza separata ed antecedente delle idee (il “mondo delle Idee”) incontra notoriamente numerosissime pesanti obiezioni. Ciò che io però sostengo, nel mio piccolo, è che abbiamo sempre cercato le essenze nella dimensione sbagliata: ciò che le essenze hanno di cruciale sono i loro confini, non il loro contenuto, e tali confini sono differenziazioni imposte da istanze assiologiche (direzioni, preferenze, orientamenti).
Una discussione accademica di questo punto, se ti va, la puoi trovare nel mio articolo “The Ontological Status of Essences in Husserl’s Thought”.
Ma per un cenno meno formale, provo a formulare un paio di esempi di tenore affine alla discussione di Hull. Prendiamo la distinzione tra vita e non vita. Ogni definizione biologica della ‘vita’ incappa notoriamente in infiniti problemi, tant’è vero che, paradossalmente, la domanda che fonda la scienza biologica “Che cos’è vita?” è ancora la più lontana da trovare risoluzione. Per ogni tratto materiale specifico che possiamo attribuire alle entità viventi ne possiamo sempre trovare alcuni discutibili, problematici, incerti. Nelle ‘definizioni materiali’ troviamo come presunti ‘attributi essenziali’ della vita cose come la presenza di un metabolismo, di ordine, di capacità riproduttiva, di omeostasi, di una storia evolutiva, ecc. E per ogni attributo si trovano casi limite, eccezioni. I virus hanno storia evolutiva, hanno capacità di riprodursi, ma non hanno metabolismo; un animale sterile è certamente vivo, ma non può riprodursi, ecc.
Ora però, il punto chiave da intendere è che, a prescindere da ogni dettaglio oggettivo, per le forme di coscienza che noi siamo non c’è distinzione assiologicamente più cruciale di quella tra vita e non-vita, intendendo per vita ciò che viviamo come vita, e che ci abbandona con la morte. Questa distinzione potrà anche avere nei suoi esempi concreti bordi sfumati e un’infinità di casi ambigui, di identificazioni parziali, ma ciò che è cruciale è che per noi importa e dunque noi cerchiamo di individuarla, cerchiamo di rinforzarla, cerchiamo di tracciare quel confine che di per sé in natura non è tracciato. La separazione assiologica tra vita e non vita crea, o cerca di portare alla luce, le essenze/idee ‘vita’ e ‘non vita’. – Come secondo esempio, prendiamo la definizione di ‘specie’. Hull anche qui può avere buon gioco a trovare per ogni tratto materiale che attribuiamo ad una specie una qualche situazione ponte verso ‘specie diverse’, per ogni attributo essenziale comunanze o differenze con altre specie. E verso la più classica delle definizioni di specie, cioè la capacità di creare progenie fertile, egli può obiettare che purtuttavia ammettiamo nella specie anche gli individui infecondi. O, ancora, che si tratta di un criterio arbitrario, visto che dopo tutto vi sono specie che per la separazione ambientale sono considerate differenti, come grizzly e orso bianco, anche se in cattività hanno dimostrato di avere progenie fertile.
Ma anche qui, al netto della miriade di dati che possiamo raccogliere, il punto cruciale è che per noi come le coscienze umane esistenti che siamo la differenza tra la capacità di riproduzione del gruppo (società, comunità, ecc.) è assiologicamente saliente e dunque siamo interessati a tracciare questo confine, anche se questo confine in natura non è tracciato da nessuna parte nel marmo.
In questo senso i casi borderline vengono posti come anomalie, perché siamo interessati a tener ferma quella distinzione, e nessun argomento ci convincerà mai, se non intellettualisticamente, che siccome niente in natura corrisponde precisamente alla separazione categoriale tra vita e non vita, o tra riproducibilità di gruppo (specie) e sua impossibilità, allora queste distinzioni ‘non esistono’.
Ho letto questo articolo e l’ho trovato interessante sotto molti punti di vista. Perlopiù trovo condivisibili le osservazioni che fa ma non posso non esprimere il mio scetticismo sull’ultima parte dell’articolo, quella di stampo più normativo. Se ho ben capito quanto sostiene, per lei la normalità possiede un valore positivo in quanto indica ciò che è preferibile per la società, e ciò che è preferibile è in buona sostanza ciò che permette di conservare la società (o specie). Riprendendo il suo esempio: una società in cui l’assenza di procreazione fosse la normalità sarebbe davvero eticamente deprecabile? Se tutti liberamente scegliessero di non avere più figli per le più varie ragioni personali, ci sarebbe davvero qualcosa di male? Oppure se tutto il mondo si deprimesse (questo esempio va preso con le pinze sia chiaro, visto che la depressione non è una scelta razionale) e questo portasse alla distruzione della società, sarebbe così grave dato che è la società stessa a deciderlo (in assenza cioè di violenza esterna)?Il punto mi sembra è scegliere se sia più importante ciò che è teoricamente utile e salutare per la società (che addirittura i bambini dovrebbero imparare durante l’infanzia) o se sia più importante la libertà di ognuno di non seguire la normalità e di agire secondo il proprio rispettabilissimo (anche se disfunzionale) interesse. Concordo che cercare di modificare i pregiudizi e gli stereotipi mediante imposizioni all’insegna del politically correct sia talvolta ridicolo ma soprattutto inutile (wittgenstein docet) ma pensare che questi siano dei toccasana per la società così che questa possa conservarsi prospera mi sembra pesantemente conservatore e in buona sostanza insostenibile razionalmente. Ad ogni modo le sue opinioni mi affascinano moltissimo e le trovo simili a certe tesi di Edmund Burke che vorrei approfondire. Saluti, Lorenzo Soffiato
Non avendo mai detto da nessuna parte che “pregiudizi e stereotipi siano dei toccasana per la società”, su ciò non rispondo.
Più interessante mi pare l’altra osservazione, che riporto: “Il punto mi sembra è scegliere se sia più importante ciò che è teoricamente utile e salutare per la società (che addirittura i bambini dovrebbero imparare durante l’infanzia) o se sia più importante la libertà di ognuno di non seguire la normalità e di agire secondo il proprio rispettabilissimo (anche se disfunzionale) interesse.” –
– A me pare che questo punto sia risolto in partenza per una ragione di fondo, ovvero in quanto non è possibile difendere una libertà individuale che abbia come prezzo ultimo l’eliminazione delle precondizioni perché una libertà individuale esista (qui, la società). Ciò che chiamiamo libertà individuale sul piano morale (dunque non nel senso del libero arbitrio ontologico o epistemologico) deve infatti il suo valore alla possibilità di ‘sottrarsi’ alla normatività sociale, normatività che è però data per presupposta e che è precondizione per il nascere, crescere e prosperare di ciascun individuo. Nessun individuo può nascere, crescere e prosperare se non in grazia di relazioni sociali funzionanti (a partire da quelle famigliari). Libertà, emancipazione, autonomia hanno valore in quanto esiste prima una cornice di vincolo normativo, inclusione, eteronomia. Non c’è dunque nessuna possibilità che le istanze della libertà individuale possano essere considerate come sovraordinate assiologicamente alle istanze della riproduzione sociale, perché le prime non possono esistere senza le seconde. La ‘disfunzionalità’ che uno può sempre legittimamente rivendicare, come propria libera scelta, è solo quella che mette a repentaglio la propria esistenza individuale, e solo essa.
Sì probabilmente ho usato un tono troppo polemico in alcuni punti e me ne scuso. Non sono però del tutto persuaso da quanto sostiene. Capisco quando sostiene, se ho ben capito, che la libertà non sia un dato naturale originario ma che sia il frutto di una dialettica con una norma precostituita che la rende possibile e che quindi abbia un senso solo all’interno di una cornice fatta di relazioni a cui opporsi o a cui adeguarsi. Tuttavia penso anche che tale dialettica in fondo dei conti non si dia davvero. Nella mia personalissima opinione non c’è una reale opposizione tra norma e “devianza” ma al massimo convivenza tra norme diverse in cui siamo inseriti anche contemporaneamente. Per chiarire: non credo che una coppia che decida di non fare figli esca dalla normalità, penso che decida (credo inconsapevolmente) di partecipare ad una normalità diversa, magari meno maggioritaria ma pur sempre una normalità. Credo quindi che la libertà e l’autonomia (intese come liberazione-da) siano qualcosa di molto sopravvalutato e che in fondo la libertà risieda nel partecipare ad una delle tante normalità possibilmente senza ricevere interferenze. Ad ogni modo, grazie per la risposta e aspetto una sua opinione in merito!
I confini tra normalità e anormalità sono storicamente e culturalmente mobili, come ho scritto. Inoltre, come per tutte la categorie, anche per la determinazione di normalità o anormalità abbiamo a che fare con nozioni che hanno un centro, una periferia e una zona esterna: un passero è percepito come un membro ordinario della specie ‘uccelli’, un pinguino come un membro eccentrico della medesima categoria, un pipistrello – nonostante le analogie – come un membro esterno alla categoria. Parlare di una ‘pluralità di normalità’ è possibile come è possibile parlare di una pluralità di famiglie nella specie ‘uccelli’. Non significa che ad un certo punto non si riconosca qualcosa come un’anormalità senza remissione, ed anzi noi incontriamo sempre questi confini categoriali. Come mi pareva di aver detto chiaramente, nel contesto storico odierno una coppia che desideri non avere figli rientra in un’anomalia perfettamente conciliabile con l’autoriproduzione sociale, e dunque può essere intesa, in un linguaggio informale, come una ‘forma di normalità’.
Se il suo intento è invece quello di asserire che vi sono solo normalità, senza anormalità, questa è un’impossibilità logica: non c’è concetto che non sia definito attraverso i suoi confini, ovvero i punti dove esso non vale più.
E al di là dell’impossibilità logica, se vuole perseguire questa strada lei dovrebbe farsi carico di spiegare, contro le argomentazioni presenti nel testo, che situazioni come la schizofrenia o l’incesto possano rappresentare delle ‘normalità possibili’.
Buonasera. Certo, sulla variabilità storica della nozione di normalità non credo possa esserci dubbio ed è stato molto esplicito nel sostenerla quindi non volevo toccare il punto.
Lasciando stare anche l’impossibilità logica (penso di star sostenendo che il concetto di normalità è qualcosa di meramente statistico e che non abbia valore assiologico se non per ragioni psicologico-emotive) tornerei sull’incesto. Se ho ben compreso l’incesto sarebbe da stigmatizzare per la sua portata “deformante” sul piano sociale visto che ogni sua conseguenza in termini di danni materiali (problemi medici) potrebbe essere arginata o eliminata. Ritengo tuttavia che se l’incesto diventasse costume, mos, e quindi una variante tra tante del comportamento normale (c’è chi preferisce le bionde, chi le straniere, chi le sorelle) non vi sarebbero grandi conseguenze: un cambiamento nei ruoli familiari certo, alcune novità (forse scomparirebbe l’autorevolezza del padre -magari- o la complicità tra fratelli -sopravviveremo-) ma niente di così grave da provocare danni irreparabili (tranne il far storcere il naso a qualche benpensante). Insomma non vedo nulla di grave nel fatto che la società muti o “si deformi” e che questo possa spaventare o che possa creare un certo ribrezzo è solo una reazione viscerale da superare. Sulla schizofrenia sinceramente fatico a cogliere il problema in quanto mi sembra una questione abbastanza differente da quella dell’incesto. Non credo ci siano questioni valoriali in questione. Penso si tratti di un genere di normalità semplicemente atipica per la maggioranza (numerica) delle persone: non ci vedo nessuna ragione di stigmatizzazione, nessun “noi e loro” connotato moralmente. Potrebbe porsi il problema se, ad esempio fossero in un numero maggiore (magari la maggior parte della popolazione mondiale) ma allora si arriverebbe, penso, ad un qualche tipo di convivenza pacifica. Credo che nessuno inizierebbe a giudicarli moralemente, semplicemente si accetterebbe serenamente la diversità di prospettive senza necessariamente porsi in un’ottica di migliore-peggiore, auspicabile-non auspicabile.
As ogni modo, grazie per gli spunti di riflessione, sono temi che mi affascinano e difficilmente si trovano persone competenti con cui discuterli. E scusi anche la mole di commenti ma la pausa estiva va riempita in qualche modo