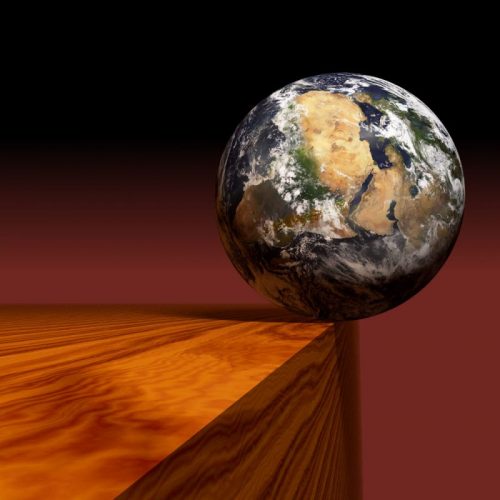1) L’UOMO FORTE E LA STORIA CHE SI RIPETE
Sondaggio Demos: l’80% degli italiani vede con favore l’idea di un “Uomo forte” al comando.
Ma va?
E’ persino noioso constatare il funzionamento dei soliti stessi meccanismi storici, con piccole variazioni, e ancor più noioso ascoltare lo stupore che suscitano.
Quello che sta succedendo è, con piccole varianti, la replica storica di ciò che è già accaduto un po’ più di un secolo fa in Europa:
1) La concorrenza economico-finanziaria produce le usuali conseguenze di lungo periodo: stagnazione o compressione salariale, crisi di domanda, caduta del saggio di profitto (eh, sì, il vecchio Karl). (Iniziò intorno al 1872, e ora si è riproposto a partire dal 1975 circa).
2) Ne segue la ricerca di punti di fuga dove recuperare margini di profitto. A fine ‘800 fu l’Imperialismo (ricerca di risorse materiali e umane a buon mercato). Oggi non serve imperialismo militare perché si può operare con delocalizzazioni e investimenti finanziari world-wide (magari solo qua e là difesi ‘in punta di baionetta’).
3) Le strategie di recupero di profitto del capitale non si ripercuotono però in benefici per le classi lavoratrici, né per la piccola borghesia. Ne segue crescita del malcontento.
4) la protesta viene incanalata verso l’esterno, secondo la consolidata tecnica della ricerca del capro espiatorio: Nazioni straniere in competizione che ci tolgono un ‘posto al sole’, odio verso i lavoratori stranieri che competono a prezzi inferiori, ecc.
5) Richiesta di recupero delle istanze nazionali, che divengono rapidamente nazionalismo e sciovinismo. (Oggi richiesta di ‘sovranismo’).
6) La strutture parlamentari si dimostrano incapaci di dare risposte senza violare interessi costituiti. Paralisi e inconcludenza della politica. Segue la richiesta a sempre maggior voce di interventi capaci di mettere fine alla ‘chiacchiera parlamentare’ oltre che di disciplinare la folla tumultuante (a fine ‘800 era la crescita dei socialisti).
7) All’Uomo Forte un secolo fa non si arrivò subito: ci volle prima il massacro della Prima Guerra Mondiale. Vediamo oggi cosa ci riserva il futuro. Magari questa volta invertiamo le opzioni e passiamo prima per l’Uomo Forte e poi per la fase conflittuale.
Lasciamoci sorprendere.
2) MALA TEMPORA CURRUNT
(SED PEIORA PARANTUR)
Ogni forma storica della civilizzazione ha prodotto le sue forme umane qualificanti.
Ci sono state civilizzazioni che hanno ottimizzato la produzione di feroci guerrieri. Altre che hanno prodotto astuti mediatori. Altre ancora che hanno prodotto robusti contadini o audaci mercanti, ecc.
Il capitalismo è quella forma storica della civilizzazione specializzata nella produzione seriale di stronzi.
3) MARX SU CAPITALISMO E IMMIGRAZIONE
Visto che Marx è stato cestinato dai nostri ‘sinistri’, che notoriamente la sanno più lunga, e pensano di avere davanti agli occhi inaudite novità, ecco una breve nota epistolare sulla dinamica tra capitalismo e immigrazione (qui non ‘extracomunitaria’, ma irlandese).
“In tutti i centri industriali e commerciali dell’Inghilterra vi è adesso una classe operaia divisa in due campi ostili, proletari inglesi e proletari irlandesi. L’operaio comune inglese odia l’operaio irlandese come un concorrente che comprime il tenore di vita. Egli si sente di fronte a quest’ultimo come parte della nazione dominante e proprio per questo si trasforma in strumento dei suoi aristocratici e dei suoi capitalisti contro l’Irlanda, consolidando in tal modo il loro dominio su se stesso. L’operaio inglese nutre pregiudizi religiosi, sociali e nazionali verso quello irlandese. Egli si comporta all’incirca come i bianchi poveri verso i negri negli Stati un tempo schiavisti dell’unione americana. L’irlandese lo ripaga con gli interessi della stessa moneta. Egli vede nell’operaio inglese il corresponsabile e lo strumento idiota del dominio inglese sull’Irlanda.
Questo antagonismo viene alimentato artificialmente e accresciuto dalla stampa, dal pulpito, dai giornali umoristici, insomma con tutti i mezzi a disposizione delle classi dominanti. Questo antagonismo è il segreto dell’impotenza della classe lavoratrice inglese, a dispetto della sua organizzazione. Esso è il segreto della conservazione del potere da parte della classe capitalistica.”
“Il colpo decisivo contro le classi dominanti in Inghilterra (…) può essere sferrato non in Inghilterra, bensí soltanto in Irlanda.” (Karl Marx, 1870)
4) BREVE NOTA AD USO DEGLI AMICI SOVRANISTI
Premesso che sono in sintonia con alcune delle istanze sussunte sotto il termine ‘sovranismo’, credo però che un’osservazione di fondo sia dovuta.
Prima di prendersela con l’ottusità della Merkel (che c’è), prima di deprecare l’austerità depressiva della Bundesbank (che nessuno nega), prima di lamentarsi degli squilibri dell’Eurozona (che esistono) è utile ricordare che la sovranità di uno stato comincia da:
1) Essere in grado di esigere le proprie imposte;
2) Avere controllo legale del proprio territorio.
Ricordo sommessamente che nel fervente europeismo italiano dei primi tempi una delle motivazioni di fondo era che <finalmente i nostri politici sarebbero stati messi sotto controllo e sorvegliati da istituzioni europee.> Per noi, infatti, l’idea di “delegare potere politico all’Europa” non era affatto visto con diffidenza (come altrove), e questo proprio perché avevamo scarsissima opinione della gestione del potere politico nostrano.
Con grande disappunto abbiamo poi scoperto che i politici tedeschi, francesi, ecc. non avevano tra le loro priorità quella di far prosperare noi.
Una vera disdetta.
Ora, è essenziale che venga rimossa l’idea illusoria che magicamente, una volta tolto il basto dei vincoli europei diverremmo finalmente ‘padroni del nostro destino’.
Queste sono balle.
Per divenire padroni del nostro destino noi dobbiamo avere a disposizione un ceto politico capace, il quale sia in grado innanzitutto:
1) Di ridurre ai minimi termini l’evasione ed elusione fiscale
(perché non possiamo aspettarci che lo facciano i politici bavaresi per noi, e non possiamo aspettarci che i cittadini bavaresi, per quanto ci possano stare antipatici, guardino in modo simpatetico ad un paese che piange miseria, mentre lascia intere fasce della popolazione di fatto esenti dal fisco.)
2) Riprendere possesso del nostro paese, e non parlo solo di sparute enclave camorristiche del profondo sud: parlo altrettanto di interi quartieri di Torino, Milano, Genova, Padova, ecc. (Che poi a violare la legge e spadroneggiare siano spacciatori marocchini o mafiosi italiani doc non è che questo faccia molta differenza.)
E, dunque, se volete fare la faccia feroce, cari sovranisti, di destra come di sinistra, cara Meloni, caro Salvini, caro Grillo, cominciate a votare norme draconiane in questi due ambiti, dedicatevi a riconquistare il paese dall’interno, a far pagare le tasse ai vostri amici, a riprendere legalmente possesso di aree del paese allo sbando.
E solo poi, eventualmente, andate a ‘battere i pugni a Bruxelles’.
Potrebbe capitare che una volta fatta la prima cosa, la seconda non sembri poi più tanto urgente…
5) ¡QUE VIVA EL COMPAÑERO TRUMP!
Trump è un pericoloso bamba, ma il ritorno del protezionismo americano (se fosse da prendere sul serio) potrebbe essere politicamente una buona notizia.
Perché?
Ma perché potrebbe, e dovrebbe, far riflettere i paesi sull’asimmetria fondamentale tra le strategie del ‘puntare sul mercato interno’ vs. ‘puntare sul mercato estero’.
Naturalmente, in un mondo ideale, l’apertura dei mercati, con la possibilità di ricorrere a produzioni specialistiche remote, è sempre un bene. Abbiamo frutta e verdura fuori stagione, autovetture e computer prodotti in luoghi remoti del pianeta, ecc.
Un paese che puntasse tutto sul solo mercato interno potrebbe introdurre dazi protezionistici fino a ridursi ad una condizione autarchica, il che implicherebbe un obiettivo impoverimento del paese stesso. Per un paese come l’Italia, con un forte apparato industriale di trasformazione e con poche risorse energetiche proprie si tratterebbe senz’altro di una soluzione pessima.
Ma questo non significa che strutturare le strategie economiche nazionali in modo da puntare in maniera unilaterale ai mercati esteri sia un’operazione intelligente.
In effetti è un’operazione suicida.
Per competere sul piano dell’export si può agire sul piano dell’innovazione del prodotto, con eventuali brevettazioni, offrendo qualcosa che non è offerto (o non con la stessa qualità) da altri, oppure si può agire sul piano del prezzo, offrendo qualcosa che è offerto da altri, ma in modo più economico.
La prima strategia richiede di potere, se necessario, ricorrere a supplementi di competenze e tecnologie dall’estero, dunque richiede di tenere il lavoro ad un livello qualificato ed attrattivo, in modo da attrarre risorse e da conservare potere d’acquisto internazionale.
Il problema della seconda strategia è che è facilmente adottabile solo da paesi con un tenore di vita basso, in cui costi di produzione bassi sono consoni alle aspettative delle persone e al peso del mercato interno. Quando un paese povero comincia ad arricchirsi, grazie al suo successo nell’export a buon prezzo, la maggior circolazione interna di denaro tende a generare crescita dei prezzi, dei salari e dei costi di produzione in generale, erodendo progressivamente il vantaggio competitivo iniziale (il proprio prodotto non è più il meno caro).
Quando un paese ricco come l’Italia adotta la seconda strategia esso crea le condizioni per il proprio declino.
La compressione dei costi di produzione, se opera sui salari deprime il mercato interno, se opera sul cambio svalutando la moneta (opzione ora preclusa all’Italia) si rende arduo il recupero di risorse dall’estero (non solo materie prime, ma anche tecnologia e operatori di alta qualifica), tendendo a perdere posizioni sul piano dell’innovazione e qualità del prodotto.
Inoltre l’impoverimento del mercato interno riduce i cespiti fondamentali della tassazione (su quelli esteri l’elusione è notoriamente facile) e con ciò si riducono anche le risorse dello stato da impiegare in investimenti, infrastrutture, funzionamento della giustizia, formazione, ecc. (tutti elementi cruciali anche per la qualità della produzione economica).
In questo quadro, per un paese così stupidamente legato al modello produttivo che ebbe successo negli anni ’50 (come è l’Italia), una bella guerra commerciale non può che fare bene.
Infatti essa può costringere la classe politica e quella imprenditoriale a capire che puntare tutto sul contenimento dei costi di produzione è una strategia imbecille, giacché basta un aumento arbitrario dei dazi per rendere inutili tutti gli sforzi più volenterosi nell’abbassamento del costo di produzione. L’attuale forma ricattatoria per cui o il lavoratore accetta condizioni sempre peggiori, oppure spostiamo la produzione in un paese dove la condizione del lavoro è già peggiore, diventerebbe immediatamente priva di senso, perché il risparmio a lungo termine dello spostare la produzione in Polonia o Cina può essere eliso immediatamente da un dazio arbitrariamente alzato dei nostri importatori.
Questo ricatto è possibile solo in un sistema di apertura costante e libera dei mercati.
Il sistema di ricatto sui lavoratori e di prosciugamento delle risorse interne italiane potrebbe perciò diventare immediatamente una strategia manifestamente assurda anche per gli imprenditori più ottusi.
¡Que viva el compañero Donald!
P.S.
Il premier Paolo Gentiloni, di fronte alla prospettiva di un aumento drastico dei dazi di importazione USA su prodotti italiani si è espresso così:
“Un Paese come l’Italia deve essere affezionato all’idea che la qualità non ha frontiere e che dazi, protezionismi e chiusure non possono essere barriere in grado di mettere un freno alla qualità. Se c’è
qualità ci sono business, scambi commerciali, crescita e benessere per tutti. Abbiamo le carte in regola per competere in questo mercato senza essere particolarmente aggressivi nei confronti di nessuno, perché l’Italia è un Paese aperto che punta sulla qualità e sugli scambi e così facendo è capace di affermare l’essenza della propria manifattura e le sue capacità industriali e artigiane”.
Al netto della verbosità il presidente del consiglio dice una cosa semplice:
“Anche un aumento dei dazi del 100% non impediranno a prodotti italiani di qualità di essere acquistati in USA”.
E questo effettivamente è vero.
Solo che a questo punto qualcuno potrebbe chiedere: com’è che poi, in Italia, le battaglie e le prediche sulla ‘responsabilità’ dei lavoratori si fanno tutte inesorabilmente per abbassare di qualche punticino percentuale il costo del lavoro?
In modo da essere “competitivi nell’export”, si dice.
E al costo di deprimere il mercato interno.
Che qualcuno ci stia pigliando per il culo?
6) UNA SINOSSI DELLA CRISI SUBPRIME
http://mimesis-scenari.it/2014/11/28/il-giro-di-vite-una-sinossi-della-corrente-crisi-2/
È sempre difficile provarsi a fornire una visione d’insieme di vicende storiche all’interno delle quali si è collocati. Ma, nonostante l’elevato rischio di fallimento, è un tentativo che merita di essere fatto, essendo precondizione per ordinare l’azione razionale nel presente storico. Nelle poche righe che seguono voglio provarmi a tratteggiare in maniera schematica i lineamenti generali del vortice economico depressivo in cui ci troviamo da circa sette anni. Nessuno dei passaggi che ricorderò è particolarmente nuovo né particolarmente controverso, basandosi su dati noti e analisi consolidate (P. Krugman, J. Stiglitz, Th. Piketty ed altri). La mia speranza è che l’unico elemento marginalmente nuovo, ovvero lo sguardo sinottico su questi eventi, possa aiutare il lettore ad orientare il proprio giudizio in questi tempi complicati. Naturalmente nel quadro generalissimo che emergerà verranno trascurate importanti specificità delle singole situazioni, ma questo è un peccato argomentativo in cui incorriamo coscientemente, per cercare di cogliere una struttura essenziale al di sotto delle particolari vicende nazionali.
I passaggi cruciali che riassumono l’andamento della presente crisi possono essere ricondotti ai seguenti sette.
1) L’innesco. In una descrizione storica non c’è mai un inizio assoluto. Le descrizioni correnti della presente crisi partono di norma dal tentativo di uscire dalla crisi precedente (lo scoppio della cosiddetta bolla tecnologica, 2000-2002). Ma in verità se di un ‘inizio’ di questa vicenda si può parlare, questo risiede in un problema presente da decenni nell’economia statunitense così come (in misura variabile) in tutte le economie maggiormente industrializzate: una crescita economica ridotta rispetto agli standard del trentennio 1945-1975. Dagli anni ’70, anche in presenza di crescita economica, i redditi della maggioranza della popolazione sono risultati tendenzialmente stagnanti, mentre risultano contrarsi nelle fasi recessive. Redditi stagnanti o in contrazione dei più (οἱ πολλοί,) significa stagnazione dei consumi, ergo, in presenza di aumenti di produttività, significa eccesso di produzione e disoccupazione. L’innesco della crisi sta dunque nella oramai pluridecennale necessità di ovviare ad una riduzione del potere d’acquisto dei più (negli USA, ma anche in Europa). Per ovviare a questo problema la via maestra sarebbe stata una politica redistributiva (tassazione fortemente progressiva, et similia). Ma per fare ciò sarebbe stata necessaria una forza che le élite politiche, in particolare negli USA (ma non solo), con tutta evidenza non hanno avuto e continuano a non avere. Come si è cercato allora di ovviare a questi problemi di sottoconsumo lasciando intoccati i patrimoni più elevati e la forbice reddituale?
2) La miccia. Per sfuggire al rischio di spirali recessive, senza toccare le distribuzioni patrimoniali, la soluzione adottata è stata di ricercare interventi a costo zero che stimolassero la crescita, ma ciò prefigura una direzione precisa: una riduzione di regole, obblighi, controlli, diritti (deregulation). Infatti, come insegna la teoria, ogni vincolo normativo è qualcosa che toglie al mercato un’area di transazioni possibili. Meno regole, più transazioni. Più transazioni più crescita. Naturalmente non tutte le liberalizzazioni hanno lo stesso significato. Quelle cruciali per intendere la crisi attuale sono state le deregolamentazioni dei mercati finanziari e dei sistemi bancari, avvenuti negli USA e, parzialmente, anche in Europa. Nell’evoluzione recente della deregolamentazione americana spiccano l’obliterazione delle differenze tra banche d’affari e banche commerciali (cancellazione dello Glass-Steagall Act, 1996-1999) e il sostanziale abbandono di un monitoraggio terzo sui rischi contratti dalle banche d’investimento (Voluntary Regulation, 2004). Ma nella stessa classe generale di interventi ritroviamo tutte le mosse rivolte ad un arretramento del ruolo, sia di regolatore che di investitore, dello stato, secondo la norma: ogni cosa in meno fatta dallo stato crea uno spazio in più per il mercato privato.
3) L’esplosivo. Tra gli effetti della deregulation ricordiamo in primo luogo la possibilità degli istituti di credito di fondersi fino a raggiungere dimensioni patrimonialmente colossali. In secondo luogo, lasciata con le mani libere, la finanza (americana, ma parlare di nazionalità in ambito finanziario è fuorviante) ha messo al lavoro i propri migliori ingegni per produrre svariate innovazioni finanziarie. Ne ricordiamo solo le tre più rilevanti per la presente crisi. Il primo elemento inventivo, al cui nome è associata la crisi stessa, è stata la concessione di mutui subprime, cioè di mutui per acquisto casa a tassi variabili anche a persone con redditi scarsi e/o instabili. Questa mossa ha aumentato d’un tratto i potenziali acquirenti di casa, nonostante la stagnazione dei redditi: i meno abbienti sono stati dichiarati d’ufficio sufficientemente benestanti, senza l’onere di mettergli davvero più denaro in tasca. La crescita della domanda nel settore immobiliare ha naturalmente prodotto un aumento dei valori degli immobili stessi (bolla immobiliare: + 42% tra il 1999 e il 2006). Subentra qui una seconda innovazione degna di nota: ai mutuatari americani è stata concessa la possibilità di ottenere prestiti mettendo a garanzia la casa stessa (in via di pagamento), contando sul fatto che il valore degli immobili stava aumentando (se la tua casa comprata per 100 ora ne vale 110, perché non capitalizzare subito quei 10?). Ciò ha permesso di aumentare ancora le disponibilità reddituali, senza aumenti salariali. Il vero colpo di genio sta però nel terzo passo. Di norma nessuna banca adotterebbe una politica così azzardata, se dovesse accollarsi in pieno il rischio delle insolvenze dei mutuatari. Come evitare il problema? La risposta è stata la ‘cartolarizzazione’ dei mutui: gli stessi contratti di mutuo sono stati trasformati in bond (Asset Backed Securities), e poi aggregati ed impacchettati in altre obbligazioni (Collateralized Debt Obligations), che sono stati a loro volta re-impacchettati in titoli ‘protettivi’ (Credit Default Swaps), ecc. Questo processo ha sostanzialmente consentito alle banche che avevano contratto mutui fragili di infilarli come rendite all’interno di altre rendite (es. fondi pensione), disperdendoli nel mercato in forma non identificabile e, apparentemente, diluendo i propri rischi.
4) Lo scoppio. Come nella migliore tradizione delle bolle finanziarie ad un certo punto (alla fine del 2006) la bolla immobiliare scoppia. Il meccanismo delle bolle speculative è ben noto: il valore di partenza di un bene dovrebbe essere legato alla prospettiva di quanto profitto esso possa produrre. Sul mercato finanziario tale valutazione di merito viene soppiantata da una valutazione svincolata dal bene reale: gli operatori finanziari non si interessano più dei ‘fondamentali’ di aziende quotate o simili ma solo delle aspettative altrui rispetto al valore del titolo che le rappresenta. Se ci sono in giro altri compratori disponibili a comprare quell’asset ad un prezzo superiore a quello di acquisto ci sono ragioni per l’operatore di continuare a comprarlo (per rivenderlo). Finché questa credenza nella disponibilità altrui a comprare per un prezzo superiore persiste, il prezzo dell’asset può aumentare infinitamente. Come sempre, ad un certo punto capita che qualcuno dica che il re è nudo, e le aspettative cambiano verso: tutti quelli che hanno in mano quegli asset sopravvalutati cercano di venderli il più in fretta possibile, sapendo che inizieranno a perdere di valore. E ciò ne produce un’ulteriore progressiva perdita di valore, in una spirale questa volta depressiva.
5) Il domino. Ed ora le tessere del domino cominciano a cadere, una dopo l’altra. Il crollo del mercato finanziario (immobiliare) produce perdite crescenti ed imprevedibili per gli istituti di credito, che reagiscono contraendo l’erogazione dei prestiti, temendo di rimanere a corto di liquidità. Ciò aumenta i tassi di interesse interbancario, cui sono agganciati i mutui variabili, che accentua ancora l’insolvibilità dei mutui più fragili. Inoltre la contrazione della liquidità bancaria si scarica sulle aziende (soprattutto medio-piccole), e queste a loro volta si scaricano sul mercato del lavoro, in forma di licenziamenti. Naturalmente, essendo il sistema finanziario costitutivamente transnazionale gli effetti della crisi finanziaria si diffondono internazionalmente. L’economia virtuale spezza la schiena a quella reale.
6) Il cavaliere dalla triste figura. A questo punto, quando il crollo dei mercati finanziari mina il mercato del lavoro, e fallimenti bancari a catena si profilano all’orizzonte, compare sulla scena di quest’avventura la figura tragica dello stato nazionale. Per porre un freno a questi fronti di crisi gli stati nazionali sono costretti ad intervenire con denaro pubblico. Ciò accade soprattutto in due forme: con ammortizzatori sociali per la disoccupazione (es.: cassa integrazione straordinaria) e come sostegno finanziario agli istituti di credito troppo grandi per poter fallire senza portare con sé il sistema creditizio (compresi i risparmi dei piccoli risparmiatori). Lo stato, dai cui lacci e lacciuoli i mercati volevano emanciparsi, diviene per un breve momento il valente e malinconico cavaliere chiamato in soccorso di quei mercati stessi. L’esito del nobile gesto è naturalmente un trasferimento netto dal settore pubblico al settore privato.
7) Il giro di vite. Si giunge così al colpo di teatro finale. Donde la malinconia del nostro valente cavaliere? È presto detto: gli interventi degli stati nazionali ne aumentano il debito pubblico. Ne segue che gli stati sono messi sotto pressione da aumenti dei tassi di interesse sul debito (spread) e, talora, da rischi di default. A questo punto gli stati indebitati sembrano avere una sola opzione bifronte, e cioè ridurre peso e perimetro dello stato, in due modi: 1) riducendo gli impegni di spesa statale e 2) riducendo la regolamentazione dei mercati.
7.1) La riduzione delle spese statali (con privatizzazioni e/o riduzione dei servizi pubblici) ha, apparentemente, un doppio effetto benefico. Da un lato, lo stato debitore appare virtuoso ai mercati, lestamente trasformatisi in giudici: piace qui ai mercati evocare la mitica figura del buon padre di famiglia che stringe la cinghia quando scopre di ‘star vivendo al di sopra dei propri mezzi’. Dall’altro lato il disimpegno statale lascia aperta alla fornitura di servizi privati campi prima occupati dal pubblico.
7.2) La riduzione della regolamentazione, infine, togliendo controlli, ‘lacci e lacciuoli’ consente di creare nuovi spazi di transazione, prima impossibili.
Ma questo naturalmente ci riporta, come in un deprimente gioco dell’oca, all’inizio della presente sequenza, dove viene esercitata una pressione al ribasso su salari e regolamentazioni, onde permettere ai mercati di ripartire per nuove intrepide avventure.
Questo meccanismo preterintenzionale ha senza dubbio una sua singolare efficienza, e quasi un’inquietante bellezza. Come in un complesso sofisma, ogni singolo passo per uscire dal labirinto sembra ragionevole, fino a che non ci si ritrova al punto di partenza. Solo più poveri e disorientati. E qui un’analogia importuna mi si impone: questo processo mi ricorda una macchina di tortura vista una volta in un museo dedicato. Si trattava di una garrota spagnola, con un laccio di cuoio deputato a strangolare il condannato, con sul retro una specie di grossa vite da girare a due mani: ad ogni giro di vite il laccio si stringeva, ma mollando la presa della vite il laccio non si allentava, perché c’era un dente d’arresto ad impedirlo. L’immagine, lo ammetto, è un po’ cruenta, ma provo a spiegarmi.
Questo processo ha alcune caratteristiche peculiari, che, in conclusione, possiamo provare a riassumere nelle seguenti tre dinamiche.
- A) In primo luogo il processo si dispiega in maniera costitutivamente asimmetrica. Se, per dire, l’economia cresce, i valori di mercato crescono, e la Borsa gioiosamente costruisce la prossima bolla, questa di norma rappresenta una notizia neutrale per i redditi da lavoro, che crescono molto di meno o per nulla. Ciò avviene per vari motivi, ma principalmente perché chi ha maggior potere contrattuale (detiene maggiore capitale) è nelle condizioni di appropriarsi di una fetta più che proporzionale del prodotto sociale. Quando la Borsa è euforica, questa è una notizia univocamente buona solo per i detentori di capitale (e tanto di più, quanto più capitale detengono). Diversamente vanno le cose quando subentra una fase di contrazione e depressione. Un crollo della Borsa è funesta novella per tutti, scaricandosi rapidamente, ed in maniera massiccia, sulla sfera dei redditi da lavoro.
- B) In secondo luogo all’occorrere di ciascuna crisi la capacità di regolamentazione ed intervento pubblico è spinta a ridursi, e simultaneamente la patrimonializzazione pubblica tende a ridursi a beneficio di quella privata. Gli stati non possono non intervenire quando la crisi si verifica, perché i problemi dei mercati divengono rapidamente problemi sociali generali. Ma al tempo stesso ogni intervento mette gli stati in sempre maggior misura alla mercé dei mercati. Accade così, come mostrato recentemente da Piketty, che, mentre tutti gli stati nazionali del mondo sono, chi più chi meno, indebitati, le patrimonializzazioni private negli ultimi trent’anni risultano in continua crescita rispetto a quelle pubbliche (oramai nell’ordine del 6-700% in USA ed Europa).
- C) In terzo ed ultimo luogo troviamo una dinamica più sottile, ma non meno incisiva. La riduzione progressiva dell’intervento pubblico aumenta l’insicurezza del cittadino medio, riducendone le garanzie pubbliche su vecchiaia, salute, calamità naturali, sicurezza del posto di lavoro, ecc. Ciò spinge chi è in grado di farlo a difendersi, acquistando sul mercato privato pensioni integrative, assicurazioni, accantonamenti sperabilmente fruttiferi, ecc. E ciò ha un rimarchevole duplice effetto. Economicamente, questo movimento sottrae denaro al consumo trasferendolo nella rendita, e ciò accentua le crisi della domanda ed i rischi recessivi. Politicamente, ciò spinge sempre più i cittadini ad essere solidali con gli interessi del ‘capitale’, a scapito di altri interessi collettivi. Perché? Ma perché il lavoratore che sia divenuto anche piccolo risparmiatore teme, giustamente, di veder messi a repentaglio i piccoli margini di sicurezza che tenta faticosamente di procurarsi. E così il cerchio si chiude una volta di più: chi lotta quotidianamente campando del proprio lavoro viene indotto a guardare con ostilità ogni attacco al capitale (tassazione delle rendite finanziarie, degli immobili, ecc.), facendosi democratico sodale di quell’1% che detiene i veri capitali.
Per dar conto di questo meccanismo non c’è qui alcuna necessità di appellarsi a congiure, complotti o piani preordinati. Talora nella storia sociale, come in quella naturale, nascono ordinamenti spontanei che generano equilibri armonici. E talaltra generano processi mirabilmente autodistruttivi. Quel che però è certo è che, salvo colpi di reni dell’umano ingegno, gli interessi della rendita hanno vinto gioco, set e partita (economicamente, politicamente e, socialmente). Il cerchio si chiude, la vite si stringe, il senso di soffocamento cresce.
7) JOHN LUDD IS BACK
Recentemente è ritornato di moda parlare dei problemi generati dalla sostituzione del lavoro umano con quello delle macchine. Sembra sempre si tratti di un’inaudita straordinaria novità, anche se si tratta precisamente del medesimo problema che portò il tessitore inglese John Ludd a distruggere un telaio nel 1779.
Il problema, nei suoi tratti di fondo, ha una struttura piuttosto elementare.
Se aumento la produttività (con l’utilizzo di macchine, ma anche altrimenti, migliorando l’organizzazione del lavoro, ecc.) aumento il prodotto per ciascun lavoratore impiegato, dunque la ricchezza che ciascun lavoratore ha prodotto.
L’aumento di produzione, se venduto, significa aumento di ricchezza e questo aumento di ricchezza può prendere, schematicamente, tre strade diverse.
1) Può essere riversato nelle tasche del lavoratore,
2) può essere reinvestito nella produzione, o
3) può finire nelle tasche del proprietario dei mezzi di produzione.
Nel caso 1) abbiamo un aumento del reddito del lavoratore, che tende a spenderlo, ad esempio in beni e servizi accessori. In tal caso (fino al limite di un lavoratore che fosse così ben pagato da cominciare a reinvestire in proprio) si può avere un equilibrato aumento di benessere sociale. Magari meno persone lavoreranno in fabbrica, ma più persone potranno lavorare altrove, nella produzione di beni e servizi accessori, acquistabili con le maggiori risorse disponibili a chi lavora in fabbrica. – In alternativa si possono far lavorare le stesse persone a salario invariato, ma per meno ore.
Nel caso 2), se si reinveste nella produzione, ciò incrementa ancora la produzione complessiva e/o la produttività per unità lavorativa, ma ciò ci rimanda semplicemente al problema di partenza.
Nel caso 3), abbiamo un aumento del reddito del proprietario dei mezzi di produzione. Ma qui sorge un problema: volendo assicurarsi la stabilità a lungo termine del proprio alto tenore di vita, il proprietario accantonerà una parte molto significativa di tale reddito in forma di risparmio/investimento. Ora, per quanto la teoria economica dica che ‘nel lungo periodo’ tutto ciò che viene accantonato come risparmio finirà tendenzialmente per ritornare nella società in forma di investimento (attinto da altri per i loro scopi), questo di fatto non accade. Quanto maggiore il reddito, e quanto maggiore il ‘desiderio di sicurezza’, tanto più il capitale si troverà immobilizzato per lunghi periodi (es.: in acquisizioni immobiliari) o accantonato in forme improduttive (con interessi negativi o nulli). Questo capitale, non ritornando in circolo (esso ha infatti la comprensibile funzione di ‘cuscino di sicurezza’ per il capitalista) genera perciò una carenza di domanda.
Questo e solo questo è il caso davvero problematico. Qui i posti di lavoro ridotti con l’automazione (più in generale con ogni aumento di produttività) non vengono più compensati da posti di lavoro in altri settori, giacché la domanda aggregata diminuisce e non c’è bisogno di rispondere ad una diversa domanda di beni o servizi. Risultato: aumento della disoccupazione, riduzione della crescita potenziale, impoverimento medio della popolazione lavoratrice.
La soluzione sul piano teorico è semplice: non rompere le macchine come John Ludd, né tassarle come propone Bill Gates (perché ciò si limita a ridurne l’impiego, ma non tocca il vero problema, che è generato da qualsiasi aumento di produttività). L’unica soluzione ragionevole sta nel far rientrare forzosamente quel denaro in circolo, il che si può ottenere aumentando il salario per ora lavorata dei lavoratori impiegati e/o tassando e poi redistribuendo gli introiti dei detentori dei mezzi di produzione (individui o corporations che siano).
La soluzione teorica non presenta dunque difficoltà.
L’implementazione politica richiede invece risorse umane e organizzative considerevoli. Ma magari già sapere dove sta il problema e cosa si vuole fare, può essere un inizio.
8) BREXIT
Tutto ciò che è necessario sapere sull’Europa Unita a poche ore dall’esito sulla Brexit
Sul Corriere di oggi c’è un bell’articolo in cui si fa una comparazione tra le condizioni di vita e scolastiche di due quartieri di Londra, uno ricco ed uno povero. Naturalmente quello ricco è europeista e quello povero è per la Brexit.
Ora, possiamo smenarcela all’infinito con sottili analisi sugli andamenti commerciali, i costi di transazione, le variabili di cambio, ma quello che bisogna essenzialmente capire sull’UE a mio immodesto avviso è solo quanto segue.
Per le classi economicamente perdenti, in presenza di politiche neoliberali, essere dentro o fuori dall’Europa è proprio la stessa fogna. E, per dirla con le parole del poeta, se fogna deve essere, che sia almeno quella di casa mia. Questo vale per gli slum britannici come per le vele di Scampia, per le banlieue parigine, per lo Josefstaedter Guertel di Vienna, ecc. ecc.
Chi ci perde davvero ad uscire dall’Unione Europea, sotto politiche liberiste, sono solo quei settori che si giovano direttamente del commercio internazionale su grande scala. Tagliato un po’ con l’accetta: finanza e multinazionali.
La vera differenza l’Europa unita la può (o meglio potrebbe) fare solo in presenza di politiche diffuse di welfare. Questo perché le possibilità di difesa dall’imposizione di condizioni svantaggiose nel nome del massimo profitto aumentano quanto maggiore è la massa economico-politica di un’istituzione.
Un’Unione Europea con una massa di mezzo miliardo di consumatori e più di un quarto del PIL mondiale potrebbe difendere i diritti dei propri lavoratori, potrebbe difendere la qualità delle proprie merci, potrebbe difendere il proprio ambiente, potrebbe difendere la formazione diffusa e il diritto allo studio, potrebbe alimentare il finanziamento della ricerca pubblica, potrebbe difendere il diritto a trattamenti sanitari gratuiti ed efficienti per tutti. Potrebbe.
Ma se non lo fa, se l’Europa è solo quella della direttiva Bolkenstein e degli ultimatum di Schäuble, beh, allora ne possono fare a meno gli inglesi, come i greci, gli spagnoli, gli italiani e, in verità tutti quanti.
In sunto.
Il progetto dell’Europa Unita NON è indifferente al variare delle politiche: non è in grado di essere un progetto politicamente neutrale. Al contrario, esso può esistere soltanto in presenza di politiche attive di tipo keynesiano, socialista, fors’anche di cristianesimo sociale, ma non liberista.
L’Europa come progetto neoliberale è solo un incubo di breve respiro e tragico esito.
9) IL SIGNIFICATO DELLA BREXIT PER L’EUROPA (da “Il Piccolo”)
Per comprendere il senso della Brexit per l’Europa bisogna partire da due osservazioni, una di attualità e l’altra storica.
La prima è che la concentrazione degli antieuropeisti al referendum è risultata massima nelle aree del paese più povere e meno assistite. Ad esempio, a Londra a fronte del quartiere ricco di Chelsea contrario alla Brexit, troviamo il quartiere povero di Newham, massicciamente favorevole.
La seconda osservazione richiede una digressione sulle origini storiche del progetto europeo. Quel progetto nacque per evitare il riverificarsi delle condizioni che avevano condotto alle due guerre mondiali. Negli anni che avevano preceduto la Prima Guerra mondiale la concorrenza economica tra i maggiori stati europei aveva creato una morsa fatale. Da un lato la crescente competizione sui mercati internazionali aveva condotto, dal 1880 in poi, ad un peggioramento delle condizioni dei lavoratori europei, innescando fenomeni di sciovinismo, nazionalismo, xenofobia. Dall’altro, la ricerca frenetica di nuovi mercati e nuove aree di sfruttamento (colonialismo ed imperialismo) aveva portato a crescenti scontri tra le potenze, fino allo scoppio manifesto del 1914.
Rispetto a questo quadro, il progetto europeo, promosso da scritti come il Manifesto di Ventotene, aveva di mira la creazione di uno spazio di libero scambio, ma moderato e armonizzato da organismi democratici. L’Europa unita poteva rimanere un’area di libertà economica (fuori dall’influenza sovietica), ma capace di evitare la competizione internazionale sregolata e i suoi tristi esiti. L’Europa unita era (e potenzialmente ancora è) nelle condizioni per affrontare i mercati internazionali senza vedersi imporre condizioni di scambio punitive (massimo ribasso di salari e diritti). L’Europa era la promessa di difendere le condizioni di vita dei propri lavoratori, lo stato sociale, il diritto allo studio, la ricerca pubblica, ecc.
Ma a partire dagli anni ’90 del ‘900 questo progetto, ispirato da istanze socialiste, socialdemocratiche e cristiano-sociali, è caduto vittima di nuove maggioranze politiche, maggioranze dove la lezione liberista del thatcherismo e della Reaganomics era divenuta ortodossia. Queste maggioranze nel Parlamento europeo fecero sì che l’Europa si identificasse in sempre maggior misura con gli interessi di banche e multinazionali, le liberalizzazioni (direttiva Bolkenstein), e l’austerità fiscale.
Ora, cosa ci insegna il traumatico evento della Brexit? Ci insegna una cosa tanto semplice da intendere, quanto complessa da risolvere. Per le classi meno privilegiate, un’Europa che alimenti politiche essenzialmente liberiste non presenta nessuna attrattiva. Essa ha tutti i difetti dei grandi organismi burocratici, ma non i pregi di uno stato forte nel moderare i processi di mercato. Per chi abita Newham o le banlieue parigine, le Vele di Scampia o le periferie di Dresda, la partecipazione a questa forma del progetto europeo non significa nulla: difficilmente la loro condizione può subire peggioramenti da una rinuncia all’Europa, al contrario l’Exit sembra promettere istituzioni più vicine cui rivolgere le proteste. Se il valore dominante che l’UE sembra ansiosa di trasmettere è solo l’essere flessibili, dinamici e pronti alla ‘sfida dei mercati’, è facile che si giunga alla conclusione che si lotta meglio con un bagaglio più leggero e che le istituzioni europee siano appunto solo un tale bagaglio. Ciò significa che il progetto europeo non può permettersi di essere un progetto politicamente neutrale. Non lo è nelle sue radici storiche e non può esserlo nella sua realtà odierna. Il progetto europeo è compatibile con politiche di sinistra, di cristianesimo sociale, persino con politiche di destra sociale (se non nazionalista e xenofoba), ma collassa sotto il peso di politiche liberiste. Un’Europa vissuta come mero lubrificante del liberoscambismo è un progetto fallimentare, destinato ad una fine ingloriosa.
10) TTIP (TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP).
http://www.corriere.it/opinioni/16_maggio_07/paura-che-frena-patto-commerciale-europa-usa-a387a8de-13b1-11e6-acb9-4814fe47e238.shtml
Daniele Manca, uno degli agit prop del liberismo che il Corriere brandisce come clave, si esibisce oggi in un articolo che è un piccolo capolavoro di malafede, con condimento ideologico.
Ci spiega come per partecipare alla concorrenza globale ed ottenerne i benefici non si può non approvare il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
E rimbrotta gli europei per l’inspiegabile atteggiamento pauroso e sospettoso.
Di passaggio, naturalmente, scorda di nominare:
1) Che per anni, fino a quando non è stato portato alla luce da Wikileaks, il trattato in preparazione è stato condotto con assoluto vincolo di segretezza e con la clausola di non essere sottoposto per 5 anni dall’entrata in vigore a valutazione popolare;
2) Che è ancora oggetto di discussione la proposta americana di rendere le decisioni politiche dei parlamenti nazionali impugnabili dalle multinazionali davanti ad un collegio arbitrale semiprivato, nel caso in cui rappresentino un danno economico per le multinazionali medesime;
3) Che in tutti i casi venuti alla luce grazie a Wikileaks, su cibo, cosmetici, telecomunicazioni, e pesticidi le richieste americane sono sempre state di un abbassamento delle garanzie e tutele per il consumatore (soglie di tolleranza per i pesticidi, ecc.)
Tra le cose che invece il giornalista nomina sì, ma come se fosse una sciocchezzuola (lavare il pollo con il cloro), è la richiesta americana dell’abbandono del principio di precauzione. Ovvero, invece di dover dimostrare che un prodotto non è dannoso prima di metterlo in commercio, lo si mette in commercio senz’altro, e se poi, prima o dopo, si dovesse dimostrare che è dannoso si può sempre mettere in piedi una bella causa postuma American Style.
Mi piacciono questi articoli, perché, nel marasma generale, fanno chiarezza su dove stanno i cattivi.
11) ALLONSANFÀN (DICEMBRE 2015)
Ecco, ora mi par già di sentire, soprattutto a sinistra, i commenti alle elezioni regionali francesi:
“Naturale, il FN sfrutta populisticamente le insicurezze dei francesi e vince brandendo l’odio verso il diverso”.
Segue mesta rassegnazione di fronte alla stupidità del popolo.
Populismo, già. E odio. E la stupidità del popolo, come negarlo.
Solo che qui buona metà del campo visivo risulta, curiosamente, inaccessibile.
Infatti, in questo quadro manca che accanto all’immancabile ‘libertà’, Madame Le Pen rivendica parole d’ordine come ‘eguaglianza’, ‘fraternità’ e persino ‘laicità’ (sic).
E manca, in questo quadro, la principale linea di contrapposizione proposta dalla Le Pen (come da altri, giustamente vituperati, personaggi di destra come Viktor Orban): l’unità del popolo vista come in epocale contrasto con gli oligarchi difensori del libero mercato a oltranza, dell’Europa della finanza, della globalizzazione inclusa l’immigrazione, delle banche e delle multinazionali. Ed infatti, non a caso, il FN ha il 20% nel centro di Parigi, ma ha il 50% nelle ex regioni rosse del nord della Francia.
Ora, che questi temi vengano branditi in modo populistico è certo, e quanto Marine Le Pen sia in grado di implementarli se dovesse andare al potere è alquanto dubbio.
Solo che è già un bel po’ che la principale occupazione e preoccupazione dei rappresentanti del PSE in Europa è quella di tacciare di populismo tutto ciò che fa (o sembra fare) gli interessi del popolo. Che il popolo sia stupido ed ignorante (così tenuto, peraltro, con la gentile collaborazione di chi governa) è altamente probabile. Ma una volta ai comunisti insegnavano che se il popolo esprime dei bisogni e delle istanze, qualcosa di vero c’è sempre, e che il compito di una ‘grande forza popolare’ è comprendere e razionalizzare queste istanze (come, incidentalmente, in parte fa papa Francesco), non rimuoverle spiegandogli che non capiscono.
Certo che i partiti di destra in Europa sfruttano il senso di insicurezza: insicurezza economica, sociale, culturale, identitaria, fisica. Ma non si può dire che tale sfruttamento sia un compito difficile, visto che dall’altra parte troviamo quasi solo forze che, implicitamente o meno, tessono le lodi dell’insicurezza (della libera concorrenza, della riduzione delle tutele, delle eccitanti sfide della globalizzazione, del multiculturalismo senza cultura, delle strategie Winner-Take-All, ecc.).
Nel momento in cui nel Parlamento Europeo PSE e PPE fanno a gara a chi tutela nel modo più convinto gli interessi dell’alta borghesia, è intuibile che, per quanto stupido ed ignorante, il popolo prima o poi, confusamente, se ne accorga.
E allora succedono due cose: la prima è che il suddetto popolo non va a votare perché gli fai schifo.
La seconda è che se proprio deve andare a votare, vota per qualcuno che almeno finge energicamente di occuparsi dei suoi problemi.
E il diritto di stigmatizzare il populismo ce l’ha solo chi prova a venire incontro sul serio al popolo. Altrimenti lanciare lo stigma del populismo è solo una difesa verbale: esangue, comoda, e perdente.
12) C’ERA UNA VOLTA LA GERMANIA
C’era una volta la Germania, il paese dove le regole si rispettavano inderogabilmente, dove la tradizione protestante dell’introiezione della colpa si era radicata in profondità, e dove un diffuso controllo sociale giudicava anche le minori infrazioni con fiero cipiglio.
Già, ma Lutero ha dovuto fare i conti, nel tempo, con Milton Friedman (quello che: “l’unica responsabilità morale di un’azienda è far guadagnare i propri azionisti”). Il processo di modernizzazione (ed incanaglimento) è stato naturalmente graduale. Ma un decisivo salto in avanti è stato fatto certamente nel periodo dell’unificazione con la Germania Est, uno dei processi politici più scandalosi e meno discussi della recente storia europea.
In quel periodo il compito di privatizzare l’intero sistema industriale dell’ex Germania Est fu assegnato a un istituto di amministrazione fiduciaria pubblico, la Treuhandanstalt. Le privatizzazioni si svolsero a trattativa privata, senza aste, e supportate da grandi incentivi statali, portando ad un diluvio di truffe e malversazioni, dalla cui persegubilità i funzionari pubblici vennero peraltro esentati con decreto federale. Si ebbe così la più colossale svendita di asset della storia, in cui la vendita di un apparato industriale stimato intorno ai 600 miliardi di marchi produsse alla fine un buco di 250 miliardi (con un ricavo complessivo dalla privatizzazione, al netto degli incentivi, di 73 miliardi).
Da allora i casi i casi di corruzione si sono ampliati e diffusi, e allo stato la Germania ha la più grande economia in nero d’Europa (351 miliardi di euro, proporzionale al Pil, ma comunque un po’ sopra la media). Sono emersi episodi come il coinvolgimento del presidente della Confindustria tedesca, Ulrich Grillo in una serie di pagamenti di tangenti in Grecia quando era a capo delle società Rheinmetall e Stn Atlas. Nel 2007 la Siemens fu multata per 600 milioni di euro per essere stata scoperta a pagare sistematicamente mazzette world-wide per ottenere (con fondi neri) appalti pubblici. Nel 2009 la Man dovette pagare 150 milioni per aver pagato tangenti per vincere contratti, in Germania e all’estero, ecc. ecc.
Il caso di ieri della truffa (ingegnosa, bisogna dargliene atto) della Volkswagen è solo l’ultimo episodio di una seria già degna di menzione anche per gli esigenti standard italiani.
Ecco, ora tutto questo potrebbe anche essere lasciato cadere. Dopo tutto la Germania ha tante virtù, incontestabili, e dopo tutto l’Italia ha tanti difetti, incontestabili anche quelli. Dunque si potrebbe registrare l’evento senza calcare la mano.
C’è però un dettaglio fastidioso.
La cultura tedesca, mirabile ed ammirata, presenta purtroppo, non da oggi, un piccolo problema di atteggiamento. Un problema che spesso può risultare del tutto trascurabile a fronte degli altri pregi, ma che occasionalmente nella storia ha invece trasformato i pregi tedeschi in difetti (talora difetti terrificanti). Non trovo un termine preciso in italiano, ma in inglese il termine giusto è ‘self-righteousness’, traducibile con la perifrasi: “La certezza, condita da senso di superiorità, di essere nel giusto”.
Ecco, se la Germania non avesse in tempi recenti (ed invero anche un paio di volte nella prima metà del XX secolo) così manifestamente frantumato gli zebedei a tutti quelli che gli stavano attorno, spiegando come loro fossero nel giusto, migliori, ligi alle regole, dotati di pedigree e accompagnati da Dio, si potrebbe serenamente lasciar correre la ghiotta occasione rappresentata dal caso VW. E se non avessero pure tratto la conclusione, sulla base delle sunnominate virtù, di essere perciò autorizzati a bacchettare il resto del mondo e a cercare di subentrare alle sovranità altrui (talvolta con i Tank, talaltra con i Bond), anche in questo caso un sobrio commento di basso profilo sarebbe stato opportuno.
Solo che proprio questo hanno fatto. E, per il bene degli stessi amici tedeschi, ogni tanto ricordargli che devono scendere dal piedistallo, e darsi una robusta sgonfiata, è un’opera di salute pubblica.
13) AUSTERITY
1) Nel 2008 la bolla subprime USA mette a rischio il sistema della finanza mondiale
2) Di conseguenza, si contrae la liquidità delle aziende, che riducono la loro attività, aumenta la disoccupazione, si entra in recessione e ciò rende vulnerabili i debiti pubblici (più rischiosi, aumenta lo spread)
3) Ricettona europea: si contraggono le spese statali e si riducono i servizi ai cittadini per tenere sotto controllo il debito (austerity)
4) L’austerity abbatte i consumi interni e per compensare in qualche modo la loro riduzione bisogna puntare sulle esportazioni, soprattutto verso i grandi paesi emergenti (BRIC)
5) Per favorire le esportazioni si comprimono i diritti del lavoro, in modo da ridurre i costi di produzione
6) Dopo sette anni di stenti, e dopo che sia Brasile che Russia hanno ridotto drasticamente la loro crescita, il pallido abbozzo di ripresa europea trainata dall’export minaccia di essere soffocato nella culla dal crollo di un’altra bolla immobiliare, questa volta in Cina.
Ed ora la domandona del giorno.
Come faranno le classi dirigenti europee (Germania in testa) a non ammettere di aver sostenuto una strategia economica imbecille ed autolesionista?
Dichiareranno guerra alla Cina? Punteranno sull’export di lusso in Quatar?
O magari si affideranno una volta di più alle mirabili facoltà oblianti dei media?
Direi che squadra che vince non si cambia. Dunque li vedremo di nuovo in TV a dire ai lavoratori europei che i tempi delle vacche grasse sono finiti, che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e che bisogna darci dentro con nuove ‘riforme’ per migliorare la ‘competitività’.
Ecco.
Ora, per quanto la capacità dei popoli di essere presi per il culo non finirà mai di stupirmi, credo che questa volta mi metterò per tempo nel business della vendita di picche e forconi.
Lo prevedo in vertiginosa crescita.