Nella riflessione ‘progressista’, in senso ampio, esistono due disposizioni teoriche di fondo, spesso confuse tra di loro, nei confronti dell’’altro’ (del diverso, dello straniero, ecc.). Possiamo nominarle schematicamente come le istanze della “giustificazione del diverso” e della “comprensione dell’altro”, rispettivamente.
L’istanza della “giustificazione del diverso” deriva dalla tradizione liberale della “tolleranza”, nata come reazione alle guerre di religione del XVII secolo. Nella seconda metà del ‘900, l’idea di tolleranza liberale si converte in una generale accettazione e giustificazione del ‘diverso’ in quanto diverso, si tratti di diversità religiosa, politica, etnica, valoriale, ecc. La ‘diversità’ viene proposta come via d’accesso al nuovo, viatico del progresso, in opposizione astratta all’identità, connotata come conservazione e ottusità. Nella tradizione storica della tolleranza il diverso da sé va accolto per così dire a scatola chiusa, senza chiedere ragioni, senza cercare mediazioni o assimilazioni. Ciò deriva dalla sua originaria applicazione alla sfera, scarsamente razionalizzabile, delle divergenze di fede. Quell’ispirazione si trasforma così in una generale idea di giustificazione del diverso in quanto diverso nella sua diversità. Questa disposizione, dove la tradizione liberale si allea al relativismo culturale, assume che le ragioni dell’altro siano per default non meno buone e legittime delle nostre. Questo atteggiamento si è incarnato in forme che sono state etichettate – dai loro critici – come ‘lassismo’, ‘giustificazionismo’, ‘buonismo’.
Naturalmente un’istanza di generica apertura e giustificazione del diverso non può applicarsi indefinitamente. Perciò, quando una certa ‘diversità’ si profila come inaccettabile (magari per ragioni mediatiche, contingenti) all’irenica agiografia del diverso subentra il rigetto più virulento e dogmatico. La cultura della tolleranza genera ciclicamente crisi di intolleranza. Così, negli stessi paesi alfieri dell’elogio del diverso e della tolleranza liberale troviamo ricorrenti reazioni di rigetto assoluto, che si tratti del consumo di alcool nel proibizionismo, del nazifascismo come archetipo del male assoluto, della caccia alle streghe nell’anticomunismo maccartista, del tabagismo, dell’islamismo dopo l’11 settembre, ecc. Ciò che accomuna la giustificazione del diverso in quanto diverso, e la sua repulsione quando ‘troppo diverso’, è l’assenza in entrambi i casi di una mediazione razionale, di un tentativo di comprendere e discernere ciò che l’altro è, o rappresenta.
Spesso, in continuità con la tradizione liberale della tolleranza, si cita la tradizione antica dell’ospitalità, a partire dalle norme greco-romane che obbligavano all’ospitalità verso lo straniero. Tuttavia l’analogia tra il concetto moderno di tolleranza e la tradizione antica dell’ospitalità è solo esteriore. Le norme sull’ospitalità erano piuttosto un tentativo di ‘comprensione dell’altro’. L’altro, l’estraneo, il diverso, presenta da sempre un lato di fascino accanto ad uno di minaccia: è un potenziale arricchimento – di conoscenze, tecniche, prospettive, sangue, alleanze -, ma anche un potenziale pericolo. Le leggi dell’ospitalità governavano il rapporto tra l’esterno e l’interno del gruppo nei confronti di singoli viandanti, occasionalmente famiglie. Ma come ricorda la comune etimologia latina di hospes (ospite) e hostis (nemico), l’allerta rispetto alla possibilità di aggressioni, invasioni, ecc. era sempre presente, specialmente di fronte non a viaggiatori isolati, ma a gruppi. Nel rapporto di ospitalità antico non c’è niente di simile all’accettazione neutrale dell’altro nella sua alterità: si trattava di un rapporto vincolante, potenzialmente di lungo periodo, che chiedeva gesti forti di compartecipazione e scambio. L’estraneo doveva essere compreso, nel duplice senso di inteso e incluso. Questa tradizione antica è coerente con il modo di concepire il rapporto con l’altro che sarà della tradizione hegelo-marxiana, dove l’alterità deve pervenire ad una sintesi, ad un’integrazione.
I due modelli hanno un senso profondamente divergente. La disposizione a “comprendere l’altro” è disposizione ad ascoltarne le ragioni, a vagliarne i motivi, anche ad essere disposti ad assimilarne dei tratti, ma non significa affatto che di per sé le ragioni e i motivi altrui abbiano pari dignità, pari valore. Nella spinta alla comprensione dell’altro è presente l’aspirazione a creare un’identità più ricca, che non lascia l’altro nel suo irredimibile stato di estraneità. Al contrario, la tendenza alla giustificazione del diverso assume la diversità in quanto tale come valore, senza porsi il problema di una sua riconciliazione o ricomposizione all’interno di una società, una comunità, una tradizione. È perciò che tale istanza produce poi crisi di cesura e rigetto radicali: non fornendo lo spazio per integrazione, assimilazione, mediazione, il ‘diverso’ può essere soltanto o tollerato o rigettato (spesso le due cose insieme, come nella creazione di enclave straniere impermeabili nelle periferie di molti centri urbani europei).
La comprensione dell’altro non si arresta di fronte alla sua condanna, alla sua percepita inaccettabilità: anche le ragioni del nemico, anche le ragioni di chi giudichiamo malvagio o in errore sono ragioni, e come tali possono essere comprese. Ma comprendere non significa giustificare, tantomeno accettare. Possiamo avere ottime ragioni per condannare il nazifascismo, il socialismo reale, il radicalismo islamico, o quant’altro, e al tempo stesso disporci a comprenderne le motivazioni e ragioni profonde. Infatti, se certe ragioni hanno motivato una volta un gruppo sociale, allora sono e restano ragioni umanamente intelligibili, di principio accessibili a chiunque, eventualmente capaci di riproporsi nella storia. Rispetto a questo atteggiamento il lato intollerante della tolleranza accusa l’atteggiamento comprensivo di collusione con il nemico, di ambiguità. Lo ‘spirito della tolleranza’ tende così a creare una rigidità moraleggiante, un convenzionalismo benpensante, con classificazioni pregiudiziali di bene e male. Paradossalmente, l’atteggiamento di tolleranza-giustificazione finisce per dare credito a priori all’estraneo remoto, rendendosi al contempo impermeabile alle ragioni non stereotipabili del proprio prossimo. Il lontano-diverso è giustificato per default, il prossimo (compatriota, concittadino, ecc.) risulta sempre più incomprensibile. Invece dell’“amore del prossimo” qui ritroviamo una sorta di amore astratto e fantasticato per il remoto, e al contempo una crescente incomprensione del prossimo.
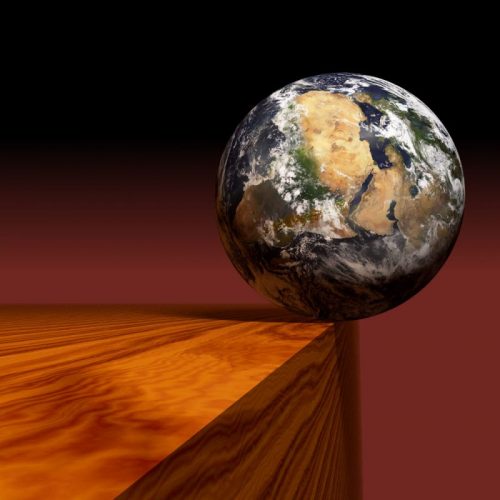
Spesso si dimentica che tollerare non significa accettare, ma sopportare. Sopporto, ovvero tollero, qualcosa che reputo falso o ingiusto per evitare conseguenze che reputo peggiori del falso o del male sopportato. Qui la radice dell’intolleranza della tolleranza.
Peraltro, alla base della tolleranza c’è un principio corretto: l’uomo non è l’errore, ne è solo il portatore. Dunque può ravvedersi. Tollero l’errante in quanto possibile portatore di verità. Per questo non lo elimino. È che spesso ci si dimentica di questo a favore del tutto va bene, tutto è giusto.
Ho trovato quest’intervento molto convincente. E forse anche perché vi ho ritrovato tracce di un percorso che, pur da altri punti di vista, sto da molto tempo provando a seguire, prendendo le mosse dai modelli della psicoanalisi delle relazioni oggettuali. Qui la paradossale identificazione nella psiche del soggetto del mimetismo e della scissione emerge con chiarezza estrema; spesso, nelle regressioni disfunzionali, con forza traumatica e destabilizzante.
Vorrei aggiungere solo un’ulteriore annotazione per arricchire il confronto, perché ciò che personalmente m’interessa di più è ricondurre le forme dialettiche come quelle esposte nell’intervento alle strutture radicali della nostra sensibilità. Mi sembra suggestivo, in questa chiave, che le “crisi di rigetto” inscritte nel tipo di tolleranza e di apertura che l’Autore definisce indifferenziate – e io “mimetiche” o “metonimiche” – conducano a un oscuramento dei sensi più distali e “metaforici”, e a una riemergenza di quelli situazionali e scarsamente metaforizzabili: tatto, gusto, olfatto. Allora l’Altro, esattamente come l’oggetto parziale persecutorio, è avvertito di volta in volta come invadente e inopportuno, disgustoso, maleodorante, avvelenatore, sabotatore, e così paradossalmente respinto tanto più, quanto più è (stato) avvicinato. Alla dialettica complessa di assimilazione e ripresa propria della metafora visiva e uditiva sembrano allora opporsi, come estremo esito sensibile di uno dei due modelli culturali presentati nell’intervento, le disfunzioni tipiche dei mimetismi e delle metonimie cieche.
Molto interessante l’articolo e stimolante la linea di ricerca proposta da Michele Gardini